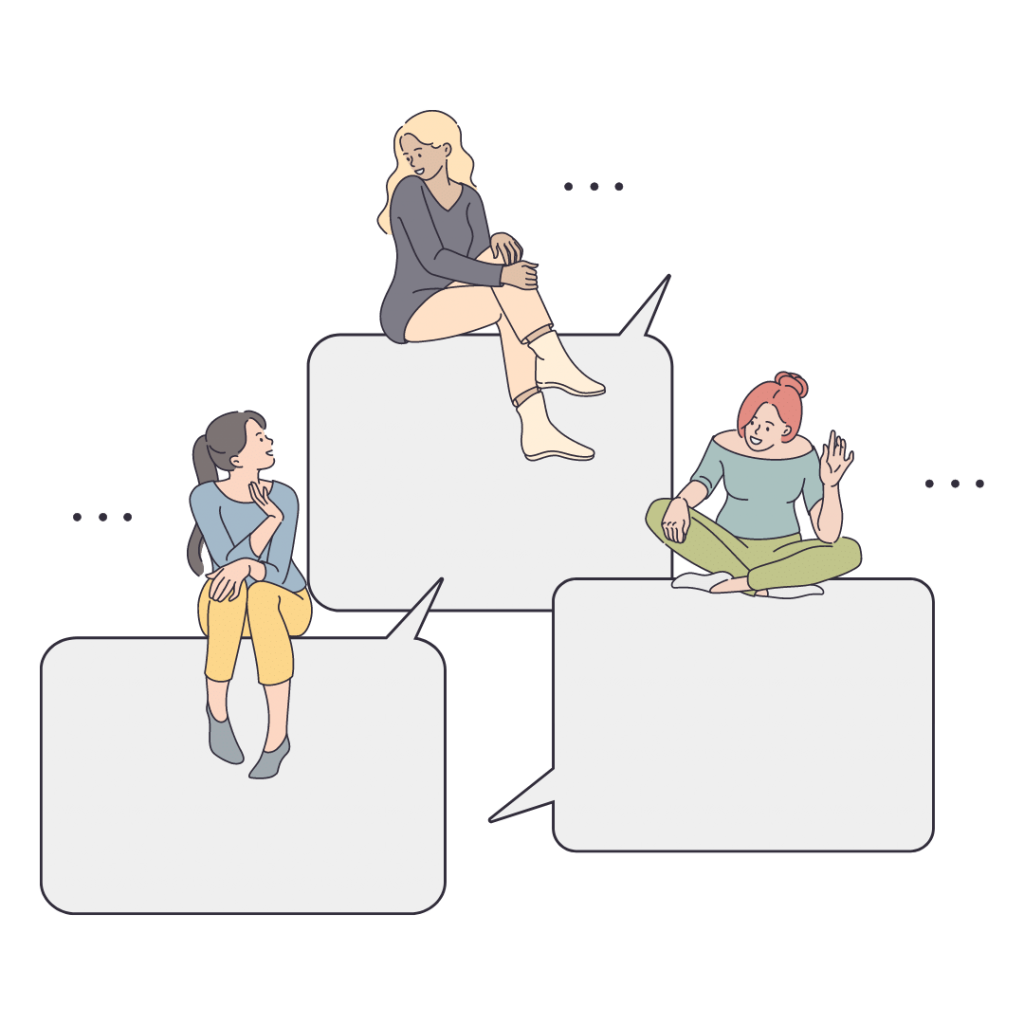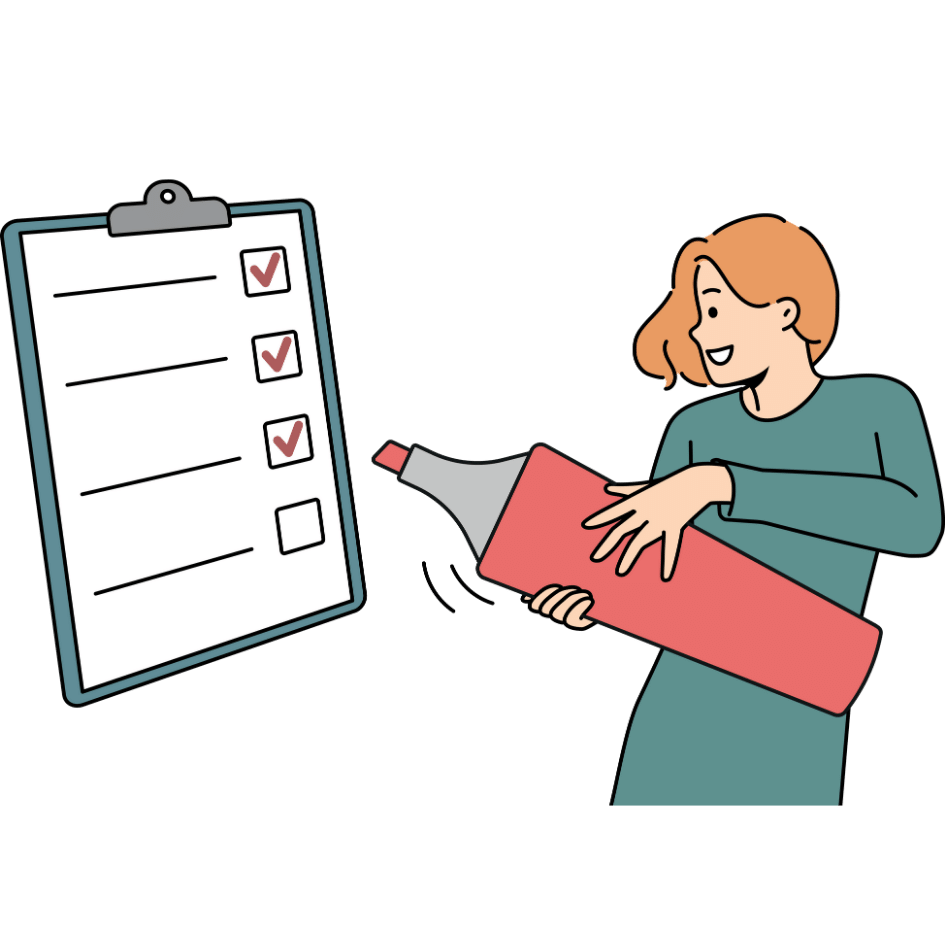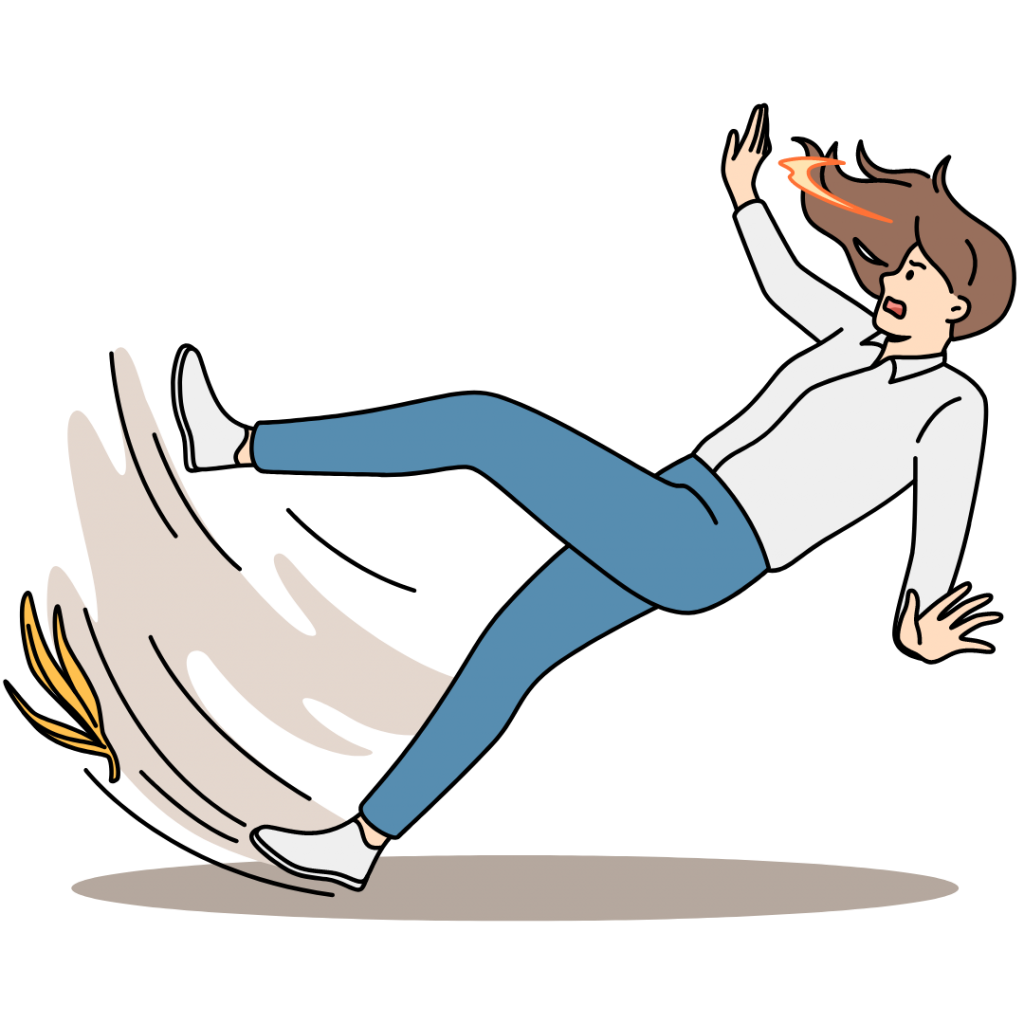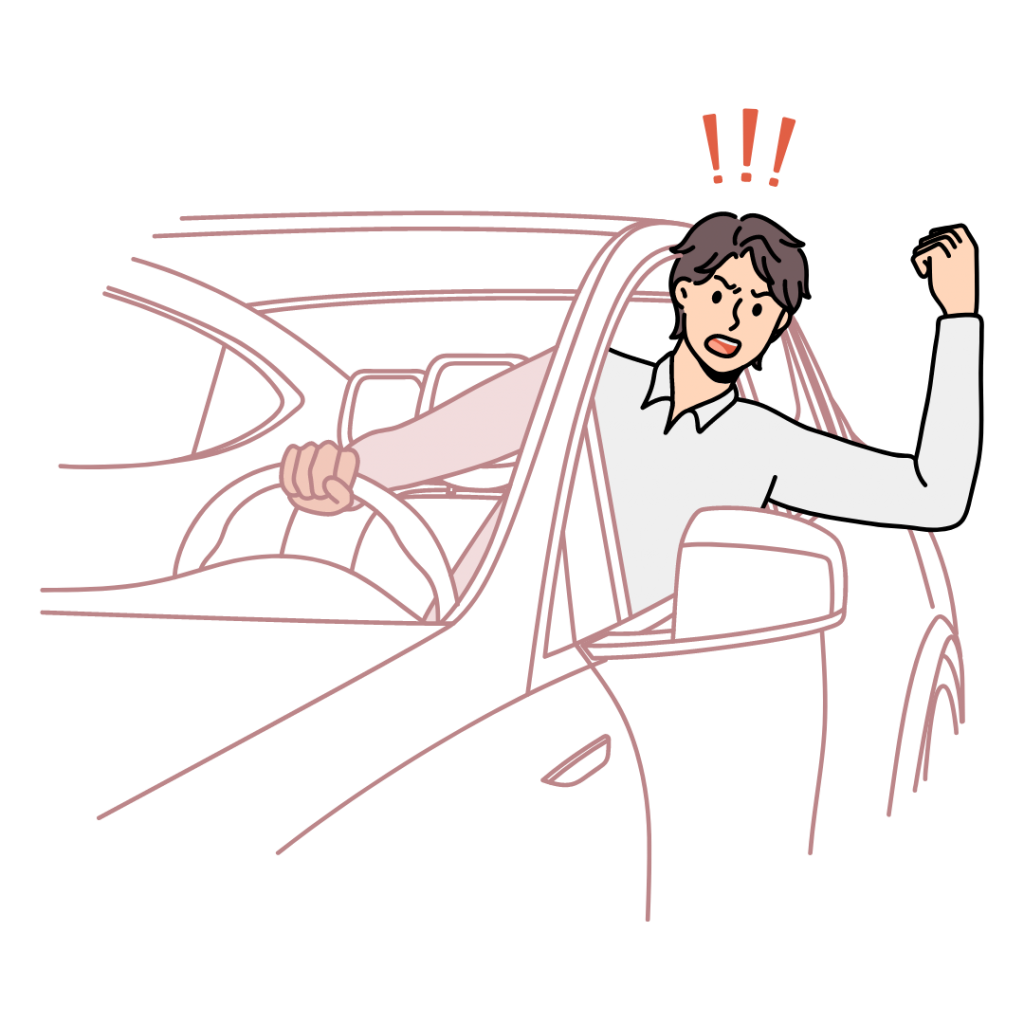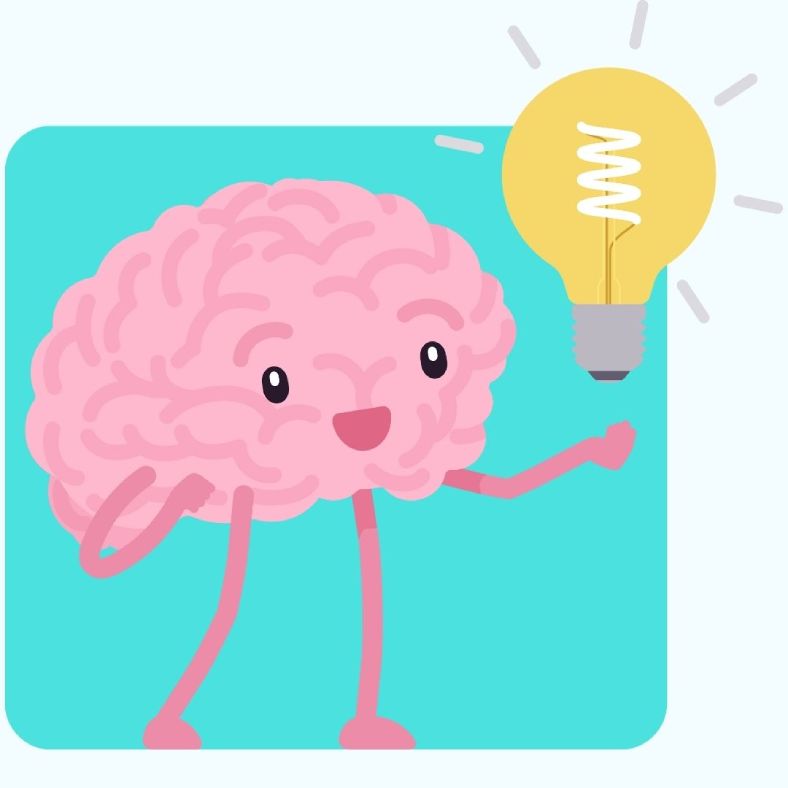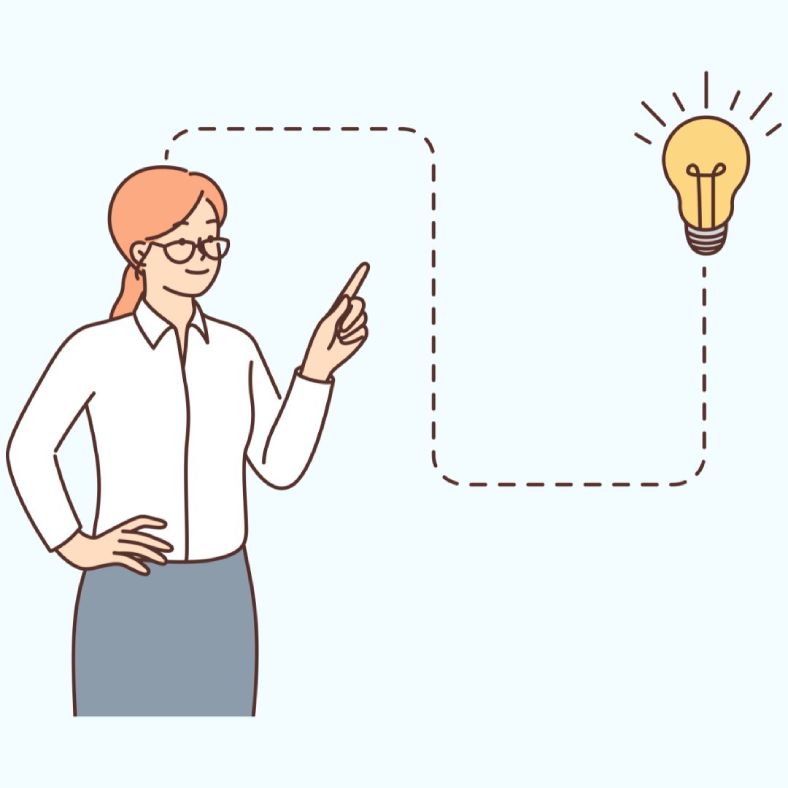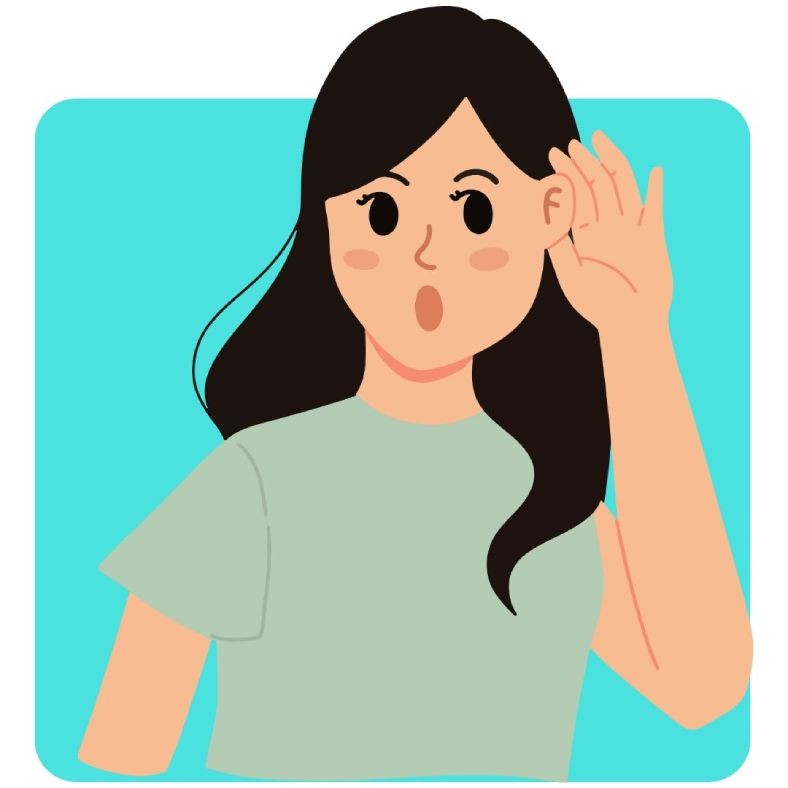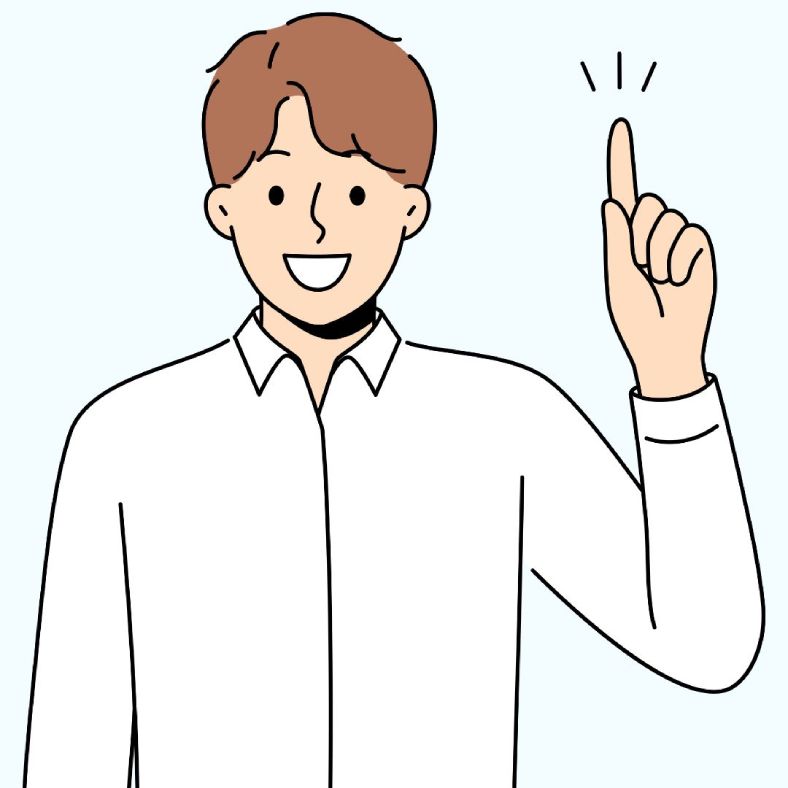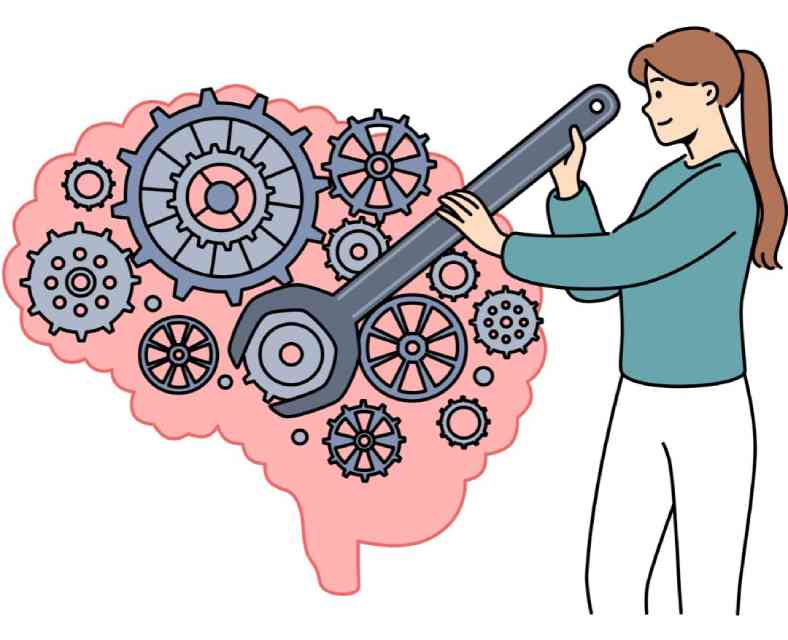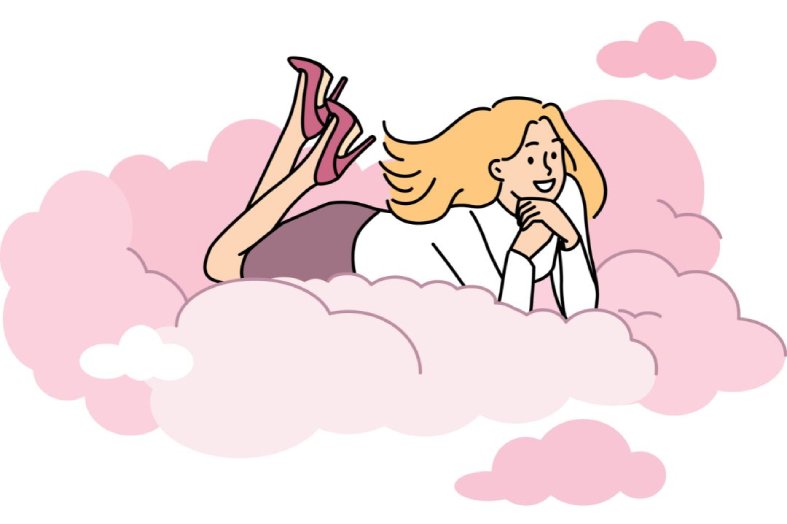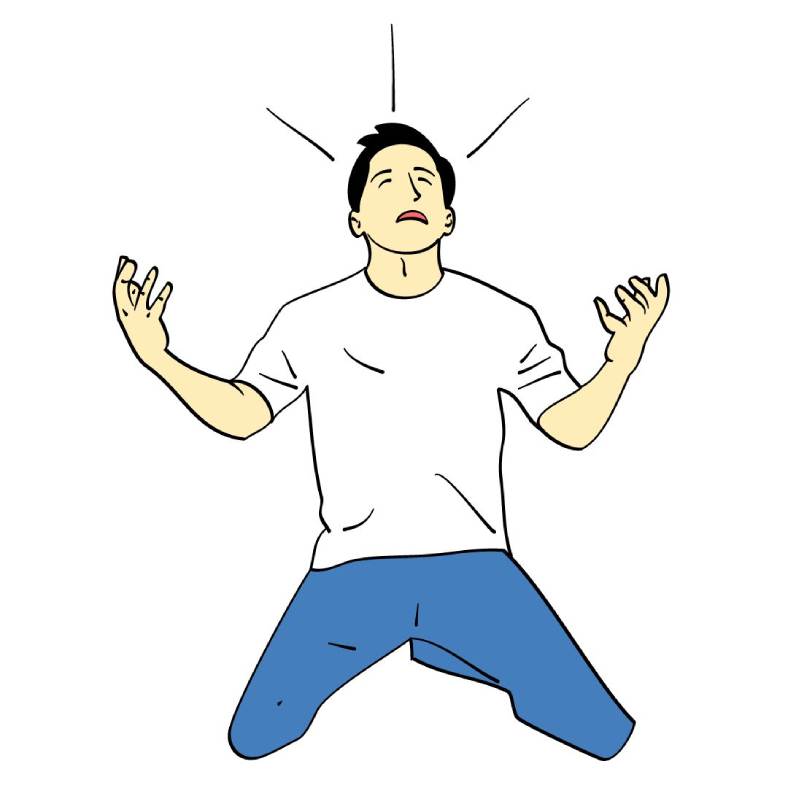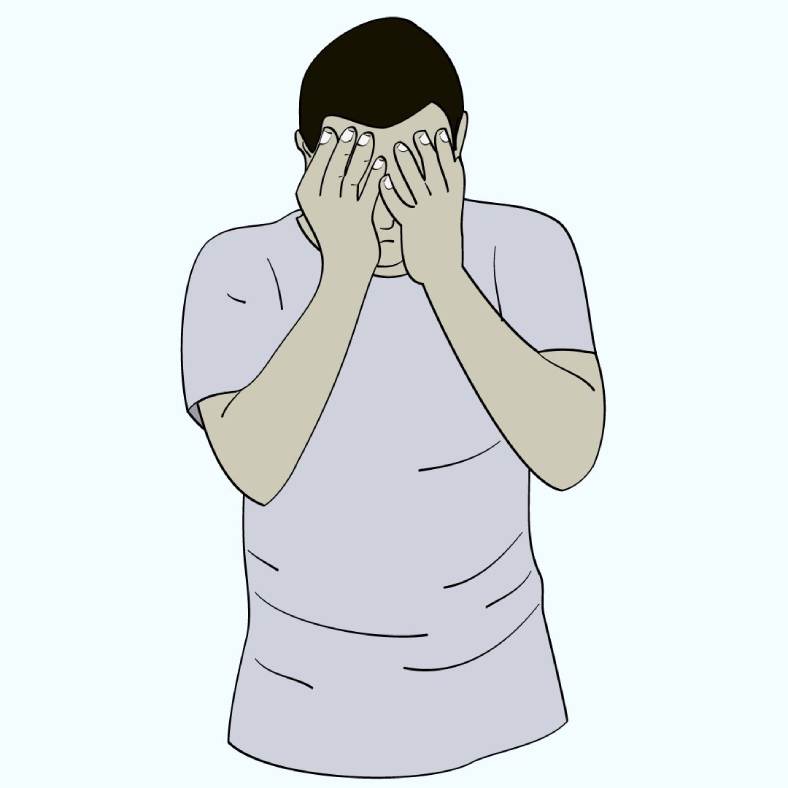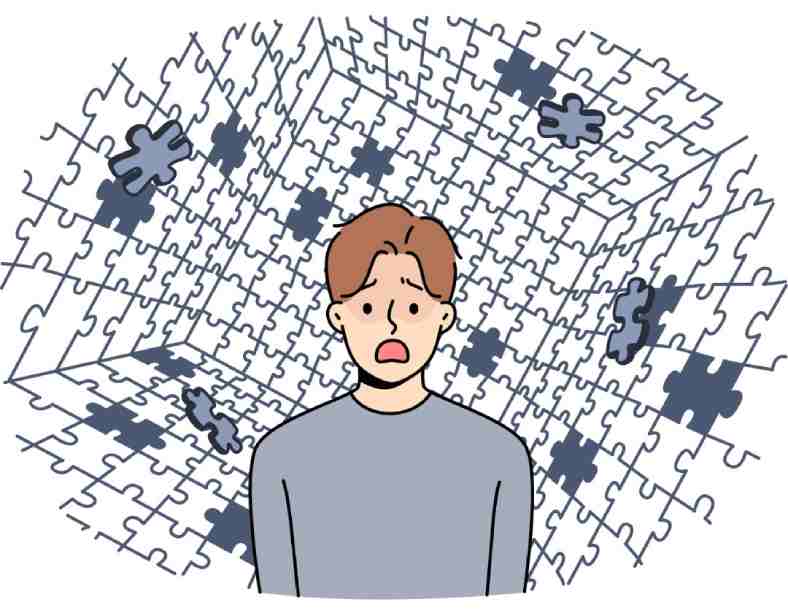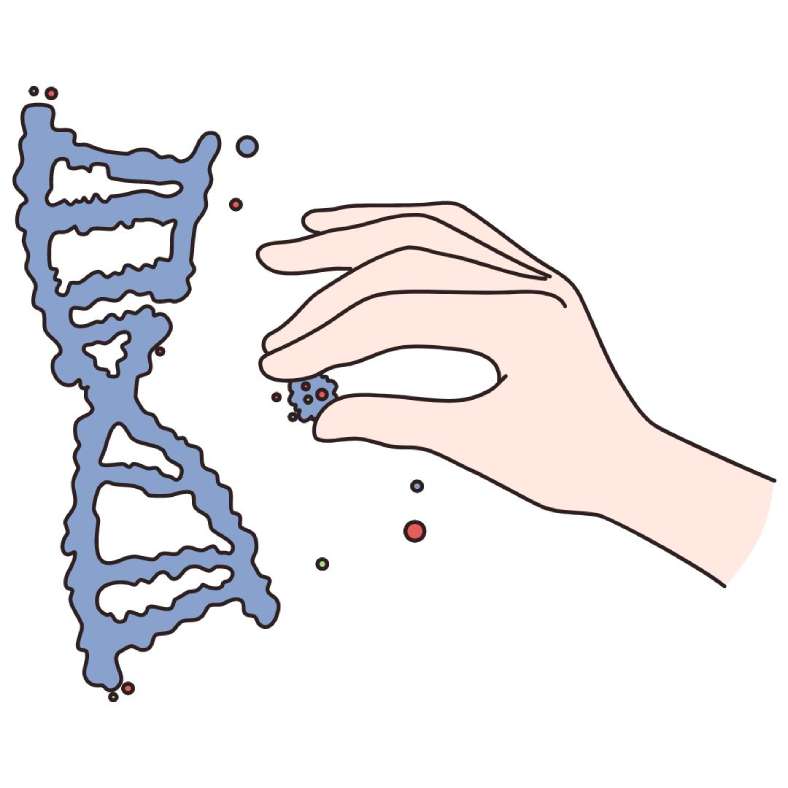Quando si parla di ADHD, ci si scontra fin da subito con una questione tanto sottile quanto centrale: le parole che usiamo per descriverlo.
Perché se da un lato l’etichetta diagnostica ufficiale ci parla chiaramente di un “disturbo”, dall’altro sempre più spesso, all’interno delle comunità di persone ADHD e tra molti divulgatori, si preferisce parlare di neurodivergenza.
Questa differenza terminologica non è casuale. Anzi, apre un’intera riflessione sul significato stesso dell’ADHD: è davvero un disturbo? O è una delle tante espressioni possibili del funzionamento neurologico umano?
La comunità di persone ADHD, che negli ultimi anni ha sviluppato una crescente consapevolezza e un’identità condivisa, spesso rifiuta l’idea di “disturbo” in quanto stigmatizzante o riduttiva.
Allo stesso tempo, la parola “neurodivergenza” viene adottata per rivendicare un’altra narrativa: quella della differenza, non della disfunzione.
E allora, cosa significa davvero parlare di disturbo? E cosa comporta, invece, scegliere la parola neurodivergenza? Le due cose si escludono a vicenda o possono coesistere? Si può dire che l’ADHD è una neurodivergenza senza negare che, in certi contesti, possa essere anche disfunzionale o fonte di sofferenza? Oppure è necessario scegliere: o si sta nel campo clinico, o in quello identitario?
Partiamo da un punto fondamentale: il fatto che l’ADHD sia chiamato, sul piano clinico, “disturbo da deficit di attenzione e iperattività” non è casuale, né arbitrario.
È il nome contenuto nei principali sistemi diagnostici internazionali, come il DSM-5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), che lo colloca chiaramente all’interno della categoria dei disturbi del neurosviluppo, vale a dire una classificazione che raccoglie condizioni che emergono durante l’infanzia e che hanno a che fare con lo sviluppo neurologico atipico dell’individuo.
Un ragionamento molto simile si può fare anche per l’autismo: sul piano diagnostico si parla di Disturbo dello Spettro Autistico, ma le persone autistiche – e gran parte delle comunità che ruotano attorno all’autismo – rivendicano un’identità neurodivergente, non patologica.
Anche l’autismo, infatti, come l’ADHD, è inserito nel DSM-5 tra i disturbi del neurosviluppo, e anche in questo caso si oscilla tra il dire “una persona ha un disturbo” e “una persona è autistica”.
In questo senso, la parola “disturbo” viene utilizzata in modo tecnico, con l’intento di descrivere un insieme di caratteristiche che possono interferire significativamente con il funzionamento adattivo della persona in contesti quotidiani: scuola, lavoro, relazioni, organizzazione personale.
Dunque, in ambito clinico, parlare di disturbo è utile – se non addirittura necessario – perché consente di riconoscere delle difficoltà, accedere a una diagnosi, attivare dei percorsi terapeutici o riabilitativi, ottenere supporto scolastico o lavorativo, e in molti casi anche tutele legali o sociali.
Psicologi, psichiatri, neuropsichiatri e psicoterapeuti utilizzano questa cornice concettuale non per stigmatizzare, ma per intervenire: il disturbo, in questa prospettiva, è ciò che crea sofferenza o ostacola il benessere. E l’obiettivo non è “correggere” la persona, ma aiutarla a vivere meglio in un mondo che spesso non è costruito su misura per il suo modo di funzionare.
Ma qui si apre un’altra riflessione: chi stabilisce cosa sia un ostacolo? chi decide se una caratteristica neurologica sia un “disturbo” o semplicemente una “variante”?
È qui che entra in gioco il concetto di neurodivergenza, una lente alternativa – non clinica, ma sociale e culturale – che propone di vedere l’ADHD come una forma naturale e legittima della diversità neurologica umana.
La neurodivergenza non nega che l’ADHD possa comportare difficoltà; piuttosto, sostiene che molte di queste difficoltà emergono solo perché la società è progettata per persone neurotipiche.
In altri termini: non sei tu ad essere “sbagliato”, è il contesto a non essere pensato per te.
Questa distinzione tra disturbo e neurodivergenza si riflette anche, in modo sottile ma profondissimo, nel linguaggio quotidiano che usiamo per parlare dell’ADHD.
Quando lo chiamiamo disturbo, tendenzialmente diciamo che una persona ha l’ADHD – come se si trattasse di qualcosa che si possiede, che si porta addosso, quasi fosse un oggetto esterno alla persona, un’etichetta che può essere tolta, curata o gestita.
Quando invece parliamo di neurodivergenza, la tendenza è a dire che una persona è ADHD – perché la neurodivergenza è vissuta come parte integrante della propria identità, come un modo di essere e di percepire il mondo, non qualcosa di separato o accidentale.
- “Avere l’ADHD” implica una visione più medica, più clinica, più centrata sul problema da affrontare.
- “Essere ADHD” apre invece a una dimensione identitaria, esistenziale, a un modo diverso – e non meno valido – di stare al mondo.
Entrambi gli approcci hanno senso, ma non sono neutri: le parole che usiamo modellano il modo in cui vediamo noi stessi e il modo in cui gli altri ci vedono.
Parlare di neurodivergenza significa dunque spostare il focus dall’individuo al sistema: significa guardare meno al sintomo e più all’ambiente.
Significa promuovere un cambiamento culturale, una maggiore inclusività, un linguaggio che non patologizza ma valorizza la differenza.
In questo senso, il termine “neurodivergenza” è carico di significati politici, identitari e relazionali: è un modo per dire “io sono fatto così”, “fa parte della mia identità”.
E allora, forse il punto centrale è proprio questo: le due prospettive non sono mutualmente escludenti.
Non si tratta di scegliere tra disturbo o neurodivergenza, ma di riconoscere che entrambe le parole possono coesistere, a seconda del contesto, del punto di vista, dell’esperienza soggettiva della persona che vive l’ADHD.
Una diagnosi clinica può coesistere con un’identità neurodivergente. Un bisogno di supporto terapeutico può convivere con una richiesta di riconoscimento sociale. Una narrazione funzionale in ambito medico può essere diversa da quella funzionale in ambito scolastico, lavorativo o familiare.
Anche il DSM, pur nel suo impianto diagnostico e clinico, secondo alcuni patologizzante ed etichettante, ci offre una traccia interessante: inserendo l’ADHD nella categoria dei disturbi del neurosviluppo, riconosce implicitamente che si tratta di una condizione legata a un funzionamento neurologico diverso, e non semplicemente di un “malfunzionamento”.
Una divergenza, appunto, che può avere origini eterogenee – genetiche, ambientali, evolutive – e che si manifesta in modi molto variabili da persona a persona.
Tutto, dunque, dipende da come decidiamo di raccontare la condizione.
E come dicevamo, il modo in cui raccontiamo una condizione determina anche come viene capita, vissuta e trattata da chi ci sta intorno.
Se la raccontiamo solo come disturbo, rischiamo di rinforzare la medicalizzazione e lo stigma. Se la raccontiamo solo come neurodivergenza, rischiamo di negare il bisogno di cura o di sottovalutare le difficoltà vissute da chi ha l’ADHD.