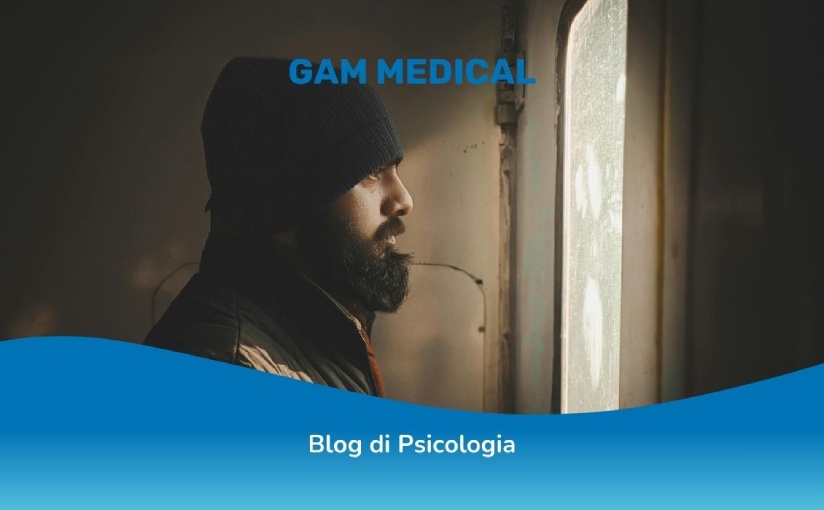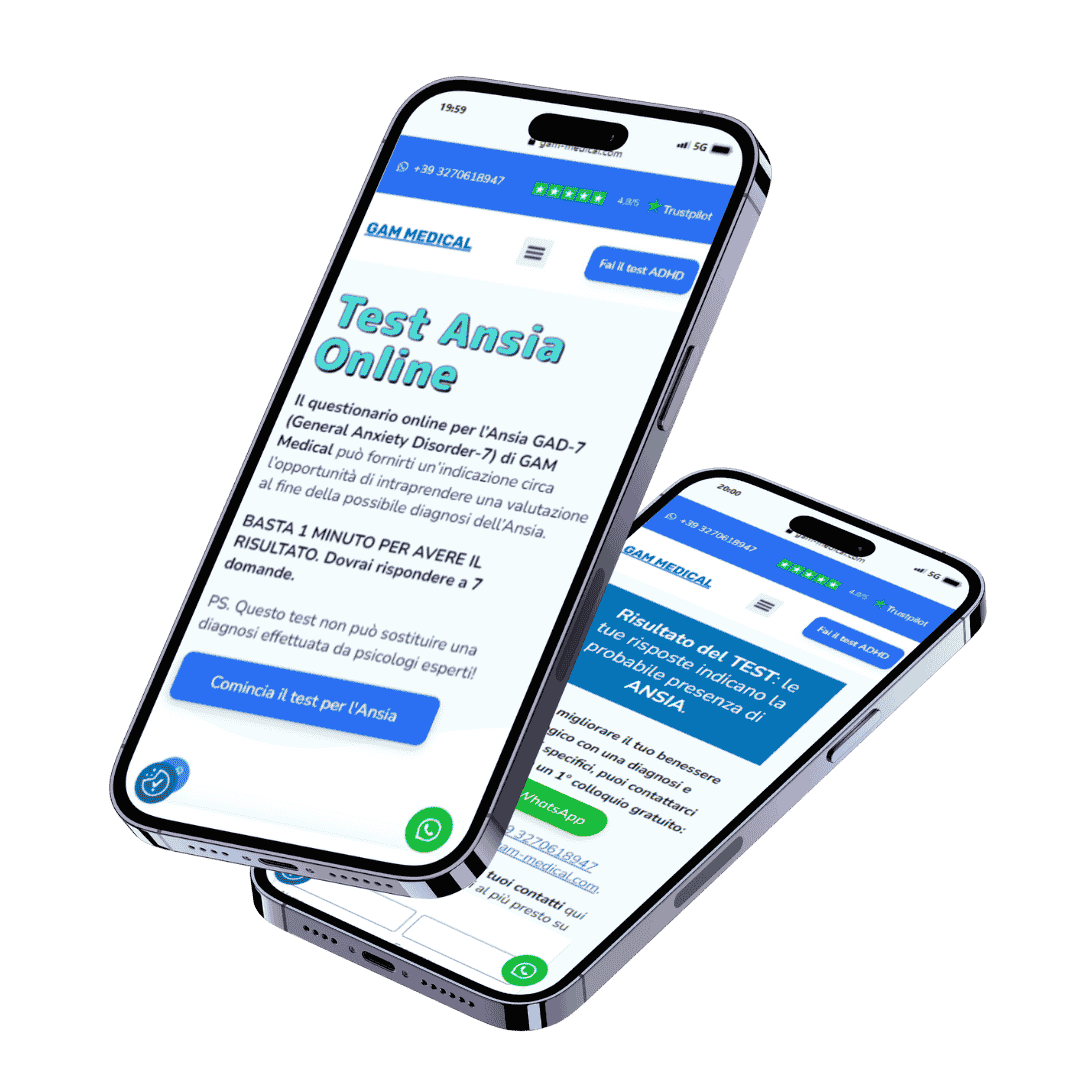Sapevi che anche i traumi possono essere ereditari?
Per molto tempo si è creduto che il trauma psicologico appartenesse esclusivamente all’esperienza soggettiva dell’individuo, confinato alla sua mente e alla sua biografia: ma non è così.
Per un certo periodo, ha fatto il giro dei social un video semplice ma potentissimo che spiegava in modo visivo la trasmissione intergenerazionale del trauma. Nessun linguaggio tecnico, nessuna definizione complicata. Solo un gesto, un’immagine, un simbolo.
Immagina di avere davanti a te un bicchiere trasparente, colmo d’acqua limpida.
A un certo punto, ci versi dentro del caffè: nero, intenso, denso. In un attimo, l’acqua diventa marrone. Non è più trasparente. Quel caffè è il trauma. Un dolore vissuto, un evento che ha segnato, una ferita profonda – che sia una guerra, una perdita, un abuso, una delusione schiacciante, o anche solo anni di silenzio e mancanza d’amore.
Quel bicchiere ora rappresenta il genitore. Porta dentro di sé quell’acqua scura, quella memoria emotiva mescolata alla sua vita. E quando arriva un figlio, arriva un secondo bicchiere.
Ma attenzione: questo secondo bicchiere non è vuoto. Anche lui ha la sua acqua, fatta di potenzialità, esperienze, carattere, contesto. È un’acqua nuova, fresca, ma ancora fragile.
Ora accade il gesto che cambia tutto: il genitore versa qualcosa del suo nel bicchiere del figlio. Lo fa senza malizia, senza voler fare del male. Lo fa perché è inevitabile. Perché chi ha dentro di sé acqua scura, non può versare solo trasparenza.
E così, l’acqua del secondo bicchiere si tinge. Un po’. Non è più limpida. Non è nera come quella del primo, ma porta dentro di sé una traccia: un’ombra, una nota di amarezza, una tinta che non era sua.
Quel secondo bicchiere diventa a sua volta un genitore. E quando tocca a lui versare qualcosa nel terzo bicchiere – il proprio figlio – accade la stessa cosa. E poi ancora. E ancora.
A ogni passaggio, l’acqua si fa un po’ più chiara. Il colore si diluisce, ma non torna mai trasparente del tutto. Perché anche se non si tramanda l’intero trauma, si tramandano le sue conseguenze: il modo in cui si reagisce al dolore, le paure non dette, la fatica a fidarsi, il bisogno di controllo, il silenzio emotivo, l’ansia immotivata.
Ed è proprio così che funziona la trasmissione del trauma tra generazioni. Non è sempre un racconto esplicito. Non è un’eredità fatta di parole. È qualcosa che si insinua nei gesti, nelle paure, nelle emozioni che non capiamo bene da dove vengano.
Nelle prossime righe capiremo come funziona il processo della trasmissione intergenerazionale del trauma esplorandole due principali modalità: epigenetica e comportamentale.
Come si Tramanda un Trauma? Due Modalità Principali
Negli ultimi decenni, la ricerca scientifica ha messo in luce una verità sorprendente e inquietante: il trauma può lasciare tracce non solo nella psiche, ma anche nel corpo – e addirittura essere trasmesso biologicamente da una generazione all’altra.
Questa nuova frontiera della psicotraumatologia prende il nome di PTSD epigenetico o trauma transgenerazionale, e descrive un fenomeno in cui gli effetti di un trauma vissuto da un individuo possono manifestarsi anche nei suoi discendenti, pur in assenza di un’esperienza traumatica diretta da parte di questi ultimi.
Numerosi studi condotti su animali da laboratorio hanno dimostrato che il trauma può alterare l’espressione genica in modi trasmissibili. Ad esempio, ratti esposti a stress gravi producono cuccioli con maggiore reattività allo stress, anche se allevati in ambienti neutri.
Oltre alla dimensione biologica, il PTSD transgenerazionale ha una forte componente psicologica e culturale. I traumi non elaborati dalle generazioni precedenti possono essere “ereditati” sotto forma di silenzi, narrazioni spezzate, dinamiche familiari disfunzionali, oppure ripetizione simbolica degli stessi eventi.
In questo senso, il trauma diventa una memoria incarnata, che si tramanda non solo tramite geni, ma anche attraverso relazioni, valori, paure e atteggiamenti inconsci.
Queste due modalità hanno un nome specifico: una è la modalità epigenetica e l’altra la modalità comportamentale.
In particolare:
- Modalità Epigenetica: il Trauma Cambia il Corpo e i Geni: l’epigenetica è il campo della biologia che studia come i geni vengono “accesi” o “spenti” in risposta all’ambiente. I traumi – anche quelli emotivi – possono causare alterazioni nel funzionamento dei geni, senza cambiare il DNA stesso. Questi cambiamenti epigenetici regolano il modo in cui il corpo risponde allo stress, produce ormoni, gestisce le emozioni e si difende da situazioni percepite come minacciose.
- Come funziona?
- Quando una persona vive un trauma, il suo corpo produce alti livelli di cortisolo e altre sostanze legate allo stress. Questo può “modificare” l’attività dei geni coinvolti nella regolazione emotiva. Queste modifiche possono essere trasmesse ai figli attraverso ovuli o spermatozoi. Il risultato? Bambini che nascono più sensibili allo stress, con un sistema nervoso iperreattivo, anche se crescono in un ambiente sereno.
- Esempi noti:
- Esempio: Discendenti di sopravvissuti all’Olocausto: hanno spesso una percezione del mondo come ostile o pericoloso. Tendono a essere ipercontrollati, ansiosi, oppure a evitare il dolore emotivo. Possono ricevere narrazioni frammentarie, silenzi o atmosfere familiari di “lutto non detto”.
- Esempio: Figli di immigrati di prima generazione: possono interiorizzare la fatica, il sacrificio e l’ansia dei genitori nel cercare di integrarsi. In molti casi sviluppano un senso di dovere, colpa o bisogno di riscatto che non è “loro”. Possono oscillare tra due identità culturali, sentendosi “fuori posto” in entrambe.
- Esempio: Popolazioni indigene o colonizzate: Trasmettono nei figli un vissuto di perdita, sradicamento, vergogna o inferiorità culturale. Anche la lingua e i valori tradizionali, se soppressi, possono essere vissuti come ferite aperte.
- Come funziona?
- Modalità Comportamentale: i Traumi Influenzano Come Educhiamo i Figli: anche senza modifiche genetiche, i traumi possono essere trasmessi attraverso il modo in cui viviamo, pensiamo, ci relazioniamo e cresciamo i nostri figli. Se una persona ha vissuto abbandoni, rifiuti, violenze o trascuratezza, è probabile che – anche involontariamente – sviluppi schemi relazionali rigidi, ansiosi o iperprotettivi.
- Come funziona?
- I traumi irrisolti si riflettono in comportamenti di evitamento, sfiducia, silenzio emotivo o ipercontrollo. Un genitore che ha vissuto un trauma può essere iperallertato, ansioso o distante, trasmettendo al figlio la sensazione che il mondo sia pericoloso o che le emozioni non siano benvenute. I bambini imparano da ciò che vedono e sentono: assorbono modelli affettivi, anche se non c’è mai stato un racconto esplicito del trauma.
- Esempi comuni:
- Esempio: Violenza domestica o genitori abusanti: un figlio che ha visto la madre subire violenze, anche senza subirle direttamente, può sviluppare paure profonde verso l’intimità o un forte senso di impotenza. A sua volta, da adulto può trasmettere ai propri figli modelli basati sulla paura, sulla sfiducia, sull’ipercontrollo o sull’assenza emotiva.
- Esempio: Abbandono o perdita di un genitore in giovane età: anche se il dolore non viene verbalizzato, può condizionare il modo in cui si vive l’attaccamento. Il trauma si può trasmettere come ansia da separazione nei figli, oppure come distanza emotiva per paura di perdere chi si ama.
- Esempio: Tossicodipendenza o malattia mentale grave in famiglia: i figli imparano presto a “monitorare” gli stati d’animo degli adulti, diventando iperresponsabili o ipervigilanti. Possono sviluppare uno stile genitoriale rigido o caotico, trasmettendo tensione cronica anche in assenza di un trauma diretto.
- Come funziona?
Siamo partiti da una metafora semplice – quella del bicchiere d’acqua e del caffè – perché ci è sembrata un’immagine potente e accessibile. Sui social ha avuto grande risonanza proprio per questo: in modo intuitivo e visivo, mostra come il trauma possa trasmettersi da una generazione all’altra, senza bisogno di parole complesse.
È un punto di partenza utile. Rende visibile l’invisibile. Ci aiuta a capire che molti vissuti emotivi non nascono da “noi”, ma ci abitano da prima, tramandati attraverso ciò che ci è stato detto, fatto, non detto o mancato.
Ma è fondamentale ricordare che questa non è una condanna scritta nel destino.
Perché lo sviluppo di un individuo non dipende solo dai fattori di rischio, ma anche dai fattori di protezione. E questi sono tanti: una relazione significativa, un’educazione consapevole, un percorso terapeutico, un ambiente sicuro, un talento, una comunità, un atto di cura.
Non ereditiamo solo il dolore. Ereditiamo anche risorse, capacità, resilienze. E soprattutto, abbiamo la possibilità di scegliere come agire, come prenderci cura di ciò che ci è stato affidato, come interrompere o trasformare ciò che non vogliamo più trasmettere.
Sicuramente una buona psicoterapia è quello che aggiunge acqua trasparente all’acqua già scura. Non cancella il passato, non svuota il bicchiere, ma goccia dopo goccia aiuta a chiarire, a rendere più limpido quello che ci portiamo dentro.
È come se, finalmente, qualcuno ci aiutasse a capire perché quell’acqua non è del tutto chiara, da dove viene quel colore, e ci dicesse: “Va bene così, ma possiamo fare qualcosa.”
E più se ne parla, più si lavora su di sé, più quell’acqua si schiarisce. Fino a quando, un giorno, ci accorgiamo che possiamo smettere di versare acqua torbida nei bicchieri degli altri. Possiamo trasmettere qualcosa di più leggero, più pulito.
Per questo la psicoterapia non è solo cura per noi stessi, ma anche un gesto di responsabilità verso chi verrà dopo. Un modo per dire: “Finisce con me.”