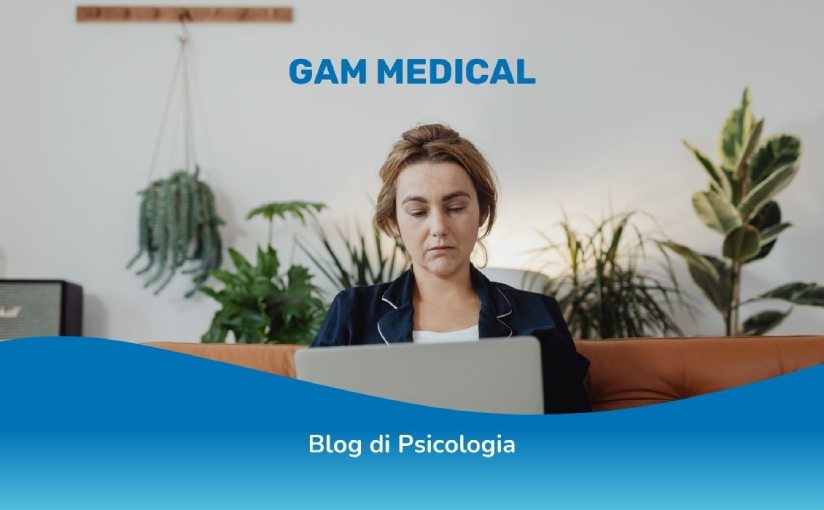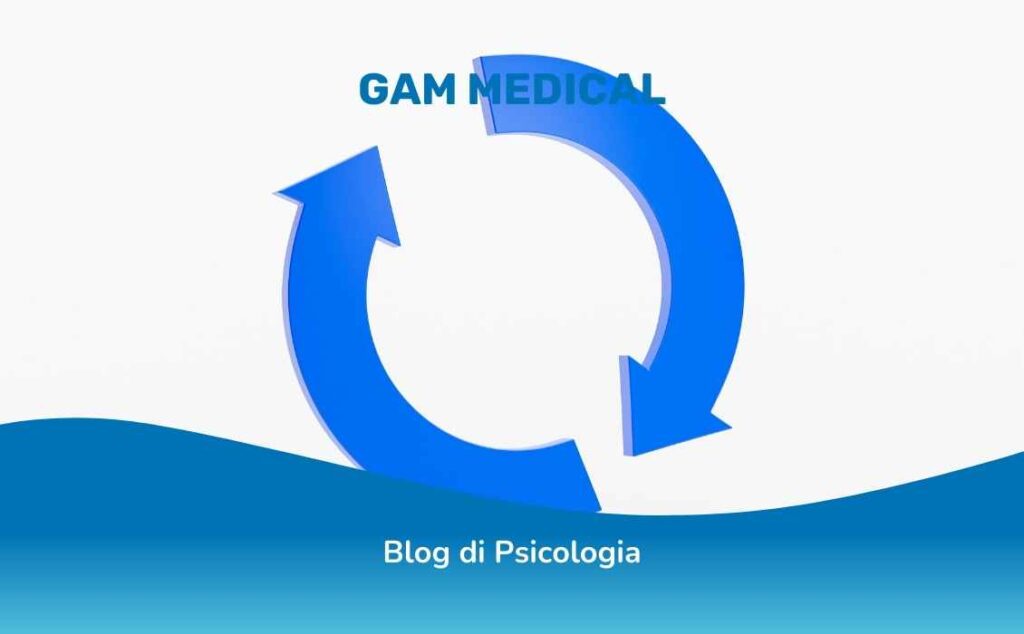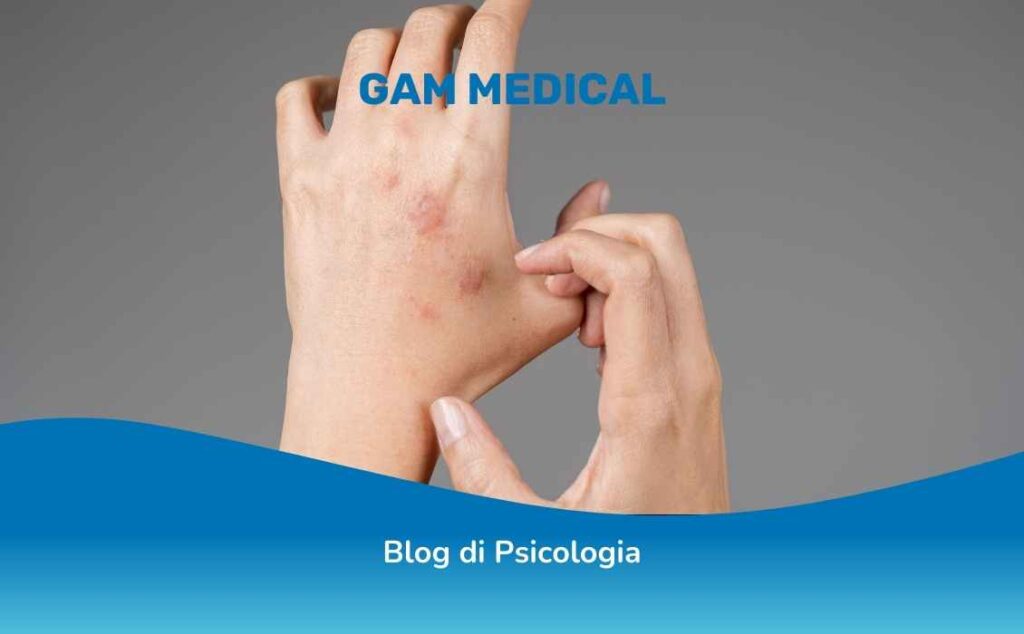Sapevi che molte persone autistiche sono affascinate e attratte nel guardarsi allo specchio? La relazione tra autismo e guardarsi allo specchio è molto interessante e cercheremo di dargli spazio nelle prossime righe, nelle quali affronteremo:
- cosa significa guardarsi allo specchio;
- sviluppo del riconoscimento dello specchio (tipico e atipico)
- perché molte persone autistiche, sia da bambine che da adulte, si guardano spesso allo specchio
Cosa significa guardarsi allo specchio?
Guardarsi allo specchio non è un gesto neutro.
È un atto psicologico, un incontro con sé stessi mediato da un’immagine, da una distanza, da un rimando. Lo specchio rimanda qualcosa che è nostro, ma non coincide esattamente con noi: è una copia perfetta, ma priva di vissuto, di intenzione, di interiorità.
Per molti bambini piccoli, ad esempio, lo specchio rappresenta inizialmente un “altro bambino” con cui interagire. Solo più tardi comprenderanno che quell’immagine è loro.
Da un punto di vista clinico, lo specchio mette in gioco almeno tre dimensioni:
- La dimensione corporea, cioè il riconoscimento dei propri confini e della propria postura.
- La dimensione concettuale, il sapere che “quello sono io”, con tutte le implicazioni linguistiche e cognitive del caso.
- La dimensione interpersonale, ovvero il modo in cui l’immagine riflessa richiama un senso di sé in relazione agli altri: come mi guardo? come mi sento guardato? come appaio?
Nelle persone che rientrano nello spettro autistico questi livelli non sempre funzionano in sincronia. Alcuni aspetti possono essere molto avanzati, altri possono essere confusi, fragili o fonte di sovraccarico. Comprendere il rapporto con lo specchio richiede proprio questa lettura sfumata.
Lo sviluppo del riconoscimento allo specchio nei bambini nello sviluppo tipico (neurotipicità) o atipico (autismo o altre condizioni)
Nei primi mesi di vita, lo specchio è per i bambini una presenza interessante ma poco comprensibile. Sorridono alla loro immagine come farebbero con un adulto, tendono la mano per toccare ciò che vedono, cercano il gioco della reciprocità. Non si pongono la domanda: “Sono io?”. Semplicemente reagiscono a un volto.
Intorno all’anno, i bambini cominciano a mostrare comportamenti più complessi: osservano le espressioni, cercano di capire la provenienza dei movimenti, cercano dietro lo specchio come per scoprire cosa stia accadendo. È un periodo ricco di domande implicite, anche se non ancora concettualizzabile.
Il famoso test della macchia – applicare un segno colorato sulla fronte del bambino e osservare se, guardandosi allo specchio, porta la mano alla sua fronte – indica la comparsa del riconoscimento di sé. Quando il bambino si tocca, significa che ha capito: l’immagine riflessa lo rappresenta. Non è un passaggio netto, ma un graduale emergere di consapevolezza.
Questo test è importante, ma non esaurisce affatto il senso di sé. Molti bambini possono riconoscersi allo specchio e tuttavia avere ancora difficoltà nel vivere le proprie emozioni, nel sentirsi interi, nel percepirsi come soggetti che esistono anche nella mente dell’altro. Il senso di sé è un processo complesso che si costruisce per anni.
Lo studio “Engaging with the self: Mirror behaviour in autism, Down syndrome and typical development” ha esplorato il comportamento allo specchio di bambini con sviluppo tipico e atipico proprio per indagarne eventuali differenze.
Gli autori hanno osservato il comportamento allo specchio di tre gruppi di bambini:
- 12 bambini in età prescolare con autismo,
- 13 bambini con sindrome di Down,
- 13 bambini con sviluppo tipico.
La ricerca ha mostrato un risultato importante: i bambini con autismo raggiungono un auto-riconoscimento allo specchio adeguato all’età evolutiva, quindi sanno perfettamente che l’immagine riflessa è la loro. Tuttavia, presentano differenze in altri aspetti del senso di sé, soprattutto nella componente interpersonale ed emotiva.
In particolare, lo studio ha evidenziato:
- minori azioni di riflessione sociale;
- meno comportamenti affettivi positivi verso la propria immagine;
- assenza o riduzione dei “sorrisi timidi” o modulati;
- minore orientamento relazionale durante l’osservazione;
- maggiore distanza emotiva.
Lo specchio come calamita sensoriale: quando guardarsi diventa un’autostimolazione autistica
Nella pratica clinica con adulti autistici e con genitori di bambini autistici emerge con grande frequenza un fenomeno che vale la pena nominare con chiarezza: lo specchio che affascina e attrae.
Molte persone autistiche, soprattutto nell’infanzia ma anche da adulte, riferiscono che lo specchio esercita una forza di richiamo quasi automatica: è un’esperienza sensoriale e percettiva che stimola, calma, organizza, distrae, occupa.
Questa dinamica non è affatto rara: lo specchio diventa un oggetto di autostimolazione, un mezzo attraverso cui modulare il proprio stato interno.
Non è necessariamente un sintomo, né una “fissazione” patologica: spesso è una forma di regolazione, un modo per trovare un equilibrio sensoriale o emotivo.
Perché le persone autistiche sono affascinate dallo specchio?
Le ragioni sono molteplici, e non riducibili a una sola spiegazione:
- Piacere sensoriale: lo specchio restituisce un’immagine fluida, luminosa, che cambia a ogni movimento. Per un sistema sensoriale che ricerca pattern visivi, dettagli, simmetrie, micro-cambiamenti, può essere estremamente stimolante e gratificante.
- Prevedibilità del riflesso: lo specchio è prevedibile: risponde sempre nello stesso modo. A differenza del volto umano, che può confondere con micro-espressioni e ambiguità sociali, il proprio riflesso offre un feedback chiaro, immediato, non giudicante.
- Autoosservazione come regolazione: fare facce, muovere la bocca, inclinare la testa, osservare il modo in cui cambiano colore e intensità degli occhi: tutto questo può avere un effetto calmante, centrante, quasi meditativo.
- Sense-making del proprio corpo: per alcune persone autistiche lo specchio è un modo per “capire” il proprio corpo: osservarlo, verificarlo, confermare la sua presenza. La propriocezione interna può essere a volte confusa; il riflesso fornisce un’ancora esterna.
Il ruolo dello specchio negli adulti autistici
Per molte persone autistiche adulte il rapporto con lo specchio non è soltanto una forma di autostimolazione visiva, come spesso avviene anche nell’infanzia, quando il riflesso diventa una calamita che cattura l’attenzione per lunghi periodi, ma rappresenta anche un importante strumento di masking e di allenamento sociale.
Lo specchio offre un ambiente prevedibile e non giudicante che permette di osservare ogni dettaglio del volto e modulare consapevolmente la propria presenza sociale.
Molti adulti riferiscono di utilizzarlo per controllare e allenare aspetti come:
- il sorriso (quanto, come, quando mostrarlo),
- le espressioni del volto (per sembrare più tranquilli, interessati o disponibili),
- lo sguardo (durata, intensità, direzione),
- i movimenti della bocca durante il parlare,
- la postura e la “presentabilità” complessiva.
In questo senso, lo specchio diventa una sorta di palestra sociale privata, in cui è possibile provare saluti, frasi, toni di voce, atteggiamenti e micro-espressioni senza la pressione dell’interazione reale.
Per alcune persone questo uso ha una funzione rassicurante: riduce l’ansia anticipatoria e aiuta a sentirsi più preparati; per altre è un modo per ridurre il rischio di fraintendimenti e per rendere la propria comunicazione più leggibile da parte dei neurotipici.
È importante ricordare che questa pratica non è patologica, ma adattiva: uno strumento per gestire un mondo che richiede una grande quantità di segnali non verbali spontanei.
Così, nello stesso gesto, lo specchio può svolgere una doppia funzione: da un lato autostimolazione visiva piacevole; dall’altro autoaddestramento sociale, una forma di regolazione dell’immagine di sé che permette alla persona con disturbo dello spettro autistico di esplorare, controllare e rendere comunicabile il proprio volto secondo bisogni, tempi e modalità personali.