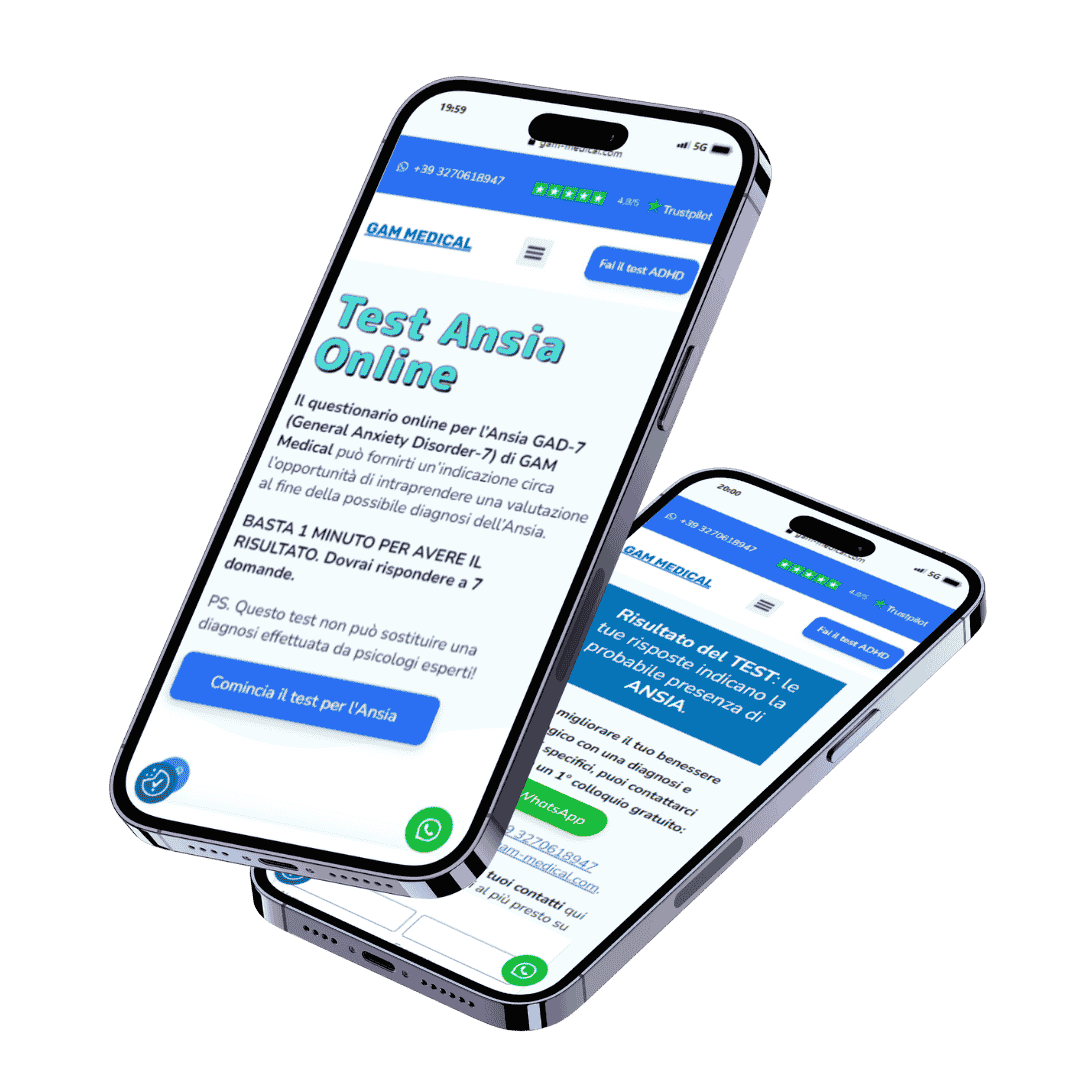I disturbi alimentari sono così difficili da trattare proprio perché sono egosintonici; questo significa, in parole semplici, che sono percepiti come parte del Sé, come qualcosa di coerente con l’identità della persona, non come un problema da cui liberarsi.
Quando un comportamento, un pensiero o un sintomo è egosintonico, la persona non lo vive come estraneo o disturbante, ma come un elemento che dà ordine, controllo o senso di sé.
Ecco perché, nei disturbi del comportamento alimentare, la resistenza alla cura non è solo paura del cambiamento: è il timore di perdere una parte di sé.
Cosa significa “egosintonico”?
In psicologia clinica, il termine egosintonico deriva da “ego” (Sé) e “sintonico” (in sintonia).
Si usa per descrivere comportamenti o pensieri che risultano coerenti con l’immagine che una persona ha di sé, con i suoi valori, desideri o obiettivi.
L’opposto è egodistonico: ciò che viene percepito come estraneo, dissonante o indesiderato.
- Un sintomo egodistonico provoca disagio: la persona riconosce che “qualcosa non va” e desidera cambiarlo.
- Un sintomo egosintonico, invece, viene giustificato, razionalizzato o addirittura difeso.
Ecco un esempio:
- Un paziente con disturbo ossessivo-compulsivo riconosce che i suoi rituali sono eccessivi e vorrebbe smettere → egodistonico.
- Una persona con anoressia può sentire il controllo del cibo come una virtù, non come una malattia → egosintonico.
Egosintonia e disturbi alimentari: una relazione profonda
Tra tutti i disturbi psichiatrici, i disturbi dell’alimentazione (DCA), come anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata, sono fra i più egosintonici, insieme a quelli di personalità.
La perdita di peso, il controllo calorico, la restrizione o il vomito autoindotto non vengono inizialmente vissuti come sintomi, ma come strategie funzionali: modi per sentirsi forti, disciplinati, “a posto”.
Questo legame identitario spiega perché la diagnosi di DCA non genera sempre sollievo, ma spesso angoscia o rabbia: perché implica la possibilità di dover rinunciare a ciò che, fino a quel momento, ha dato senso alla propria esistenza.
Perché l’egosintonia di un disturbo alimentare rende difficile la cura?
L’egosintonia è più di tutti l’aspetto che rende difficile l’uscita da un disturbo alimentare. Questo perché determina:
- Scarsa consapevolezza di malattia: quando un disturbo è egosintonico, la persona non riconosce il problema come tale. Nell’anoressia, la percezione corporea è alterata ma la convinzione di “stare bene così” è ferrea. L’obiettivo di “dimagrire ancora un po’” appare razionale, anche se i parametri medici indicano pericolo.
- Alta motivazione al mantenimento: molti comportamenti patologici vengono mantenuti perché producono rinforzi positivi immediati: senso di controllo, riduzione dell’ansia, autostima momentanea. Interromperli significherebbe affrontare il vuoto, la perdita di senso e la vulnerabilità emotiva.
- Difficoltà di alleanza terapeutica: il terapeuta, nei DCA, deve spesso confrontarsi con una parte del paziente che non vuole guarire. L’obiettivo terapeutico non è solo “mangiare di più” o “smettere di vomitare”, ma ridefinire la relazione con il Sé. La cura diventa un percorso di negoziazione continua tra la parte che vuole cambiare e quella che teme di farlo.
- Ambivalenza costante: l’egosintonia genera un paradosso: la persona soffre, ma allo stesso tempo difende la causa della propria sofferenza. Può chiedere aiuto e, il giorno dopo, rifiutare ogni intervento. Può sentirsi “meglio” quando perde peso, anche se fisicamente peggiora.
Egosintonia nell’anoressia
Tra i DCA, l’anoressia nervosa è la forma più fortemente egosintonica.
La restrizione alimentare viene vissuta come scelta morale, espressione di volontà, purezza e autocontrollo.
Molti pazienti riferiscono orgoglio per la propria forza: la fame diventa una vittoria, non un segnale di bisogno. Il peso che scende è una conferma di valore.
L’egosintonia qui è totale: la malattia non è percepita come tale, ma come virtù. Questo spiega perché, anche di fronte a rischi vitali, la motivazione alla cura può essere minima.
Solo quando il corpo crolla o le relazioni si sgretolano, può emergere un barlume di egodistonia: la consapevolezza che “qualcosa non torna”, che il controllo ha preso il sopravvento.
Egosintonia nella bulimia nervosa
La bulimia nervosa è spesso un disturbo misto: alterna fasi egosintoniche a momenti egodistonici.
Durante le abbuffate o le condotte di compenso (vomito, digiuno, esercizio eccessivo) la persona può sperimentare un senso di sollievo, potere o “reset”.
Subito dopo, però, arriva la vergogna, il disgusto, la colpa.
L’egosintonia nella bulimia è legata all’illusione di poter controllare ciò che è caotico.
Il vomito, ad esempio, viene razionalizzato come un modo per “rimediare”, “pulirsi”, “riprendere il controllo”.
In realtà, la persona resta intrappolata in un ciclo di auto-punizione.
La sfida terapeutica è aiutare il paziente a riconoscere il ciclo, non solo a interromperlo, e a comprendere che il controllo non coincide con il benessere.
Egosintonia nel binge eating
Nel disturbo da alimentazione incontrollata, l’egosintonia è più sfumata ma presente.
La persona può giustificare le abbuffate come “momenti di conforto” o “ricompense dopo lo stress”.
Anche qui il comportamento risponde a un bisogno autentico: regolare emozioni difficili.
La difficoltà sta nel riconoscere che quel comportamento, sebbene “coerente con sé”, non è funzionale al benessere.
La terapia deve aiutare a distinguere il bisogno reale (consolazione, calma, protezione) dal mezzo disfunzionale (il cibo).
Egosintonia e cultura: quando la società rinforza il disturbo
Un altro elemento che rende i DCA particolarmente egosintonici è la cultura del controllo e della magrezza.
Viviamo in una società che premia la disciplina, la forza di volontà, l’autocontrollo, la performance.
Molte credenze distorte dei DCA — “meno mangio, più valgo”, “la magrezza è successo” — sono condivise culturalmente, non solo individualmente.
Questo rinforza l’egosintonia: il disturbo appare “normale”, “ammirabile”, “motivante”.
Il contesto sociale quindi conferma e protegge la malattia, rendendo più difficile che la persona la metta in discussione.
L’egosintonia come meccanismo di difesa
A livello psicodinamico, l’egosintonia funziona come una difesa contro il dolore psichico.
Il disturbo alimentare serve a tenere sotto controllo emozioni percepite come caotiche o intollerabili: rabbia, paura, senso di vuoto, tristezza, vergogna.
Finché il disturbo funziona come barriera, non viene percepito come un nemico, ma come un alleato.
Rinunciarvi significherebbe affrontare direttamente quelle emozioni.
Per questo, il lavoro terapeutico deve procedere con delicatezza: non si può togliere il sintomo senza offrire alternative di regolazione emotiva.
Egosintonia e motivazione al cambiamento
Il trattamento dei DCA richiede di lavorare su due livelli paralleli:
- La motivazione esterna, spinta da medici, familiari, conseguenze fisiche.
- La motivazione interna, che nasce quando la persona inizia a percepire il disturbo come limitante e non più come sostegno.
Solo quando l’egosintonia comincia a incrinarsi può nascere la motivazione autentica al cambiamento.
Questo passaggio è fragile: la persona può sentirsi persa, vuota, confusa.
È il momento in cui il terapeuta deve accogliere il dolore della perdita del sintomo come parte naturale della guarigione.
Tra le strategie terapeutiche per far fronte all’egosintonia dei DCA ci sono:
- Validare prima di sfidare: negare o contrastare frontalmente l’egosintonia rischia di rafforzarla. Il primo passo è validare la funzione che il disturbo ha avuto: riconoscere che ha aiutato a sopravvivere. Solo da lì si può costruire un senso alternativo.
- Costruire un nuovo linguaggio del Sé: la persona deve poter riscoprire chi è al di là del disturbo. La terapia deve lavorare sull’identità, sui valori e sulle emozioni che l’anoressia o la bulimia hanno oscurato.
- Promuovere esperienze di controllo sano: non si tratta di “eliminare il bisogno di controllo”, ma di trasformarlo: dal controllo distruttivo al controllo consapevole, basato su scelte e non su regole rigide.
- Favorire la mentalizzazione: aiutare il paziente a riflettere sui propri stati mentali (“Cosa sento?”, “Cosa penso?”, “Perché mi comporto così?”) riduce l’automatismo egosintonico.
Presso GAM-Medical, centro specializzato nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (DCA), lavoriamo con un’équipe multidisciplinare e la comprensione dell’egosintonia è parte fondamentale del nostro approccio: non giudichiamo, ma ascoltiamo, accompagniamo e costruiamo insieme nuove modalità di relazione con te stesso e con il cibo.