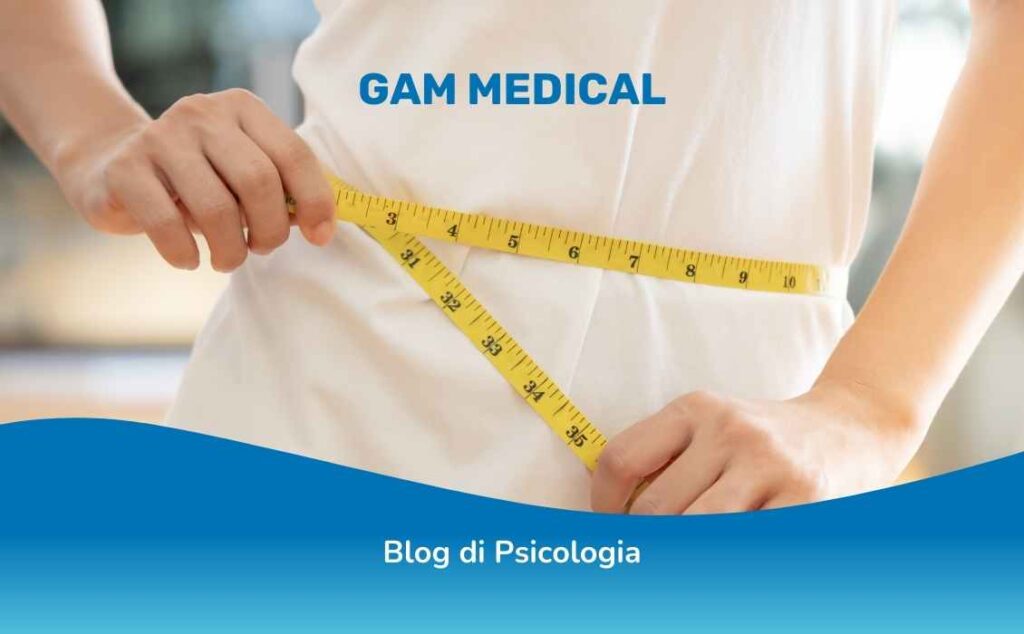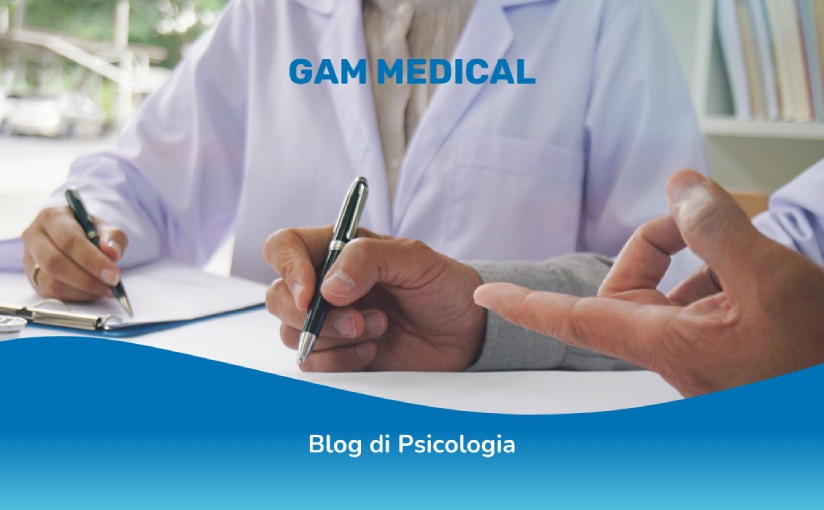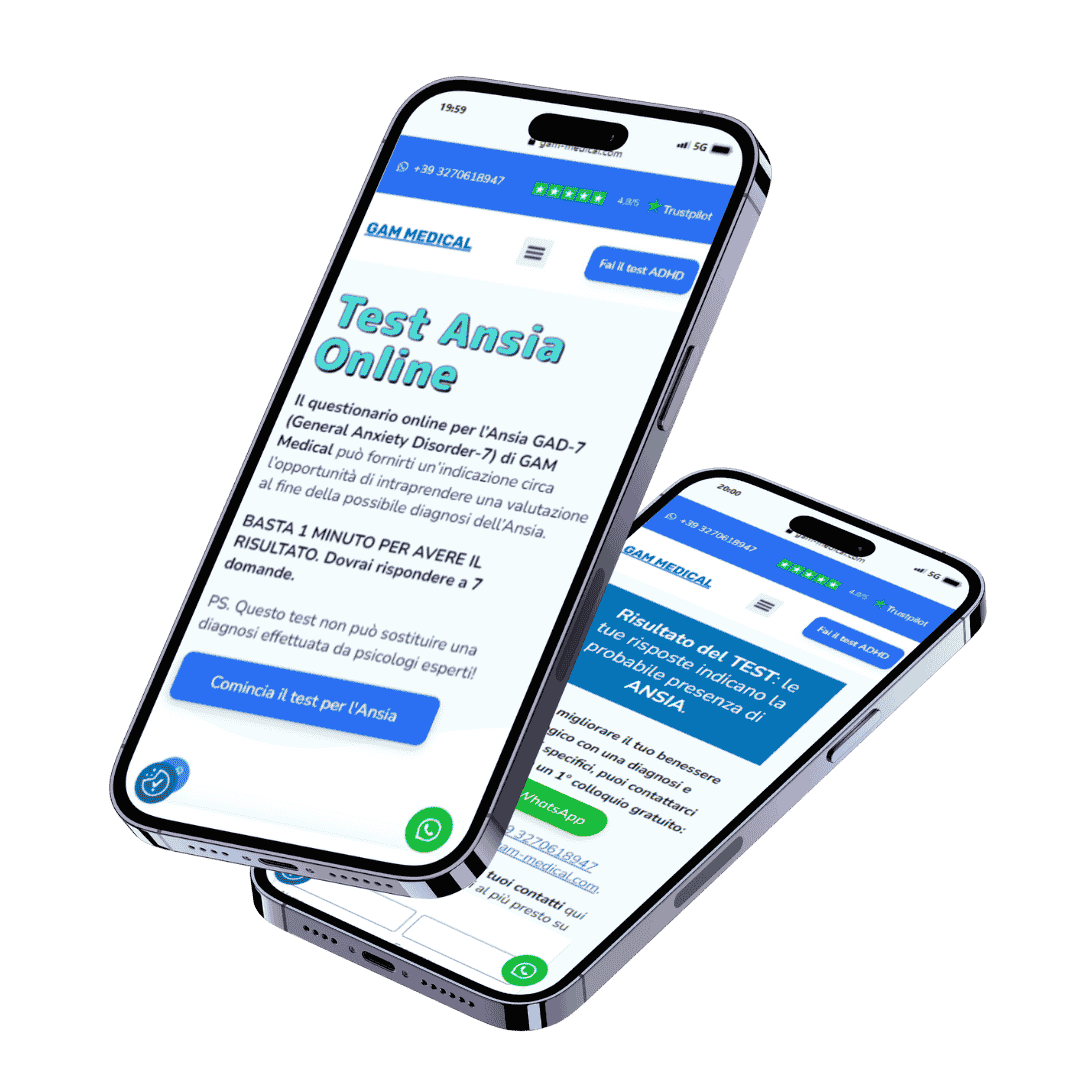Quando una persona subisce un trauma, che si tratti di una violenza, un abuso, un’aggressione o un incidente è, per definizione, vittima di un evento che ha oltrepassato le sue risorse di protezione in quel momento.
Questa è la prima vittimizzazione: l’evento traumatico in sé, con la sua irruzione nella vita della persona, la perdita di controllo, l’impotenza, il senso di minaccia e di pericolo.
Ma c’è un secondo livello che spesso non si vede, pur essendo profondamente traumatogeno: si parla di vittimizzazione secondaria quando, dopo aver subito un trauma, la persona incontra risposte sociali, istituzionali, relazionali o culturali che la colpevolizzano, minimizzano, ridicolizzano, discreditano o la espongono a ulteriore danno.
È secondaria perché non è l’evento originario a ferire, bensì ciò che accade dopo: l’atteggiamento di chi ascolta, i protocolli messi in atto (o non messi in atto), le parole scelte, i tempi, gli sguardi, i dubbi, i commenti, gli articoli di giornale, i post, le domande fuori luogo, i “perché non hai…?”, i “ma sei sicuro/a?”, i “sarai stato/a tu a provocare”, i “non è successo niente”.
Nelle righe che seguono esploreremo in profondità che cos’è la vittimizzazione secondaria, dove e come si manifesta, quali forme assume nei diversi contesti, che cosa la alimenta (bias, stereotipi, miti sul trauma) e quali effetti ha sul piano emotivo, cognitivo e sociale.
Che cos’è la vittimizzazione secondaria?
Per vittimizzazione secondaria intendiamo l’insieme delle esperienze negative che una persona vive dopo un trauma quando entra in contatto con sistemi, persone e ambienti che dovrebbero informare, sostenere, dare giustizia o semplicemente ascoltare e invece aggiungono dolore.
Non è necessaria l’intenzionalità: la vittimizzazione secondaria può essere esplicita (accuse, derisione, colpevolizzazione diretta) oppure implicita (indifferenza, distrazione, ritardi, linguaggio impreciso, burocrazia fredda, procedure che espongono inutilmente, mancanza di privacy). In ogni caso, la persona percepisce che il danno iniziale viene invalidato o aggravato.
Tre sono gli elementi chiave per definire la vittimizzazione come “secondaria”:
- Temporalità: avviene dopo l’evento traumatico, a volte immediatamente, altre volte a distanza di mesi o anni (es. durante un procedimento giudiziario o un’intervista giornalistica).
- Sorgente sociale/istituzionale: arriva da altri (singoli o collettività), da regole e prassi; non è “solo dentro la testa” della vittima.
- Effetto cumulativo: chiaramente non sostituisce l’evento traumatico, ma si somma ad esso, alimentando senso di impotenza, rabbia, vergogna, isolamento.
Le forme della vittimizzazione secondaria
Il repertorio di vittimizzazione secondaria è molto vasto e alcune manifestazioni riguardano:
- Colpevolizzazione esplicita (victim blaming): frasi come “Perché eri vestita così?”, “Perché ci sei andato?”, “Non potevi dire di no?”, “Sei rimasta/o lì, allora volevi”, “Sei sicura/o che sia successo davvero?”, “Avresti dovuto difenderti meglio” spostano la responsabilità dall’autore della violenza alla vittima, producendo vergogna e auto-accusa. Nel PTSD la colpa è già frequente; la colpevolizzazione esterna la rinforza.
- Minimizzazione e delegittimazione: “Non fare la/o drammatica/o”, “Esageri”, “Capita a tutti”, “Non è stato poi così grave”, “Smettila di pensarci”. Il messaggio è “la tua esperienza non conta”, interrompendo narrazione e riconoscimento dell’evento e ostacolando l’integrazione dei ricordi nel tempo.
- Discredito della memoria e della credibilità: “Non ricordi bene”, “Ti contraddici”, “Stai inventando”. La memoria traumatica è spesso discontinua, frammentaria, sensoriale; scambiarla per bugia o incoerenza alimenta rapidamente la vittimizzazione secondaria.
- Interrogatori e domande intrusive: richieste ripetute, dettagli intimi in contesti inappropriati, pressioni a raccontare “tutto”, curiosità voyeuristiche. Anche senza insulti, luogo/tono/frequenza possono risultare opprimenti e riattivanti.
- Ritardi, rimbalzi e burocrazia indifferente: appuntamenti spostati, tempi lunghi, “torni domani, manca un modulo”, “chiami questo numero, non è competenza nostra”. L’indifferenza procedurale fa sentire trascinati in un percorso senza volto; per chi ha iperattivazione/allerta (PTSD) attesa e sospensione pesano molto.
- Violazioni della privacy e del consenso: diffusione di dettagli sensibili a persone non coinvolte, condivisione non necessaria di informazioni/documenti. La perdita di controllo su “chi sa cosa”, centrale nel trauma, viene replicata dal contesto.
- Linguaggio stigmatizzante: espressioni che ridicolizzano, infantilizzano o patologizzano (“isterica/o”, “drammatica/o”, “paranoica/o”) ed etichette sensazionalistiche nei media (“scandalo”, “torbido”, “pettegolezzo”) costruiscono cornici che definiscono cosa “conta” e cosa “non conta”.
- Esposizione forzata e ripetuta al racconto: richieste di narrare l’evento molte volte senza reale necessità o coordinamento tra servizi; ogni ripetizione può riattivare emozioni e immagini, facendo sentire obbligati a rivivere l’accaduto per essere creduti.
- Sanzione sociale e isolamento: allontanamento, pettegolezzi, esclusione, perdita di opportunità (lavorative, sportive, culturali). Le reti che dovrebbero contenere diventano luoghi di rischio; per chi vive evitamento/ritiro (PTSD), l’isolamento esterno si somma a quello interno.
- Narrazioni mediatiche dannose: titoli che insinuano dubbio o colpa, ricostruzioni parziali, foto non consone, commenti online aggressivi, “processi” televisivi. La spettacolarizzazione si trasforma in umiliazione.
- Tradimento istituzionale: quando scuole, università, aziende, comunità religiose o associazioni negano, coprono, spostano o minimizzano. Non è solo una persona a non credere: è un sistema a fallire, con ferita identitaria (“non valgo, qui non sono al sicuro”).
- Micro-invalidazioni quotidiane: sguardi, sospiri, battute, cambi di argomento, “ti stai fissando”, “cambia discorso”, “sei troppo sensibile”. Goccia dopo goccia generano sfiducia e insegnano che “non è il caso di parlare”.
Vittimizzazione secondaria “digitale”
Oggi molte interazioni passano dai canali online. Questo crea nuove vie per la seconda ferita:
- Commenti pubblici che mettono in discussione la versione della vittima.
- Condivisioni non autorizzate di dettagli o immagini (anche in chat ristrette).
- Memoria lunga: un contenuto resta indicizzabile, ripescabile, “ripubblicabile”.
- Anonimato: la distanza riduce l’inibizione e aumenta la violenza verbale.
- Polarizzazione: la logica del “pro/contro” azzera le sfumature, trasformando la persona in bandiera.
Dove accade: i contesti della vittimizzazione secondaria
La vittimizzazione secondaria può prendere piede in molti ambiti, compresi:
- In famiglia: la famiglia può essere rifugio o fonte di secondo danno. Reazioni come “Non dire in giro”, “Pensiamo alla reputazione”, “Non rovinare la vita a nessuno”, oppure l’ipercontrollo (decidere al posto della persona cosa deve fare) comunicano che la priorità non è il suo vissuto, ma altro (apparenza, pace domestica, ordine).
- Tra amici e pari: anche gli amici, spesso in buona fede, possono invalidare: cambiare discussione, giustificare l’aggressore (“è fatto così”), chiedere dettagli per curiosità, trasformare la storia in gossip. Oppure adottare l’atteggiamento “non so che dire → minimizzo”.
- A scuola e all’università: insegnanti, tutor, segreterie, compagni: mancano procedure chiare; le segnalazioni diventano impasse. Commenti in classe, chat di gruppo, pettegolezzi digitali: contesti dove l’etichetta “vittima” viene spesso ridicolizzata.
- Sul lavoro: battute, isolamento da progetti, ritorsioni mascherate da valutazioni di performance, mancata protezione in caso di segnalazioni interne. Il posto di lavoro, che dovrebbe garantire dignità e sicurezza, può diventare teatro di secondi traumi.
- Nella sanità: tempi, linguaggio, spazi: una domanda fatta nel corridoio, una porta socchiusa, un nome ad alta voce quando non serve, l’obbligo di ripetere la storia a professionisti non coinvolti. Anche la sola fretta può suonare come “tu non conti”.
- Forze dell’ordine e giustizia: qui il rischio è alto perché la persona deve raccontare. Se il contesto è non accogliente, se le domande sono suggerenti o colpevolizzanti, se la persona non viene aggiornata, se ci sono ritardi o archiviazioni poco motivate, la vittimizzazione secondaria si imprime profondamente.
- Media e social network: la narrazione pubblica — titoli, foto, tag, condivisioni — può essere cassa di risonanza di stigma e dubbi. Nei social, i commenti anonimi possono diventare aggressioni verbali, creando processi paralleli che aggirano ogni garanzia di rispetto.
- Comunità religiose, sportive, associative: i gruppi valoriali hanno grande potere di proteggere o delegittimare. Se prevale la logica del “non creare scandalo” o “lavare in casa”, la persona impara che non c’è spazio per la sua verità.
Vittimizzazione secondaria e PTSD: intersezioni e risonanze
La vittimizzazione secondaria non è “solo” un’aggiunta spiacevole; dialoga con il disturbo da stress post-traumatico in modi specifici:
- Ricordi intrusivi e trigger: domande, ambienti, parole possono funzionare da stimoli condizionati che riattivano immagini e sensazioni dell’evento originario.
- Evitamento: dopo esperienze di invalidazione, molte persone evitano luoghi, persone, istituzioni, cessano di chiedere aiuto, interrompono percorsi di segnalazione; l’evitamento è un cardine del disturbo post traumatico da stress e si rinforza così.
- Iperattivazione e ipervigilanza: attese, burocrazia, incertezza alimentano allerta e irritabilità. Ogni incontro può essere vissuto come potenzialmente pericoloso.
- Alterazioni di credenze: il trauma può cambiare le credenze su sé e sul mondo (“non valgo”, “il mondo è pericoloso”); la vittimizzazione secondaria cementa questi assunti (“nessuno crede”, “non c’è giustizia”).
- Vergogna e colpa: già frequenti post-trauma, vengono esacerbate da commenti svalutanti, insinuazioni e bias culturali (es. sessismo, razzismo, omobitransfobia, abilismo).
- Disconnessione e isolamento: quando la rete sociale diventa minaccia, la persona si ritira; il ritiro prolungato ha ripercussioni su studio, lavoro, legami.
Quindi la vittimizzazione secondaria non è neutra; modifica traiettorie, tempi e vissuti del disturbo post-traumatico da stress.
Miti e bias che alimentano la vittimizzazione secondaria
La seconda ferita provocata con la vittimizzazione secondaria vive di immaginari.
In particolare:
- “Una vera vittima si comporta in un certo modo”
Aspettarsi che la persona pianga, denunci subito, ricordi tutto in ordine, non rida mai, non esca con amici, non pubblichi foto “felici”. La realtà: le reazioni al trauma sono eterogenee. - “Se non reagisci come dico io, allora dubito”
Pretendere conformità a un copione (“avresti dovuto…”) e, in caso contrario, mettere in discussione la credibilità. - “Il trauma si vede”
Molti traumi non lasciano segni fisici. Anche quando ci sono, non sono prova di tutto. L’assenza di segni non significa assenza di trauma. - “Le false denunce sono ovunque”
Il timore di essere ingannati porta a distribuire scetticismo indiscriminato, creando un clima dove nessuno si sente al sicuro a parlare. - “Come fai a non ricordarti questa cosa?”
Ci si aspetta un racconto perfettamente cronologico. Ma la memoria post-traumatica è spesso a frammenti; dettagli emergono a ondate. - “Se eri lì, volevi” / “Te la sei cercata”
Questo mito sposta la responsabilità sul comportamento della vittima (vestiti, orari, luoghi, consumo di alcol), oscurando il nucleo: un’altra persona ha agito violenza. - “Meglio il silenzio, per non rovinare famiglie, carriere, reputazioni”
La protezione dell’immagine collettiva prevale sul riconoscimento della dignità individuale, generando tradimento istituzionale.
Effetti della vittimizzazione secondaria nel medio e lungo periodo
Cosa può succedere dopo una vittimizzazione secondaria?
- Cristallizzazione del silenzio: la persona impara che parlare è pericoloso.
- Ritiro sociale: si limitano contatti e occasioni, con perdita di risorse.
- Interiorizzazione della colpa: la voce esterna diventa voce interna (“è colpa mia”).
- Rabbia e risentimento: l’ingiustizia alimenta iperattivazione e conflitti.
- Perdita di fiducia: istituzioni, gruppi e ruoli perdono legittimità agli occhi della persona.
- Frammentazione narrativa: la storia non trova spazio per essere detta con coerenza; i ricordi restano sensoriali, spezzati.
Dopo uno o più eventi traumatici, quindi, potrebbe succedere che oltre alla vittimizzazione primaria — il danno diretto dell’accaduto — si debba affrontare anche la vittimizzazione secondaria.
È una dimensione distinta ma altrettanto meritevole di attenzione e, in alcuni passaggi, persino più gravosa sul piano emotivo e sociale perché può riaprire la ferita, amplificarne gli effetti e alimentare silenzio, vergogna e sfiducia.
Per questo i professionisti che lavorano con i traumi si trovano frequentemente a riconoscere e nominare entrambe le forme di vittimizzazione: la primaria, legata all’evento, e la secondaria, legata alla risposta dell’ambiente.
Noi di GAM-Medical, clinica specializzata in traumi e PTSD, conosciamo bene queste dinamiche: sappiamo quanto spesso vittimizzazione primaria e secondaria coesistano e quanto sia importante tenerle entrambe nel campo visivo clinico.