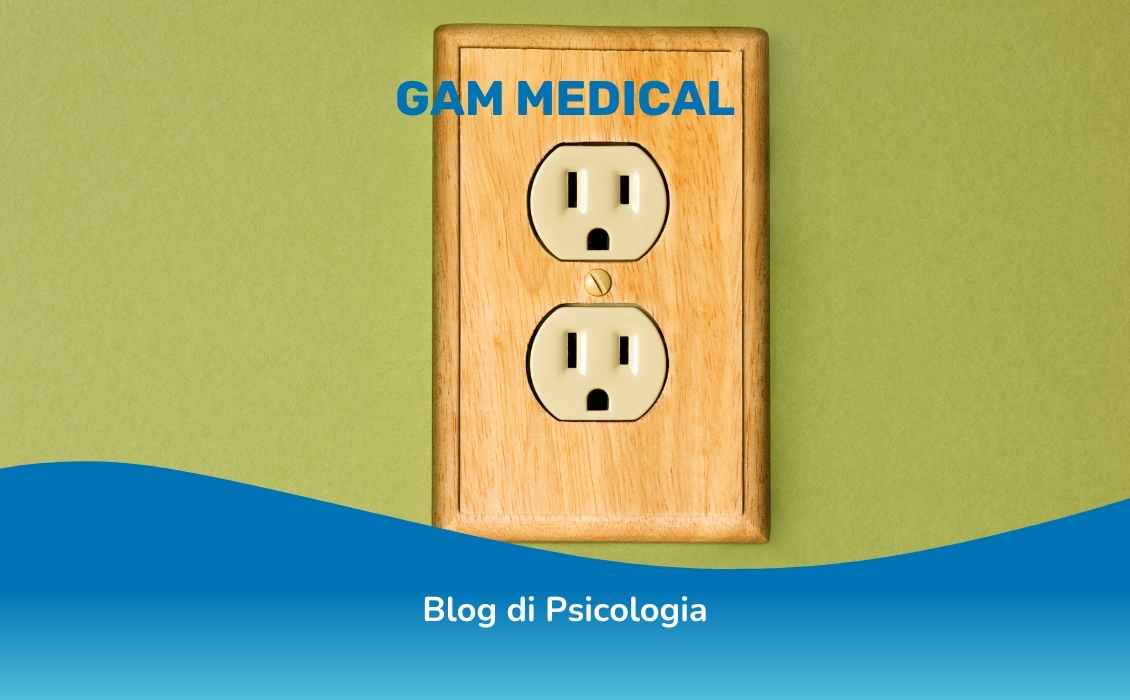Hai mai guardato una nuvola e visto un volto sorridente? Oppure riconosciuto due occhi e una bocca nella facciata di un edificio? Questa tendenza ha un nome: pareidolia, un’illusione percettiva in cui il cervello, cercando schemi familiari, “vede” figure dove non ce ne sono.
A sentirla così, potrebbe sembrare un fenomeno universale, identico per tutti, eppure la ricerca scientifica ci racconta una storia diversa quando si parla di persone nello spettro autistico.
Gli studi mostrano che, proprio nei casi in cui il cervello dovrebbe “vedere volti” in stimoli ambigui, le persone con disturbo dello spettro autistico (ASD) tendono a farlo meno spesso rispetto ai coetanei a sviluppo tipico.
Non perché non abbiano immaginazione o capacità visiva, ma per motivi legati alla percezione sociale e a come guardano i volti reali.
Questo dettaglio, all’apparenza marginale, in realtà si collega a una delle caratteristiche chiave dell’autismo: l’attenzione visiva e il rapporto con il contatto oculare.

Un supporto concreto per l’autismo
Il nostro Centro Clinico offre diagnosi, consulenze e percorsi personalizzati per supportare al meglio le persone autistiche e le loro famiglie. Scopri come possiamo aiutarti.
Cos’è la pareidolia?
La pareidolia è un meccanismo di interpretazione visiva che porta il cervello a riconoscere schemi noti, come volti, figure o simboli, in immagini casuali o ambigue.
È un retaggio evolutivo: il nostro cervello è “programmato” per reagire velocemente a stimoli potenzialmente rilevanti, come un volto, anche quando il segnale è incerto.
Meglio scambiare una macchia per un volto piuttosto che rischiare di non accorgersi di una persona davanti a noi.
In realtà esistono diversi tipi di pareidolia, come ad esempio:
- Pareidolia facciale: vedere volti in prese elettriche, automobili, facciate di case, nuvole, superfici rocciose.
- Pareidolia figurativa: individuare animali o oggetti in forme naturali (un drago nelle nuvole, un coniglio sulla luna).
- Pareidolia sonora: percepire parole in suoni casuali o rumori di fondo.
- Pareidolia simbolica: riconoscere lettere, numeri o simboli in strutture naturali o casuali.
Tra tutte, la pareidolia facciale è la più comune e la più studiata, soprattutto in relazione alla percezione sociale, perché i volti sono uno degli stimoli più rilevanti nella vita umana.
Luoghi e oggetti in cui è più comune sperimentare pareidolia facciale nella vita quotidiana:
- Nuvole – forme soffici che possono facilmente ricordare occhi, nasi e bocche.
- Facciate di edifici – finestre e porte che sembrano occhi e bocca.
- Presa elettrica – i fori sembrano occhi e la fessura di messa a terra una bocca.
- Automobili – fari come occhi, griglia come bocca o naso.
- Elettrodomestici – soprattutto lavatrici, forni e aspirapolvere.
- Sedie o poltrone – bottoni o cuciture che formano “espressioni”.
- Superfici naturali – rocce, tronchi d’albero, cortecce.
- Frutta e verdura – ad esempio peperoni, patate o pomodori con “espressioni”.
- Macchie su pareti o soffitti – umidità, crepe o segni di vernice.
- Oggetti decorativi – disegni su tessuti, tappeti, piastrelle.
- Orologi e strumenti – quadranti con lancette e indicatori che formano volti.
- Giochi o giocattoli – soprattutto quelli non progettati come personaggi ma che ricordano facce.
- Mezzi di trasporto – treni, autobus e aerei, spesso con “espressioni” date da finestrini e fari.
I volti sono centrali per la nostra comunicazione: dagli occhi e dalle espressioni ricaviamo informazioni emotive, intenzioni e segnali sociali.
A livello cerebrale, la percezione dei volti attiva aree specifiche come la fusiform face area (FFA) e regioni della corteccia temporale superiore, specializzate nel riconoscere configurazioni facciali anche quando queste sono vaghe o incomplete.
In altre parole, non serve un volto “perfetto” per far partire il meccanismo di riconoscimento: bastano due punti e una linea, nella giusta posizione, e il cervello “accende” la modalità volto.
Ma cosa succede quando, per ragioni neurologiche e percettive, l’attenzione verso i volti è minore o diversa?

Prenota un colloquio gratuito per l’autismo
Pensi di rientrare nello spettro autistico? Un colloquio gratuito con un nostro psicologo può chiarire molti dubbi, così potrai decidere se iniziare un percorso di diagnosi o trattamento.
Cosa dice la ricerca: autismo e pareidolia
Negli ultimi anni, diversi studi hanno analizzato la relazione tra pareidolia facciale e ASD.
Due lavori in particolare sono rilevanti per capire il quadro.
1. Studio del 2016 – bambini
Lo studio pilota descritto nell’articolo Brief Report: Seeing the Man in the Moon: Do Children with Autism Perceive Pareidolic Faces? A Pilot Study, ha coinvolto 60 bambini con ASD e un gruppo di controllo a sviluppo tipico.
Ai partecipanti sono state mostrate immagini ambigue che potevano evocare volti o oggetti. Risultato? bambini con ASD riconoscevano significativamente meno volti pareidolici. Interpretazione: il “calo” riguarda in modo specifico i volti, suggerendo un’attenzione ridotta verso gli stimoli sociali rispetto a quelli neutri.
2. Studio del 2025 – adolescenti e eye-tracking
Più recente, lo studio Alterations in looking at face-pareidolia images in autism ha coinvolto adolescenti autistici ad alto funzionamento e coetanei tipici in un compito con immagini “Face-n-Food” in stile Arcimboldo.
Usando l’eye-tracking, i ricercatori hanno scoperto che:
- I partecipanti con ASD dichiaravano meno spesso di vedere un volto.
- Guardavano meno le aree chiave del volto (soprattutto gli occhi) e più spesso bocca, parti periferiche o aree non facciali.
- I coetanei tipici, invece, fissavano maggiormente occhi e altre aree facciali centrali.
Questi risultati supportano l’eye avoidance hypothesis: molte persone nello spettro evitano di fissare gli occhi per ridurre il carico emotivo, poiché lo sguardo diretto trasmette informazioni sociali intense e talvolta difficili da processare.
La ridotta pareidolia facciale nelle persone ASD non è casuale.
Gli stessi processi che regolano il contatto visivo e l’attenzione ai volti reali influenzano anche la capacità di riconoscerli quando sono appena accennati.
Tre fattori chiave:
- Minor esposizione visiva ai volti → se si passa meno tempo a guardare volti reali, le aree cerebrali deputate al loro riconoscimento ricevono meno “allenamento”.
- Strategie di esplorazione visiva diverse → invece di concentrarsi su occhi e configurazione generale, lo sguardo si sofferma su dettagli periferici o zone neutre.
- Evitamento emotivo → gli occhi sono una “finestra” emotiva intensa; evitarli riduce il carico sensoriale e l’ansia sociale, ma limita l’abitudine a cogliere segnali facciali.
Molte persone nello spettro dell’autismo raccontano di non riuscire a riconoscere immediatamente anche volti familiari, soprattutto in contesti non abituali.
Questa esperienza quotidiana rende intuitivo il dato degli studi: se il cervello non si abitua a “catturare” rapidamente la configurazione di un volto reale, sarà meno propenso a rilevarlo anche in contesti ambigui — come nelle immagini pareidoliche.

Pensi di essere una persona autistica?
Compila il test di autovalutazione! Ti darà un’indicazione sull’opportunità di approfondire con diagnosi e terapia. Bastano 5 minuti per avere il risultato.

Senti che le difficoltà sociali ti isolano?
Se pensi di essere una persona AUTISTICA e hai difficoltà nella comunicazione e nelle interazioni sociali, una diagnosi può offrirti la comprensione necessaria per affrontare le tue sfide quotidiane. Vuoi avere più informazioni?
Ma allora la pareidolia è ridotta o assente nell’autismo?
La risposta breve: non è assente, ma è meno frequente per i volti.
Questi studi non dicono che una persona nello spettro non possa mai vedere volti nelle nuvole, nelle macchie sui muri o nelle prese della corrente, ma che in media questo accade meno spesso rispetto alle persone neurotipiche, e che la differenza è specifica per i volti, non per altri oggetti.
Inoltre, testimonianze raccolte da persone autistiche nella pratica clinica e nei gruppi di confronto online parlano di una forte presenza, nell’autismo, di altri fenomeni collegati, come:
- Sinestesia: un’esperienza sensoriale in cui uno stimolo in un senso (per esempio, un suono) attiva in automatico una percezione in un altro (per esempio, vedere un colore quando si sente una nota musicale).
Alcune persone nello spettro riferiscono di associare spontaneamente suoni a colori, giorni della settimana a forme, o parole a sapori. - Pareidolia uditiva: la tendenza a percepire parole, frasi o suoni familiari all’interno di rumori casuali o di fondo.
Ad esempio, sentire una “voce” nel rumore del ventilatore, riconoscere un motivo musicale in un elettrodomestico, o percepire frasi in registrazioni distorte
Per alcuni, questi fenomeni sono quotidiani e naturali, tanto da non essere percepiti come “strani” finché non vengono messi a confronto con l’esperienza di altre persone.
Rimane che la pareidolia facciale può essere una finestra privilegiata per osservare le differenze nella percezione sociale tra ASD e sviluppo tipico.

Ti senti bloccato nelle relazioni e nella comunicazione?
Con un percorso terapeutico adatto, puoi trovare strategie per migliorare le tue interazioni sociali e sentirti più a tuo agio nel mondo.