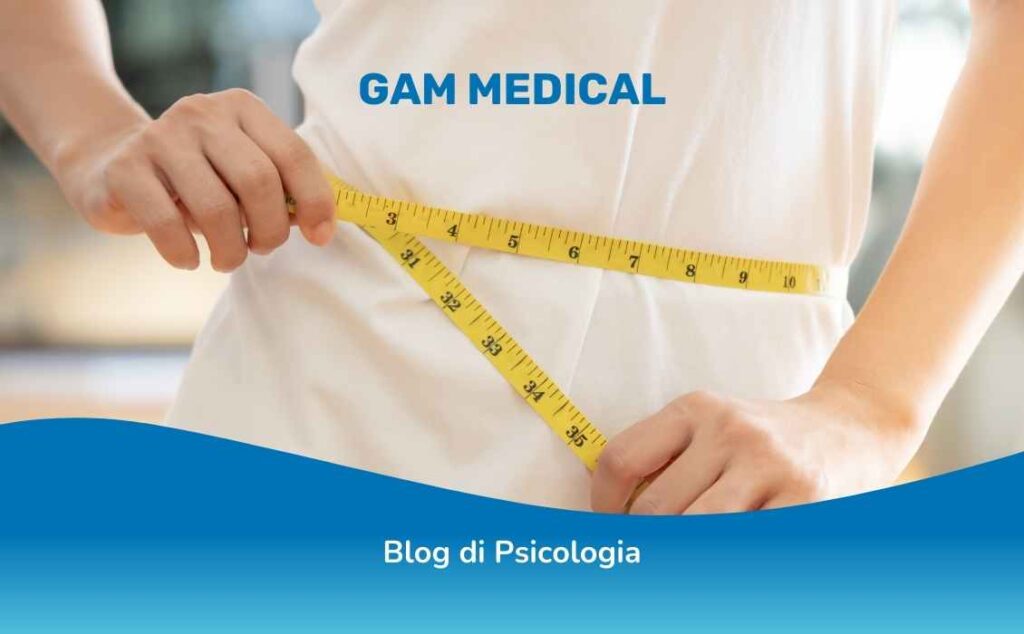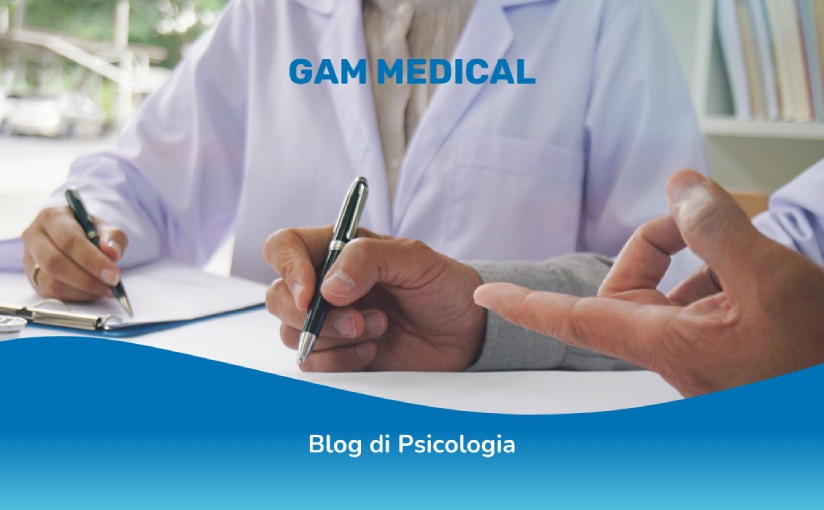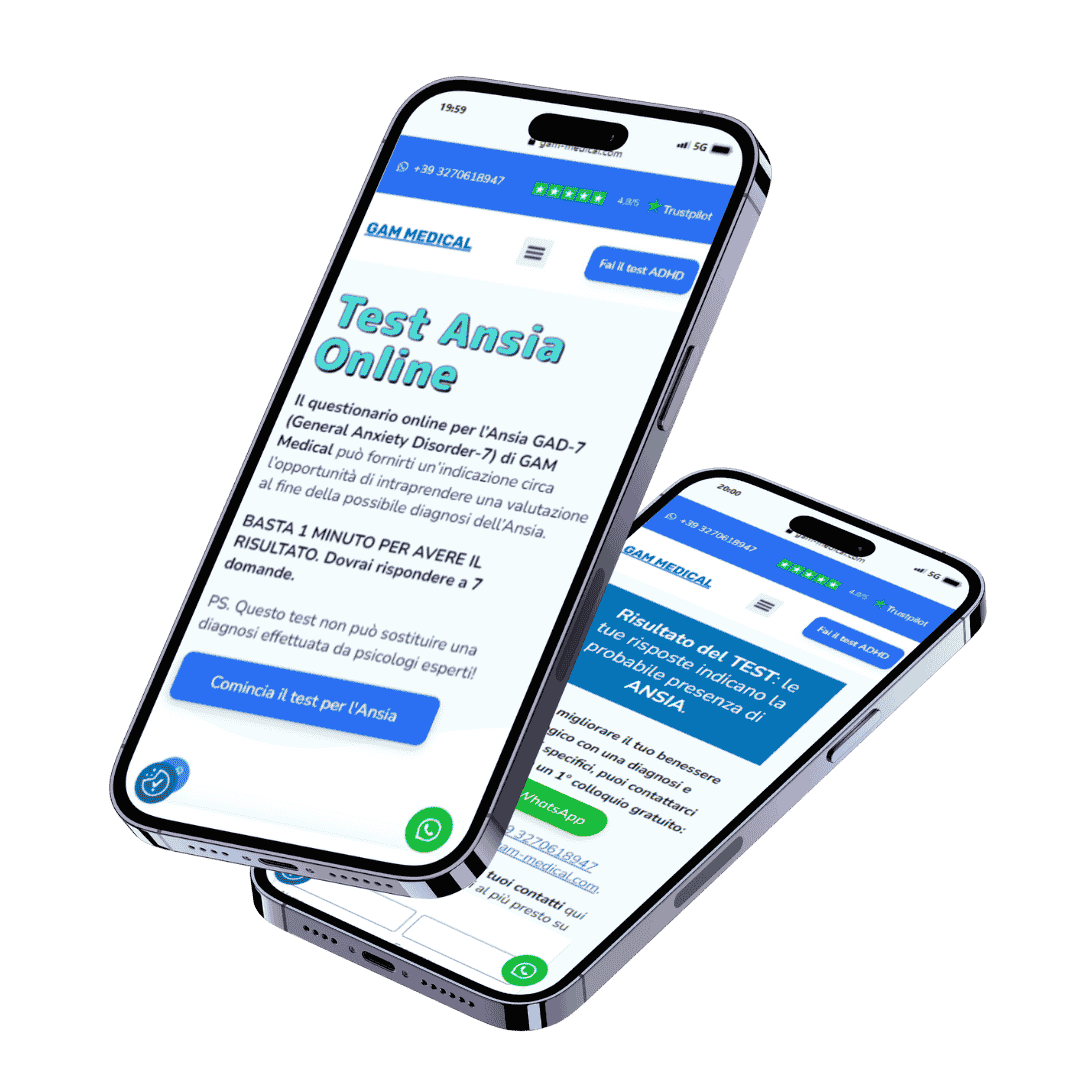Il Disturbo da deficit dell’Attenzione e Iperattività non si esaurisce nell’infanzia: molti adulti scoprono solo tardi di conviverci, dopo anni di difficoltà attribuite a stress, ansia o depressione. I sintomi cambiano forma ma restano presenti, spesso confondendosi con altri disturbi o con problemi di sonno e dipendenze.
In questa intervista il dott. Giancarlo Giupponi, psichiatra e psicoterapeuta, formatore di GAM Medical, racconta cosa significa affrontare l’ADHD in età adulta, tra sfide diagnostiche, percorsi terapeutici multimodali e strategie quotidiane.
Libro “Disattenti e iperattivi. ADHD: cos’è, come riconoscerla, come conviverci ” di Giupponi e Conca
Nel suo libro Disattenti e iperattivi. ADHD: cos’è, come riconoscerla, come conviverci (curato per GAM Medical con Andreas Conca) descrive anche come i sintomi dell’ADHD evolvano con l’età. In particolare, l’iperattività tende a diminuire, mentre la disattenzione e la disregolazione emotiva persistono. Quali sono le principali sfide diagnostiche e terapeutiche nell’affrontare l’ADHD in età adulta?
“L’ADHD è un disturbo che accompagna la persona lungo tutto l’arco della vita, con manifestazioni cliniche che cambiano radicalmente in base all’età e al contesto. Nell’infanzia i sintomi appaiono più evidenti: iperattività motoria, difficoltà di concentrazione a scuola, impulsività. Con l’età adulta, molti di questi elementi si trasformano: l’iperattività diventa tensione interna, la disattenzione resta centrale e condiziona studio, lavoro e vita familiare. La disregolazione emotiva, pur non essendo inclusa nei criteri diagnostici ufficiali, è tra i sintomi più invalidanti: irritabilità, sbalzi d’umore, difficoltà a gestire le emozioni compromettono relazioni e qualità di vita. Questo porta spesso a diagnosi errate con disturbi affettivi o ansiosi.
La diagnosi è resa complessa dalle comorbilità, che superano l’80% dei casi: ansia, depressione, uso di sostanze, disturbi del sonno. Molti adulti arrivano tardi alla valutazione, talvolta dopo che un figlio o un nipote ha ricevuto la diagnosi.
Negli anziani poi il Disturbo da deficit dell’Attenzione/Iperattività può essere confuso con deterioramento cognitivo lieve. L’anamnesi è decisiva per distinguere i sintomi persistenti da un esordio tardivo. In futuro avremo bisogno di più dati sull’ADHD over-60, soprattutto per adattare i protocolli terapeutici.
Il trattamento deve essere multimodale e personalizzato. I farmaci, stimolanti e non stimolanti, hanno efficacia documentata, ma non bastano: vanno integrati con psicoterapia, coaching e psicoeducazione. In presenza di abuso di sostanze può essere utile iniziare con farmaci non stimolanti o trattare prima la dipendenza. L’approccio migliore resta quello su più piani: farmaci, strategie psicologiche, modifiche dello stile di vita e supporto sociale.”
Divulgazione scientifica e ADHD
Come valuta l’importanza della comunicazione scientifica nel sensibilizzare il pubblico sull’ADHD? Quali sono le principali difficoltà nel tradurre contenuti clinici complessi in un linguaggio accessibile?
“La comunicazione scientifica è fondamentale per contrastare i pregiudizi e aumentare la consapevolezza pubblica sul Disturbo d’Attenzione e Iperattività. Ancora oggi persistono miti dannosi: che l’ADHD non esista, che sia solo un problema di disciplina, o che dipenda da cattiva educazione. Queste convinzioni ostacolano diagnosi e accesso alle cure, alimentano stigma e auto-stigma, e fanno sentire molte persone inadeguate. Un’informazione corretta permette invece di riconoscere il disturbo, avviare percorsi di prevenzione e ridurre i ritardi diagnostici.
La difficoltà maggiore è trovare un equilibrio tra rigore scientifico e chiarezza divulgativa. I contenuti clinici, se comunicati in linguaggio tecnico, risultano incomprensibili al grande pubblico; ma se troppo semplificati diventano banali o fuorvianti. È essenziale usare esempi concreti e metafore accessibili, evitando però banalizzazioni. Un’altra sfida è la saturazione di contenuti sul web: molti non sono prodotti da professionisti qualificati e diffondono informazioni scorrette. Il compito del comunicatore scientifico è anche quello di correggere le false credenze.
La comunicazione poi deve essere integrata in un percorso più ampio di sensibilizzazione: formazione di insegnanti, operatori sanitari e medici di base; campagne mediatiche che smontino i falsi miti; collaborazione con associazioni di pazienti. Solo così sarà possibile ridurre la frammentazione, favorire diagnosi precoci e promuovere una cultura che consideri l’ADHD parte delle neurodivergenze.”
Domande sull’ADHD al dott. Giupponi
L’ADHD è spesso associato a disturbi come depressione, ansia e disturbi del sonno. In che modo queste comorbilità influenzano la diagnosi e il trattamento? Esistono approcci specifici per differenziare l’ADHD da altri disturbi con sintomi simili?
“Le comorbilità sono la regola nell’adulto ADHD e rappresentano una delle principali difficoltà cliniche. Ansia, depressione, abuso di sostanze e disturbi del sonno sono presenti, in qualche misura, nella maggioranza dei pazienti. Spesso sono proprio questi sintomi a portare la persona dal medico, nascondendo il disturbo di base. Questo aumenta il rischio di diagnosi errate: la disattenzione può sembrare depressione, l’irrequietezza può essere scambiata per ansia, la disregolazione emotiva può ricordare il disturbo bipolare o borderline.
La diagnosi differenziale si fonda su una valutazione accurata della storia dei sintomi. Nel Disturbo da deficit dell’Attenzione e Iperattività sono cronici, presenti fin dall’infanzia, e si manifestano in contesti diversi (scuola, lavoro, famiglia). Nei disturbi dell’umore o d’ansia compaiono invece in periodi specifici o in risposta a eventi esterni.
La gestione terapeutica deve considerare le comorbilità. In presenza di depressione maggiore si può iniziare con farmaci antidepressivi, in caso di ansia significativa, la psicoterapia cognitivo-comportamentale può ridurre i sintomi. Se coesiste abuso di sostanze, la priorità è trattare la dipendenza, limitando o evitando stimolanti e privilegiando farmaci non stimolanti. L’approccio sequenziale può essere necessario: prima stabilizzare la dipendenza o l’umore, poi introdurre la terapia per l’ADHD.
In sintesi, le comorbilità rendono più complessa diagnosi e trattamento, ma un approccio esperto, multimodale e personalizzato permette di ottenere miglioramenti significativi, riducendo l’impatto globale del disturbo sulla vita del paziente ADHD.”
Chi ha a che fare con il Disturbo da Deficit d’Attenzione e Iperattività ha a disposizione sia trattamenti farmacologici che psicoterapeutici. Come concilia l’approccio farmacologico con quello psicoterapeutico? Qual è il ruolo della psicoeducazione e del coaching nel percorso terapeutico?
“L’approccio ottimale al Disturbo da deficit dell’Attenzione/Iperattività è multimodale: farmaci e psicoterapia non sono alternativi, ma complementari. I farmaci agiscono sui meccanismi neurobiologici, aumentando la disponibilità di dopamina e noradrenalina nelle aree cerebrali coinvolte nell’attenzione e nel controllo degli impulsi. Questo permette una riduzione rapida dei sintomi principali, creando le condizioni perché il paziente possa apprendere nuove strategie. Tuttavia, da soli non bastano a modificare i comportamenti e gli schemi cognitivi appresi.
La psicoterapia comportamentale, adattata per l’ADHD, lavora sulle abilità pratiche: organizzazione del tempo, gestione delle emozioni, ristrutturazione dei pensieri disfunzionali. È uno spazio per imparare tecniche concrete, come suddividere i compiti, utilizzare agende e app, allenare la mindfulness e ridurre l’autocritica.
Accanto a farmaci e terapia, la psicoeducazione ha un valore fondamentale: fornire al paziente e ai suoi familiari una comprensione corretta del disturbo riduce lo stigma e consente di rivedere la propria storia alla luce di un nuovo significato. Anche il coaching psicoeducativo è uno strumento pratico e immediato: aiuta ad affrontare le difficoltà quotidiane con strategie concrete.
La telemedicina e le terapie digitali rappresentano nuove opportunità: consentono follow-up più agili, supporto continuo e interventi psicoeducativi accessibili anche a distanza. In futuro potrebbero diventare uno standard, soprattutto per mantenere l’aderenza terapeutica e monitorare i progressi.”
Con l’evoluzione delle neuroscienze e delle tecniche diagnostiche, quali sviluppi prevede nel campo dell’ADHD? Ci sono nuove frontiere nella ricerca che potrebbero migliorare la comprensione e il trattamento di questo disturbo?
“Il campo dell’ADHD è in continua evoluzione e nei prossimi anni ci si aspettano progressi importanti sia sul piano diagnostico che terapeutico. Le neuroscienze stanno indagando sempre più a fondo le basi neurobiologiche, con studi di neuroimaging e genetica che permettono di identificare circuiti cerebrali e fattori di rischio genetici. L’obiettivo è arrivare a biomarcatori oggettivi, come pattern cerebrali o profili genetici, che possano supportare la diagnosi. Anche il sonno appare un indicatore promettente: differenze misurabili tra persone ADHD e neurotipici potrebbero diventare in futuro strumenti diagnostici.
L’intelligenza artificiale e i fenotipi digitali stanno aprendo nuove prospettive: algoritmi in grado di analizzare dati comportamentali, uso dello smartphone, performance in test digitali o videogiochi possono costituire strumenti di screening preliminare. Le terapie digitali. Sul piano terapeutico, oltre ai farmaci già disponibili, si stanno studiando approcci innovativi: neurofeedback, stimolazione magnetica transcranica, stimolazione a corrente diretta e nuove molecole.
La ricerca sul Disturbo da deficit dell’Attenzione e Iperattività negli anziani è ancora agli inizi, ma diventerà cruciale nei prossimi anni. Serve capire come evolve il disturbo oltre i 60 anni e come adattare diagnosi e terapia a questa fascia di età, distinguendo i sintomi dall’invecchiamento cognitivo. Nel medio termine ci aspettiamo linee guida più specifiche, percorsi di cura più personalizzati e un riconoscimento sempre maggiore dell’ADHD come condizione che accompagna l’intero arco della vita.”
L’ADHD in età adulta è una realtà complessa, che richiede attenzione clinica, percorsi personalizzati e una cultura più consapevole per superare pregiudizi e ritardi diagnostici. Dalle parole del dott. Giancarlo Giupponi emerge chiaramente che non si tratta di un’etichetta, ma di una condizione che coinvolge emozioni, relazioni, lavoro e qualità di vita.
La buona notizia è che oggi abbiamo strumenti diagnostici più precisi, farmaci efficaci, terapie psicologiche e strategie quotidiane capaci di fare davvero la differenza. Guardando al futuro – tra neuroscienze, telemedicina e approcci integrati – cresce la possibilità di offrire a ogni persona ADHD un percorso su misura, più efficace e rispettoso della sua storia.
In GAM Medical crediamo che la conoscenza e la condivisione siano il primo passo per migliorare la vita delle persone con Disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Continuare a parlarne, con rigore e chiarezza, significa aprire nuove strade di cura e comprensione.
Se pensi di riconoscerti in alcuni dei sintomi dell’ADHD adulto, o se vuoi approfondire come questo disturbo possa influenzare la tua vita, il nostro team è a disposizione. Scopri i percorsi dedicati all’ADHD in GAM Medical e contatta i nostri specialisti della salute mentale per una valutazione personalizzata.
Questo è contenuto divulgativo e non sostituisce le diagnosi di un professionista. Se ti è piaciuto l’articolo, condividilo.
Fonti:
- https://www.amazon.it/Disattenti-iperattivi-ADHD-riconoscerla-conviverci/dp/8830905275
- https://www.rivistadipsichiatria.it/archivio/3713/articoli/37043
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32326351/
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28409677/