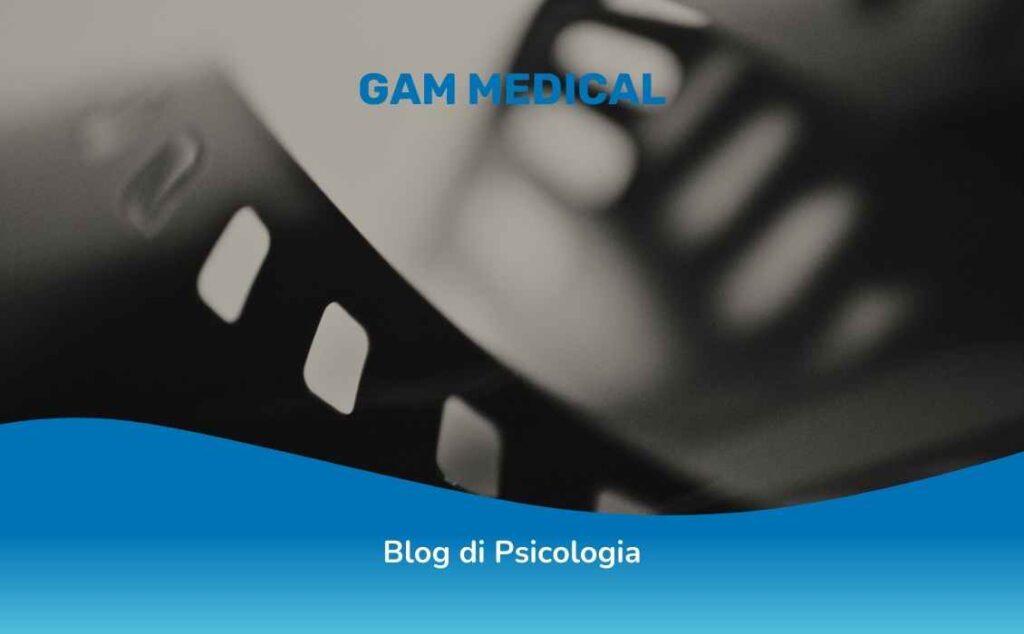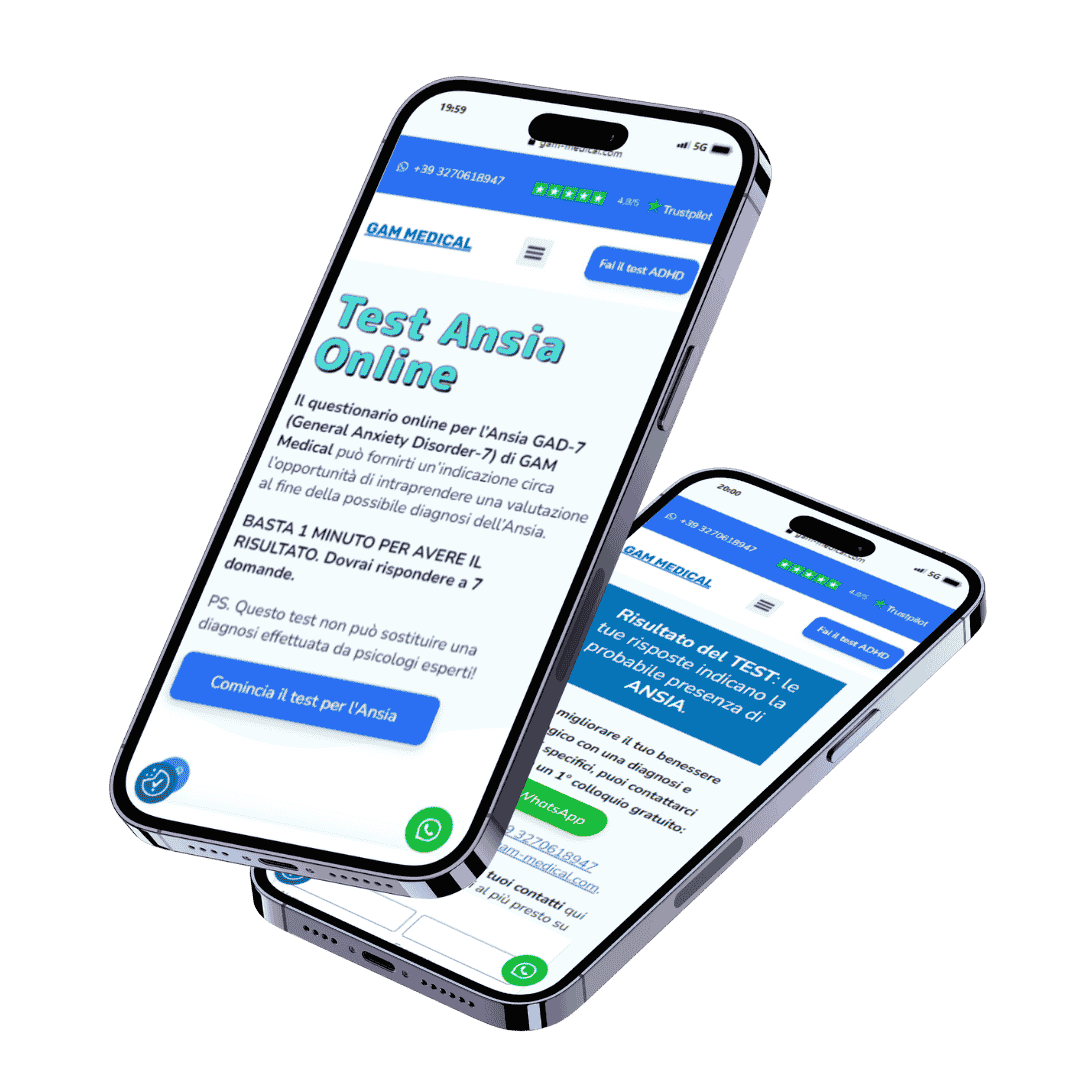Negli ultimi anni i social network sono diventati parte integrante della vita quotidiana, soprattutto per le generazioni più giovani.
Si tratta di strumenti che hanno modificato profondamente il nostro modo di comunicare, di informarci e persino di percepire noi stessi.
È innegabile che abbiano portato con sé molte opportunità – pensiamo alla possibilità di rimanere costantemente connessi, di esprimere la propria creatività o di trovare comunità con cui condividere interessi e passioni – ma allo stesso tempo è importante riconoscere che rappresentano anche spazi potenzialmente delicati.
Questo non significa cadere nella retorica, ormai logora, del “i social distruggono i giovani”: un’affermazione che semplifica eccessivamente la complessità del fenomeno.
Significa piuttosto prendere consapevolezza del fatto che i social, proprio per la loro struttura e per il tipo di interazioni che promuovono, possono diventare terreno fertile per fragilità già esistenti o per dinamiche psicologiche che rischiano di trasformarsi in qualcosa di problematico.
In particolare, quando parliamo di disturbi del comportamento alimentare, è importante sottolineare come le piattaforme digitali possano agire sia come fattori di rischio, sia come fattori che tendono a mantenere e rinforzare il disturbo stesso.
Non è difficile immaginare quanto questi spazi virtuali, fatti di immagini, confronti costanti e approvazione sociale, possano avere un impatto sul modo in cui una persona si percepisce, sul rapporto che costruisce con il proprio corpo e sulla relazione che intrattiene con il cibo.
Ci sono momenti in cui i social vengono utilizzati per confrontarsi con gli altri, altri in cui diventano un luogo dove si cercano conferme o rinforzi, e altre volte ancora finiscono per sostituire l’esperienza reale con forme di alimentazione vicaria, attraverso contenuti e immagini.
Tutto questo assume un peso particolare nelle età evolutive, come la preadolescenza e l’adolescenza, in cui il bisogno di appartenenza, l’importanza dello sguardo degli altri e la costruzione della propria identità corporea sono al centro dello sviluppo.
Non si tratta quindi di dire che i social network “fanno male” o che siano unicamente responsabili di un certo tipo di disagio, ma piuttosto di sottolineare che esistono dinamiche che meritano attenzione, proprio perché rischiano di diventare invisibili e normalizzate.
Tenere a mente questi aspetti è un passo importante per comprendere la complessità del rapporto tra social network e disturbi alimentari, senza cedere a semplificazioni, ma mantenendo lo sguardo critico e consapevole.
Social network come fattore di rischio per i Disturbi Alimentari
Non esiste mai una causa unica e lineare del perché ci si “ammala” di un DCA, ma piuttosto una rete complessa di predisposizioni individuali, influenze familiari, contesti culturali e dinamiche sociali.
All’interno di questa rete, i social network possono assumere un ruolo rilevante, in particolare nelle fasi evolutive più delicate come la preadolescenza e l’adolescenza.
Non perché rappresentino in sé il “nemico” da demonizzare, ma perché possono fungere da amplificatori di fragilità preesistenti e, in alcuni casi, trasformarsi in veri e propri fattori di rischio.
Le piattaforme social si basano infatti su meccanismi che esaltano il confronto, l’approvazione esterna e l’attenzione alla dimensione estetica.
Per un soggetto giovane, che magari già mostra una certa vulnerabilità sul piano dell’autostima o che fatica a costruire un’immagine positiva e stabile di sé, questo terreno può diventare scivoloso.
Nella preadolescenza e nell’adolescenza, infatti, il bisogno di appartenenza e di riconoscimento è particolarmente forte: il corpo diventa un veicolo attraverso cui cercare conferme, testare il proprio valore, ottenere approvazione.
Quando a questo si somma la continua esposizione a immagini di “corpi ideali”, spesso filtrati, ritoccati e presentati come standard raggiungibili, il rischio è che si sviluppi un confronto costante e doloroso.
Questo confronto non avviene in modo sporadico, ma si radica nella quotidianità: scrollare la home, osservare fotografie di coetanei, influencer o celebrità diventa parte della routine.
Il cervello adolescenziale, ancora in fase di maturazione e particolarmente sensibile ai meccanismi di gratificazione immediata, si trova a misurarsi con un flusso incessante di stimoli che rimandano sempre allo stesso messaggio: “questo è il corpo giusto, questo è l’aspetto desiderabile, questo è ciò che vale di più.”
Per chi parte già da una base di autostima fragile, la distanza percepita tra sé e questi modelli diventa insopportabile, e il confronto si trasforma in un fattore di rischio concreto.
In questo modo, il social non crea il DCA dal nulla, ma agisce come una lente di ingrandimento che rende più evidenti e dolorose le insicurezze già presenti.
Il meccanismo di confronto sociale, già descritto in letteratura come una delle dinamiche centrali nello sviluppo dell’identità adolescenziale, trova qui un terreno potenziato e pervasivo.
Non si tratta più solo di confrontarsi con i compagni di classe o con le persone del proprio gruppo ristretto, ma con un universo quasi illimitato di modelli estetici e di vite “perfette” esibite pubblicamente.
La percezione di inadeguatezza si amplifica, e con essa il rischio di ricorrere a strategie disfunzionali per colmare quella distanza percepita: restrizioni alimentari, ossessioni per il controllo del corpo, o altre condotte che, nel tempo, possono sfociare in un vero e proprio disturbo.
È importante sottolineare che non tutti gli adolescenti reagiscono allo stesso modo.
Chi possiede un senso di sé più stabile, una buona rete di supporto familiare e strumenti di pensiero critico può navigare i social senza sviluppare conseguenze cliniche significative.
Ma nei soggetti predisposti – quelli che già partono da una vulnerabilità psicologica, da un’autostima fragile, o che hanno vissuto esperienze di critica e giudizio sul proprio corpo – il rischio è più alto.
Per loro il social network non è semplicemente un passatempo, ma può diventare una sorta di specchio deformante che riflette e ingigantisce le loro paure, i loro dubbi e le loro insicurezze.
Il risultato è un circolo vizioso: più ci si confronta con gli altri e ci si sente inadeguati, più cresce la spinta a modificare se stessi; e più si adottano strategie estreme per ottenere quell’approvazione sperata, più aumenta la possibilità di rafforzare il legame tra immagine corporea e valore personale.
In questo senso, i social network non sono la causa unica del problema, ma diventano uno degli scenari privilegiati in cui la vulnerabilità si manifesta e trova terreno per radicarsi.
Social network come fattore perpetuante dei disturbi alimentari
Se i social network possono rappresentare un fattore di rischio nell’insorgenza di un disturbo della nutrizione e dell’alimentazione, è altrettanto vero che in molti casi diventano fattori di mantenimento e perpetuazione del disturbo stesso.
Per chi già vive quotidianamente con un DCA, le piattaforme digitali finiscono spesso per trasformarsi in un ambiente dove i sintomi trovano terreno fertile per radicarsi, consolidarsi e, in alcuni casi, aggravarsi ulteriormente.
Innanzitutto, i social sono un luogo di confronto per eccellenza.
La persona che soffre di anoressia, bulimia o altri disturbi alimentari tende già di per sé a confrontarsi in maniera ossessiva con gli altri, sia in termini di corpo sia di comportamenti alimentari.
I social amplificano questo meccanismo, offrendo un’esposizione continua a immagini di corpi magri, tonici, scolpiti, spesso lontani dalla realtà ma presentati come modelli “naturali” e desiderabili.
Per chi ha un disturbo, questi contenuti non solo diventano spunti di paragone, ma possono rafforzare la convinzione che il proprio valore dipenda esclusivamente dall’aspetto fisico o dal peso corporeo.
Un altro elemento centrale riguarda le dinamiche di rinforzo. Pubblicare una foto, un selfie o un “progress picture” può tradursi in una ricerca compulsiva di approvazione attraverso like, commenti e visualizzazioni.
Ogni interazione positiva viene vissuta come conferma che il comportamento messo in atto – ad esempio una dieta estrema o una perdita di peso drastica – è valido e va mantenuto.
In questo senso, la piattaforma non solo diventa uno spazio di espressione, ma anche un potente rinforzatore che contribuisce a mantenere in vita il disturbo.
A ciò si aggiunge un fenomeno ancora più problematico: l’esistenza di comunità e spazi virtuali che non solo normalizzano, ma in alcuni casi addirittura glorificano il disturbo alimentare.
È noto, ad esempio, il mondo degli hashtag e dei blog “pro-ana” (pro-anoressia) o “pro-mia” (pro-bulimia), che circolano con continuità nonostante i tentativi di molte piattaforme di limitarne la diffusione.
In questi spazi si trovano consigli su come digiunare, come nascondere i sintomi ai familiari, come bruciare più calorie o come resistere alla fame.
Non si tratta soltanto di contenuti esplicitamente dannosi, ma anche di un linguaggio comunitario che finisce per creare senso di appartenenza: chi soffre di un DCA si sente “capito” e “legittimato” in un contesto che rinforza la patologia invece di contrastarla.
Esistono poi contenuti che, pur non essendo dichiaratamente pro-ana o pro-mia, possono comunque fungere da trigger.
Pensiamo ai video “What I eat in a day”, format molto diffuso in cui le persone mostrano cosa hanno mangiato in una giornata.
A seconda di come vengono presentati, questi contenuti possono avere un impatto fortemente destabilizzante per chi ha un rapporto patologico con il cibo.
Vedere diete ipocaloriche, porzioni estremamente ridotte o regimi alimentari ossessivi può scatenare sentimenti di colpa, invidia o la spinta a emulare quei comportamenti.
Un ulteriore esempio è rappresentato dall’alimentazione vicaria, che in un altro articolo abbiamo già affrontato (Mukbang e DCA: cosa significa guardare gli altri mangiare?), ma che qui vale la pena citare brevemente.
Si tratta del consumo di contenuti in cui altri mangiano in modo esagerato, abbondante o spettacolare, come avviene nei cosiddetti video mukbang.
In questo caso, chi soffre di disturbi alimentari può sostituire l’atto concreto del mangiare con il guardare altri farlo, nutrendosi in maniera simbolica ma rinforzando al contempo la propria ossessione per il cibo.
Anche questo fenomeno, apparentemente innocuo o “intrattenitivo”, può diventare un ulteriore fattore perpetuante del disturbo.
Se stai notando in te stesso, o in una persona a te vicina, dei comportamenti che possono essere ricondotti a un disturbo del comportamento alimentare, è importante fermarsi e ascoltare quei segnali.
Quando il proprio umore, il senso di autostima o la percezione di valore personale dipendono in maniera significativa dal peso, dalla magrezza o dal grado di controllo esercitato sull’alimentazione, è possibile che ci si trovi di fronte a una condizione che merita attenzione e cura.
Affidarsi a professionisti della salute mentale rappresenta un passo di grande coraggio e, allo stesso tempo, un atto di responsabilità verso se stessi o verso la persona che si ama.
Centri specializzati in DCA come la clinica GAM-Medical offrono percorsi specifici e personalizzati per i disturbi del comportamento alimentare, con équipe multidisciplinari in grado di seguire il paziente sia dal punto di vista psicologico che medico-nutrizionale.