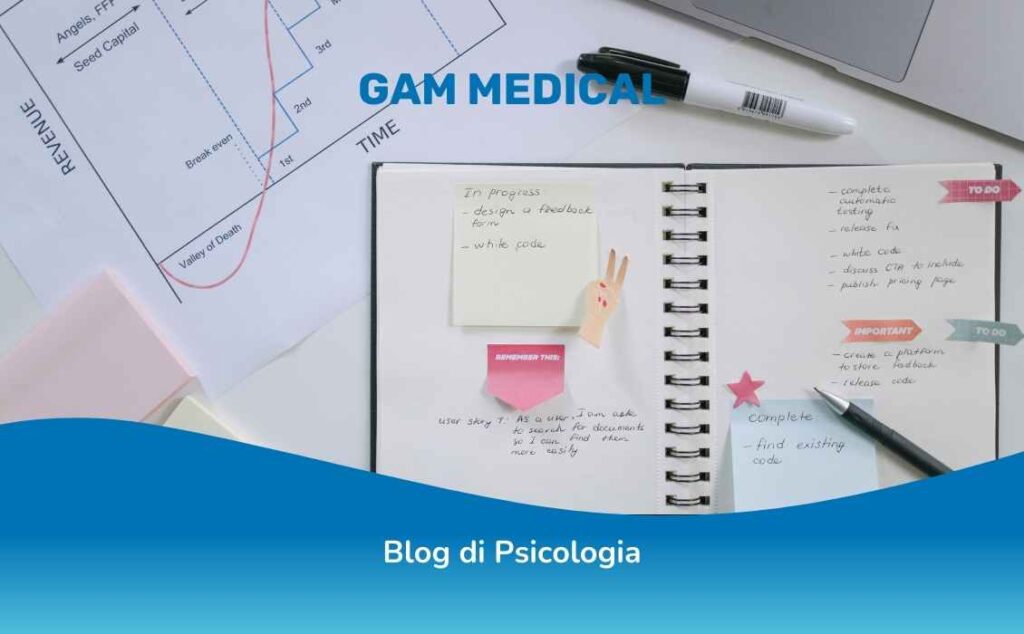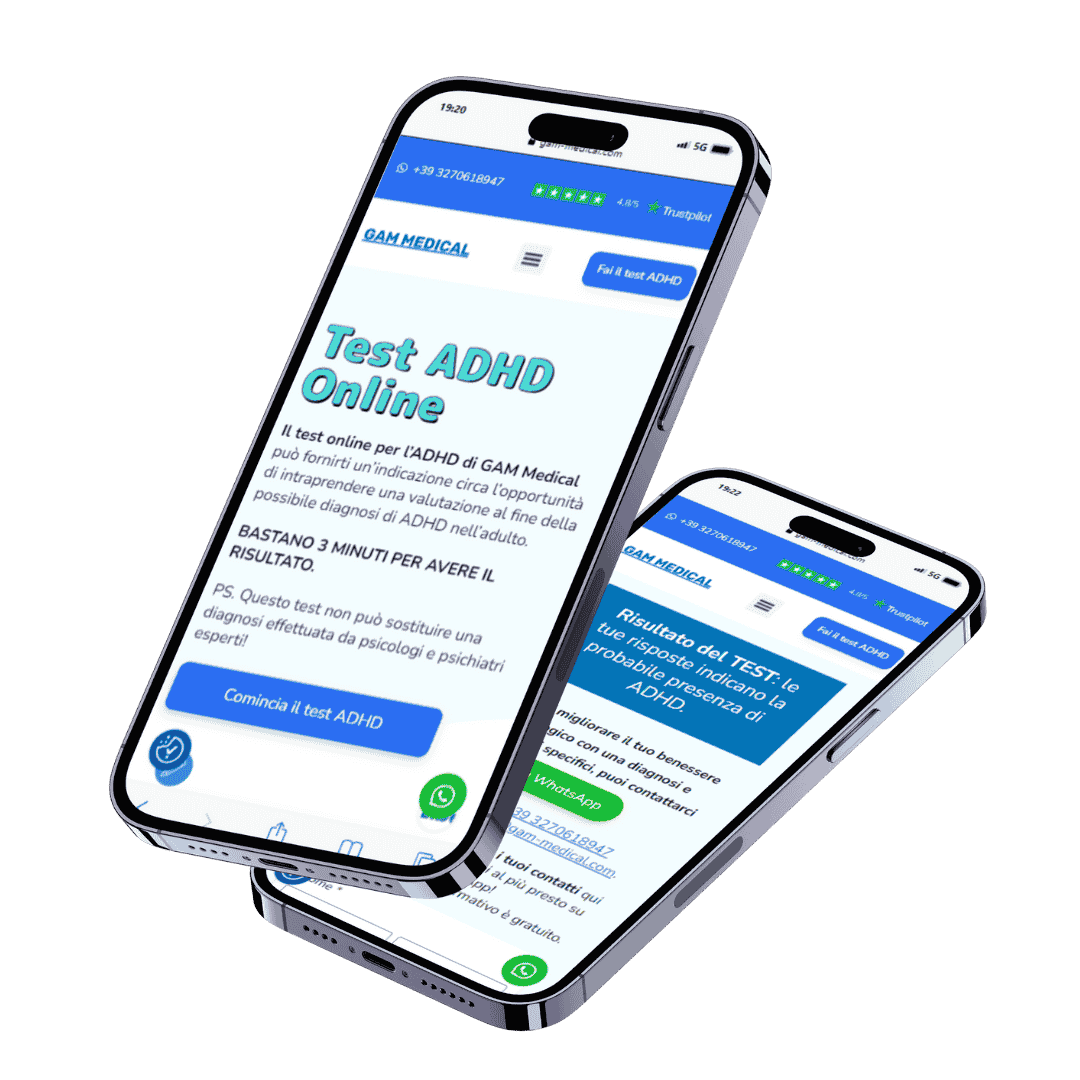Sapevi che chi è ADHD può presentare anche ipoattività oltre ad iperattività?
Siamo abituati a pensare all’ADHD, cioè al Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, come a una condizione caratterizzata da un eccesso di movimento, di energia e di impulsività.
Nella mente di molti, la sigla ADHD evoca subito l’immagine di un bambino o di un adolescente incapace di stare fermo, che parla troppo, si muove senza sosta e fatica a concentrarsi. Tuttavia, questa è solo una parte della realtà.
Esiste infatti una manifestazione molto diversa, quasi opposta, del disturbo: una forma in cui non troviamo l’iperattività, ma al contrario una ipoattività, cioè una riduzione dell’energia e dell’attivazione.
In questi casi, la persona ADHD non appare agitata o impulsiva, ma rallentata, letargica, silenziosa, distratta.
Spesso sembra vivere “a basso volume”, come se il suo cervello facesse più fatica ad accendersi e a mantenere l’attenzione.
È la cosiddetta forma disattenta dell’ADHD, in cui il problema principale non è l’eccesso di attività, ma la difficoltà ad attivarsi.
Potremmo dire, in modo simbolico ma efficace, che in questa versione del disturbo la “H” di Hyperactivity si trasforma in una “h” di Hypoactivity: Disturbo da Deficit di Attenzione e Ipoattività.
Naturalmente, nei manuali diagnostici ufficiali (come il DSM-5) questa distinzione non viene esplicitata in questi termini, ma può essere utile per comprendere il senso clinico e psicologico di ciò che accade.
La persona non è “pigra” o “disinteressata”: è semplicemente ipoattiva, cioè ha un livello di energia più basso e un’attivazione cerebrale ridotta rispetto alla media.
Questa forma di ADHD è particolarmente frequente nelle ragazze, che spesso non mostrano la componente iperattiva o impulsiva tipica dei maschi, ma una modalità più silenziosa, introspettiva e disattenta.
E proprio perché non disturbano, tendono a passare inosservate: la loro ipoattività viene scambiata per timidezza, pigrizia o mancanza di motivazione, quando invece rappresenta un’altra faccia dello stesso disturbo.

Il tuo punto di riferimento per l’ADHD
Se cerchi un aiuto concreto per affrontare l’ADHD, il nostro Centro Clinico è qui per te. Offriamo diagnosi accurate, trattamenti personalizzati e supporto continuo per aiutarti a vivere al meglio.

Prenota un colloquio gratuito per l’ADHD
Pensi che l’ADHD limiti la tua vita? Un colloquio gratuito con un nostro psicologo può chiarire molti dubbi, così potrai decidere se iniziare un percorso di diagnosi o trattamento.
Ipo-attività vs Iperattività
Per comprendere bene la differenza tra iperattività e ipoattività, è importante partire da un concetto fondamentale: che cosa intendiamo per “attività”.
Nel linguaggio psicologico e neurobiologico, l’attività non si riferisce solo al movimento fisico o al livello di energia esteriore, ma al grado di attivazione interna del sistema nervoso — ciò che gli psicologi chiamano arousal.
L’attività, dunque, è una condizione di allerta e di disponibilità all’azione: è ciò che ci permette di concentrarci, di rispondere agli stimoli, di iniziare e portare a termine un compito.
Quando questa attivazione è regolata in modo equilibrato, riusciamo a muoverci, pensare e reagire in maniera flessibile: né troppo, né troppo poco.
Ma se il livello di attivazione si sposta verso uno degli estremi, si manifestano due condizioni opposte: l’iperattività e l’ipoattività.
L’iperattività rappresenta l’eccesso: il sistema nervoso è sovraattivato. La persona non riesce a fermarsi, è sempre in movimento, parla senza sosta, cambia continuamente attività senza completarle.
Questo eccesso di energia è disorganizzato, non regolato: non è forza, ma una difficoltà nel trovare la calma necessaria per concentrarsi. Il corpo e la mente sono come un motore che gira costantemente al massimo, anche quando non serve.
L’ipoattività, invece, è l’estremo opposto: il sistema è sottoattivato. La persona appare rallentata, come se fosse sempre “a corto di batterie”.
Potremmo dire che iperattività e ipoattività sono due facce dello stesso problema di regolazione dell’arousal: da una parte un eccesso incontrollato di stimolazione, dall’altra un deficit di attivazione.
Entrambe derivano da un funzionamento irregolare dei circuiti cerebrali che modulano la dopamina e la noradrenalina — i neurotrasmettitori che regolano attenzione, motivazione e prontezza mentale.
In sostanza, l’iperattivo “non riesce a fermarsi”, mentre l’ipoattivo “non riesce a partire”.
Il primo è spinto da un’energia che non sa controllare, il secondo è bloccato da un’inerzia che non sa superare.
Ma, in fondo, entrambi vivono lo stesso tipo di fatica: quella di non riuscire a regolare il proprio stato interno per essere nel “giusto livello” di attivazione, quello che permette di pensare, imparare e agire in modo efficace.

Pensi di essere ADHD?
Compila il test di autovalutazione! Ti darà un’indicazione sull’opportunità di approfondire con diagnosi e terapia. Bastano 3 minuti per avere il risultato.

Hai il sospetto che l’ADHD ti stia influenzando la vita?
Se credi che l’ADHD possa limitarti, un percorso diagnostico ti aiuterà a ottenere chiarezza e a capire come affrontarlo al meglio.
Ipo e Iper attività: le difficoltà nella regolazione tipiche dell’ADHD
In realtà, quando parliamo di ADHD, non dovremmo pensarlo semplicemente come un “deficit” di attenzione o come un “eccesso” di attività.
Entrambe queste definizioni rischiano di semplificare troppo la complessità del disturbo.
Oggi, molti specialisti preferiscono descrivere l’ADHD come un disturbo della regolazione: un’alterazione della capacità del cervello di modulare in modo flessibile i propri livelli di attenzione, energia e attivazione.
In altre parole, l’ADHD non è tanto una mancanza di attenzione in sé, quanto una difficoltà nel regolarla: nel riuscire ad accenderla, mantenerla e spegnerla quando serve.
E lo stesso vale per l’attività fisica e mentale.
La persona ADHD può oscillare tra momenti di iperattività, in cui l’energia esplode senza controllo, e momenti di ipoattività, in cui tutto sembra rallentare o fermarsi.
Il problema non è quindi “quanto” si è attivi o concentrati, ma come si riesce (o non si riesce) a regolare questi stati interni.
Si potrebbe dire che il cervello ADHD ha una difficoltà nella gestione dei “volumi”: a volte il volume dell’attenzione è troppo basso, e la mente si spegne; altre volte è troppo alto, e diventa impossibile filtrare gli stimoli o mantenere la calma.
Lo stesso accade per l’attività: si alternano momenti di agitazione incontrollata e fasi di stanchezza profonda o immobilità mentale.
Questa difficoltà di regolazione non dipende dalla volontà, ma da un funzionamento neurobiologico specifico.
Le aree cerebrali coinvolte — in particolare la corteccia prefrontale e i circuiti dopaminergici — sono responsabili della capacità di attivare e disattivare l’attenzione e il movimento in modo adeguato al contesto.
Quando questi circuiti lavorano in modo disorganizzato o inefficiente, il cervello fatica a “dosare” le proprie risorse: a volte ne produce troppe, a volte troppo poche.
Per questo motivo, è più corretto parlare di disturbo della regolazione dell’attenzione e dell’attività, piuttosto che di semplice “deficit” o “iperattività”.
L’ADHD, infatti, è una condizione in cui il sistema di controllo dell’arousal e dell’attenzione non riesce a trovare il suo equilibrio, come se i “volumi” interni del cervello si muovessero costantemente su livelli troppo bassi o troppo alti, senza stabilità.
Nella nostra clinica ADHD siamo specializzati nella diagnosi dell’ADHD in tutte le sue manifestazioni: dalla forma iperattiva a quella ipoattiva, che spesso coincide con la forma disattenta. GAM-Medical propone un percorso valutativo integra colloqui clinici, test standardizzati e osservazioni funzionali in contesti reali, così da ottenere un quadro completo che consente di raccogliere anche quelle varianti che non sempre sono immediatamente riconoscibili e riconducibili all’ADHD.
AEHD – Il disturbo da iperattenzione/ipoattività
Secondo la proposta descritta in Psychiatryonline (AEHD: Attention Excess Hypoactivity Disorder), un quadro “speculare” all’ADHD e in parte simile al disturbo ipocinetico ICD-10, l’AEHD sarebbe un disturbo del neurosviluppo con difficoltà nelle funzioni esecutive che producono iperattenzione, ipoattività e ipercontrollo del comportamento non adeguati all’età; per porre diagnosi i sintomi dovrebbero comparire tra 5 anni e mezzo e 12 anni e persistere >6 mesi.
Nel contesto scolastico la iperattenzione rigida e la ridotta attivazione possono ostacolare rendimento e socializzazione; la severità può variare e talvolta, se stimolati o in situazioni di pericolo, i soggetti diventano sufficientemente attivi.
Il testo sottolinea che la letteratura è ancora scarsa e controversa (con possibili bias di interesse), pur riportando stime di prevalenza e differenze di genere, e richiama alla prudenza clinica: più che inventariare una nuova etichetta, l’obiettivo sarebbe comprendere il continuum della regolazione tra eccesso di attenzione/controllo e ipoattività, evitando semplificazioni e medicalizzazioni acritiche.

L’ADHD ti sta mettendo alla prova ogni giorno?
Un trattamento mirato può aiutarti a gestire meglio i sintomi dell’ADHD, migliorando la tua qualità della vita e restituendoti il controllo delle tue azioni.