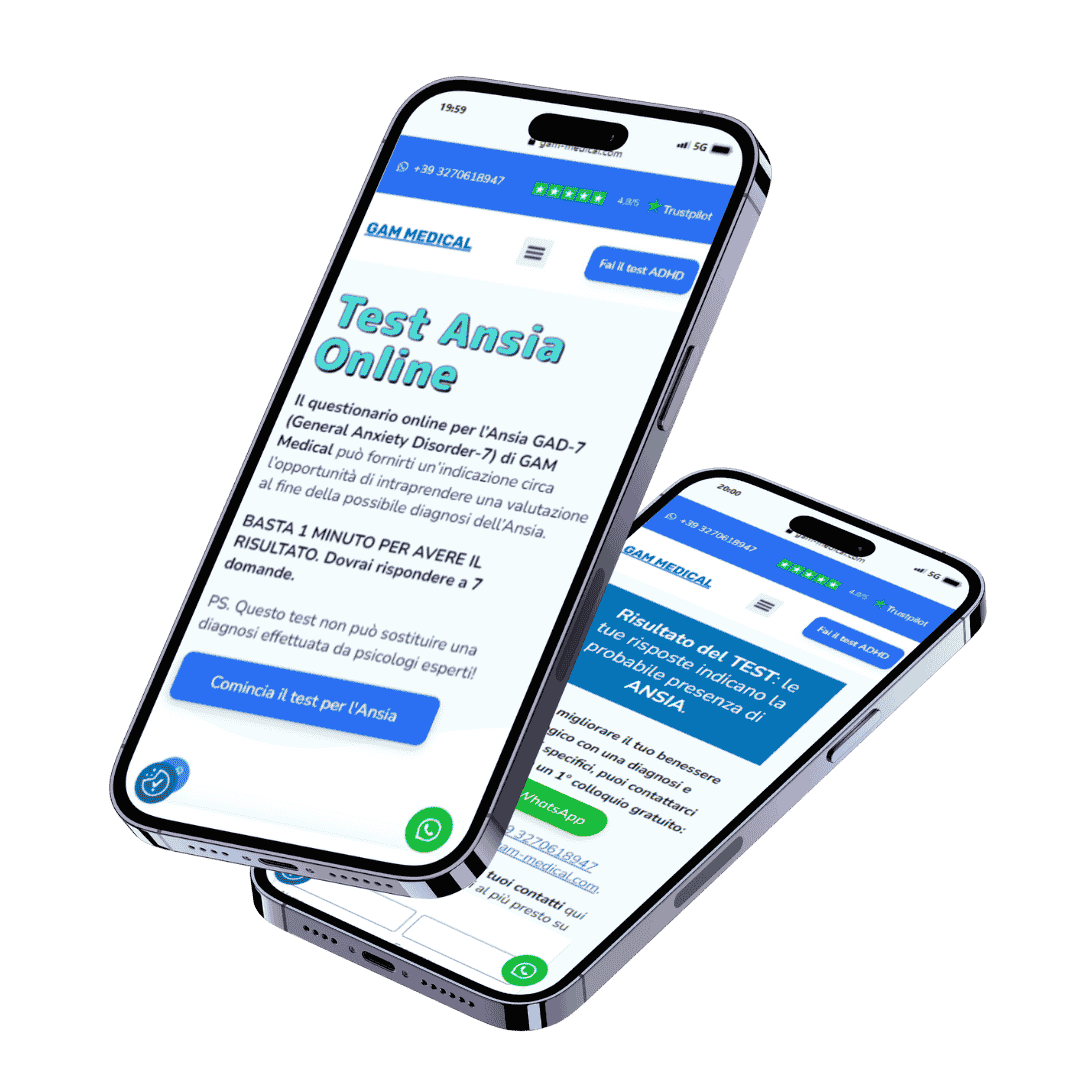Sapevi che molte persone, anche dopo anni dal trauma originale, continuano a rivivere inconsciamente le stesse dinamiche dolorose all’interno delle loro relazioni?
In psicologia, questo fenomeno è noto come copione relazionale traumatico: una tendenza profonda e inconsapevole a riprodurre schemi interpersonali originati da esperienze traumatiche, spesso vissute nell’infanzia o in contesti relazionali significativi
Non si tratta di semplici ricordi o flashback, ma di un vero e proprio copione relazionale: un insieme di aspettative, ruoli e comportamenti che il paziente mette in atto quasi automaticamente, ricreando spesso ruoli che sono riconducibili ai classici vittima, salvatore o abusatore.
L’aspetto cruciale è che il copione relazionale traumatico non è solo un sintomo da trattare, ma una struttura relazionale da interrompere.
Cos’è il copione relazionale traumatico?
Il termine “copione” richiama il linguaggio teatrale: un insieme di battute e azioni che si ripetono seguendo una trama prevedibile.
In questo caso, il copione è interiore: il paziente, senza rendersene conto, interpreta un ruolo che ha appreso in passato, mentre “assegna” agli altri ruoli complementari.
Questi ruoli — vittima, salvatore e abusatore — derivano dal cosiddetto Triangolo drammatico di Karpman, un modello ampiamente utilizzato in psicoterapia per descrivere le dinamiche relazionali disfunzionali.
Nel contesto del trauma, la persona può muoversi da un ruolo all’altro nel corso di una relazione, ma il pattern di base resta invariato: il copione serve a confermare aspettative profonde (“gli altri mi faranno male”, “sono responsabile della sofferenza altrui”, “devo difendermi o attaccare per sopravvivere”), anche quando queste convinzioni sono fonte di dolore.
Questa tendenza è strettamente collegata al concetto di trauma relazionale e, nei casi di traumi ripetuti o prolungati, al PTSD complesso o cPTSD (se non conosci questa tipologia di PTSD, leggi il nostro articolo sul disturbo post-traumatico da stress complesso)
Qui il problema non è solo un evento traumatico singolo, ma una serie di esperienze relazionali dannose che hanno plasmato la percezione di sé e degli altri.
Come si manifesta il copione relazionale traumatico?
Il copione relazionale traumatico può presentarsi in forme diverse, spesso sottili.
Alcuni esempi tipici includono:
- Scelta di partner o amici che riproducono dinamiche abusive o svalutanti, anche quando la persona dichiara di volere relazioni sane.
- Tendenza a sacrificarsi eccessivamente per gli altri, assumendo il ruolo di salvatore, spesso fino al punto di trascurare i propri bisogni.
- Difficoltà a fidarsi, alternata a un attaccamento eccessivo verso figure percepite come protettive.
- Reazioni sproporzionate a piccoli segnali di rifiuto o critica, che riattivano memorie emotive di esperienze passate.
- Conflitti ripetuti con figure di autorità o partner, che ricalcano il rapporto con genitori o caregiver abusanti.
Queste ripetizioni non sono segno di “scarsa volontà” di cambiare, ma il risultato di un condizionamento emotivo profondo, spesso radicato in epoche in cui il paziente non aveva alternative per sopravvivere psicologicamente
Perché il trauma si ripete nelle relazioni?
Può sembrare controintuitivo che una persona voglia ripetere esperienze dolorose.
In realtà, il meccanismo inconscio alla base è una combinazione di ricerca di familiarità e tentativo di riscrivere la storia.
- Ricerca di familiarità: il cervello umano tende a preferire ciò che conosce, anche quando è dannoso. Per chi ha vissuto in ambienti relazionali abusanti, la disfunzione può sembrare “normale”.
- Tentativo di riscrivere la storia: inconsciamente, il paziente può cercare di ricreare la situazione traumatica per cambiarne l’esito. Ad esempio, scegliere partner simili all’abusante sperando di “farcela stavolta”.
Il problema è che, senza consapevolezza e strumenti terapeutici, il copione porta a ripetere il trauma invece di guarirlo.
Ruoli del copione relazionale traumatico: vittima, salvatore, abusatore
All’interno del copione relazionale traumatico, esistono tre ruoli principali che tendono a ripetersi: vittima, salvatore e abusatore.
Questi ruoli non sono etichette fisse e immutabili: una persona può muoversi dall’uno all’altro a seconda della relazione, del momento di vita o dello stato emotivo. Tuttavia, quasi sempre c’è un ruolo “di base” più familiare, che si è appreso durante il trauma o che si è sviluppato come adattamento a esso.
Questi ruoli sono strategie di sopravvivenza che, nel contesto originale del trauma, avevano un senso e una funzione precisa.
Il problema nasce quando continuano a essere agiti in contesti attuali in cui non sono più necessari o sono addirittura dannosi.
NB. questi ruoli non sono rigidi!
All’interno di una stessa relazione, la stessa persona può passare rapidamente da vittima a abusatore, o da salvatore a vittima.
Ad esempio, un salvatore che non riesce a “salvare” può sentirsi vittima; una vittima che percepisce minaccia può reagire con aggressività, entrando nel ruolo di abusatore.
Questa fluidità è parte del problema: il copione non si interrompe semplicemente cambiando ruolo, perché tutti e tre fanno parte della stessa struttura disfunzionale.
La vera interruzione avviene quando la persona riconosce il copione e sceglie di agire in modi che non riproducono la dinamica traumatica originaria.
Nei successivi sottoparagrafi vedremo ognuno dei ruoli nel dettaglio.
1. Il ruolo della Vittima: “perché mi pongo sempre come vittima nelle relazioni?”
Chi ha vissuto un trauma in cui è stato più o meno consapevolmente vittima di abuso, violenza o trascuratezza, può interiorizzare un’identità di vittima.
Questa identità non riguarda solo l’evento traumatico, ma si estende alla percezione di sé: “non ho potere”, “sono in balìa degli altri”, “il mondo è un luogo pericoloso e io sono indifeso”.
Nella vita adulta, questa posizione può tradursi in due direzioni principali:
- Ricerca di salvatori: la persona tende a gravitare verso figure percepite come protettive, affidandosi a loro in modo intenso e talvolta eccessivo. Può sviluppare dipendenza emotiva o tollerare comportamenti disfunzionali pur di mantenere un senso di protezione.
- Identificazione degli altri come abusatori: anche di fronte a comportamenti neutri o protettivi, la persona può interpretare segnali ambigui come minacce, rivivendo emotivamente la dinamica del trauma. Questo può condurre a conflitti o allontanamenti che rinforzano la sensazione di essere perennemente danneggiati dagli altri.
Il rischio, in entrambi i casi, è la rivittimizzazione: inconsciamente, si possono scegliere contesti e persone che confermano la narrazione di sé come vittima, alimentando il copione invece di interromperlo.
2. Il ruolo del Salvatore: “perché cerco sempre qualcuno che mi salvi?”, “perché faccio il/la crocerossino/a?”
Il ruolo del salvatore, all’interno del copione relazionale traumatico, può manifestarsi in due forme apparentemente opposte ma radicate nella stessa matrice: il bisogno di essere salvati e il bisogno di salvare gli altri.
Chi si pone queste domande — “Perché cerco sempre qualcuno che mi salvi?” oppure “Perché faccio il/la crocerossino/a?” — sta in realtà, probabilmente, esplorando due lati della stessa strategia di sopravvivenza, spesso appresa in un contesto traumatico.
Per alcuni, l’origine è un’infanzia o un’adolescenza in cui si è sperimentata una costante vulnerabilità, fisica o emotiva.
In questi casi, affidarsi a figure forti o protettive è diventato un modo per sentirsi al sicuro.
La ricerca di un “salvatore” in età adulta riproduce inconsciamente questo modello: si sceglie di legarsi a persone percepite come capaci di proteggerci o di prendere decisioni per noi, anche a costo di tollerare relazioni sbilanciate o poco sane.
È una strategia che mantiene un senso di sicurezza, ma a lungo andare rafforza la percezione di non essere autonomi o capaci di affrontare la vita senza una “guida” esterna.
Per altri, il trauma ha portato a un adattamento opposto: diventare loro stessi i salvatori.
È la dinamica del “crocerossino” o della “crocerossina”, spesso radicata in esperienze in cui, da bambini, ci si è trovati a prendersi cura di un genitore in difficoltà, a proteggere fratelli più piccoli o a mediare in un contesto familiare instabile.
In questi scenari, aiutare gli altri non era una scelta, ma una necessità per ridurre il pericolo o mantenere un minimo di equilibrio.
Da adulti, questa tendenza può trasformarsi in una vera e propria identità: si cerca attivamente chi ha bisogno di essere aiutato, si investono energie e risorse nel “salvare” gli altri, talvolta fino a esaurirsi o a trascurare i propri bisogni fondamentali.
In entrambi i casi, che si cerchi un salvatore o che si agisca da salvatore, il copione è simile: la relazione si fonda su uno squilibrio di potere e dipendenza.
Questo modello, per quanto familiare e apparentemente sicuro, impedisce di sperimentare relazioni paritarie e reciproche, e spesso diventa un ostacolo alla guarigione.
3. Il ruolo dell’Abusatore nelle relazioni post-traumatiche
Questo ruolo è spesso frainteso: non riguarda solo chi, durante il trauma, ha inflitto danno, ma anche chi, da vittima, ha interiorizzato il messaggio che “per sopravvivere devo avere il controllo o colpire prima che mi colpiscano”.
Dopo il trauma, alcune persone adottano comportamenti di tipo abusivo o controllante come difesa preventiva. Non si tratta necessariamente di violenza fisica: può essere svalutazione verbale, manipolazione emotiva, aggressività passiva o ipercontrollo.
Nella vita adulta, l’ex-vittima che è diventata abusatore tende a:
- Cercare vittime: partner o amici percepiti come deboli o bisognosi, in cui si può esercitare un controllo diretto.
- Leggere vulnerabilità come pericolo: se qualcuno si avvicina emotivamente, l’abusatore reagisce con attacchi o distacco per evitare di sentirsi esposto.
- Confondere rispetto con debolezza: il modello relazionale interiorizzato è che “chi comanda è al sicuro”, quindi la parità può essere percepita come perdita di potere.
Questo ruolo è spesso il più difficile da riconoscere per chi lo agisce, perché è protetto da narrazioni giustificative (“lo faccio per il tuo bene”, “così impari a difenderti”).
Il copione relazionale traumatico in terapia
Uno degli aspetti più delicati di questo fenomeno è che il copione non resta fuori dalla stanza di terapia.
Anzi, la relazione terapeutica in casi di traumi o disturbi ad essi associati, come il disturbo post-traumatico da stress (PTSD), per la sua intensità e il suo valore emotivo, può diventare un terreno fertile per la ripetizione.
Il paziente può:
- Posizionarsi nel ruolo di vittima, percependo il terapeuta come una figura distante, svalutante o giudicante;
- Assumere il ruolo di salvatore, cercando di “prendersi cura” del terapeuta o di non deluderlo, a scapito della propria autenticità;
- Entrare nel ruolo di abusatore, criticando o svalutando il terapeuta, soprattutto quando si sente ferito o non compreso.
Queste dinamiche, conosciute tra i terapeuti come “transfert”, possono emergere gradualmente o in momenti di crisi, e se non vengono riconosciute rischiano di compromettere il lavoro clinico.
Per il terapeuta, la sfida è mantenere un’alleanza terapeutica solida, riconoscendo il copione e aiutando il paziente a osservarlo dall’esterno, senza giudizio
Il copione relazionale traumatico è una delle eredità più insidiose del trauma, perché agisce silenziosamente e si manifesta proprio nei legami più significativi.
Riconoscerlo non significa colpevolizzare il paziente, ma restituirgli potere e scelta.
In GAM-Medical, clinica specializzata in trauma e PTSD, sappiamo che interrompere questo copione non è un passaggio accessorio, ma il cuore stesso della guarigione: significa liberare la persona da una trama relazionale che non ha scritto, ma che ha imparato a recitare per sopravvivere.
Il lavoro terapeutico è il luogo in cui questa storia può essere finalmente riscritta, non più sotto il segno del trauma, ma della consapevolezza e della libertà.