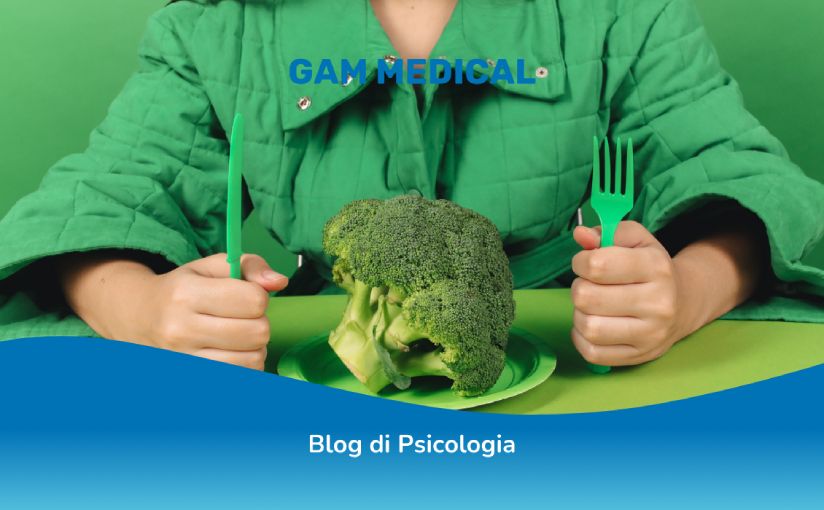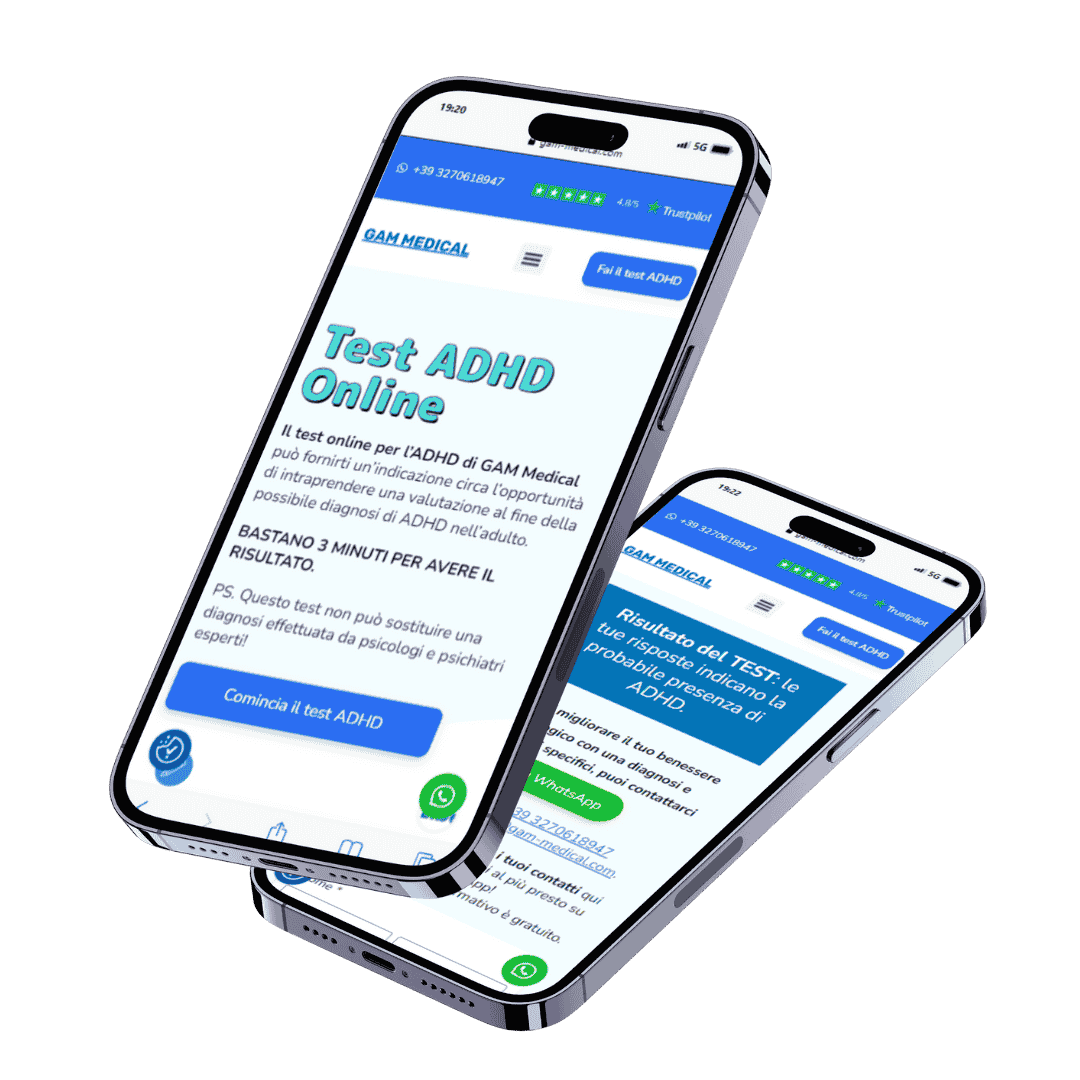Nel dibattito sulle neurodivergenze, l’attenzione è spesso concentrata su due condizioni principali: l’autismo e l’ADHD.
Entrambe sono condizioni che influenzano il modo in cui una persona pensa, percepisce e interagisce con il mondo, eppure esiste una discrepanza importante nel modo in cui vengono classificate e riconosciute.
L’autismo, oggi noto come disturbo dello spettro autistico (ASD), è stato ufficialmente ridefinito come spettro solo negli ultimi decenni, mentre l’ADHD continua a essere considerato un disturbo con sottotipi distinti e non una condizione che si distribuisce lungo un continuum.
Questo porta a chiedersi: perché l’ADHD non è ancora stato riconosciuto come spettro, proprio come è avvenuto per l’autismo? E, soprattutto, sarebbe possibile farlo in futuro?

Hai il sospetto che l’ADHD ti stia influenzando la vita?
Se credi che l’ADHD possa limitarti, un percorso diagnostico ti aiuterà a ottenere chiarezza e a capire come affrontarlo al meglio.
Cosa si intende per “spettro” in psicologia?
L’idea di “spettro” in medicina e in psicologia si riferisce a una gamma continua di manifestazioni cliniche di una condizione, piuttosto che a una categoria rigida con confini netti.
Quando si parla di un “disturbo dello spettro”, si sta dicendo che esiste una grande variabilità tra le persone che ricevono quella diagnosi: alcune possono avere sintomi lievi, altre molto gravi, alcune possono manifestare un certo insieme di difficoltà mentre altre ne sperimentano di completamente diverse.
Il concetto di spettro permette di riconoscere che una condizione può esistere in molteplici forme e che i confini tra una diagnosi e un’altra possono essere sfumati.
Questo è esattamente ciò che è avvenuto con l’autismo.
Fino a pochi decenni fa, l’autismo veniva suddiviso in diverse diagnosi separate, come autismo infantile, sindrome di Asperger e disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato (PDD-NOS).
Tuttavia, con l’avanzare delle conoscenze scientifiche, ci si è resi conto che queste classificazioni erano artificiose e che, piuttosto che esistere come condizioni distinte, esse rappresentavano variazioni di uno stesso insieme di caratteristiche neurocognitive.
Questo ha portato alla decisione di unificare queste diagnosi sotto un’unica etichetta: disturbo dello spettro autistico.
Questo cambiamento ha permesso di riconoscere che l’autismo si manifesta in modi molto diversi da persona a persona e che non si tratta di una condizione fissa, ma piuttosto di un continuum di tratti.
Questa stessa logica potrebbe essere applicata all’ADHD.
Anche in questo caso, la diagnosi di ADHD è attualmente suddivisa in sottotipi (prevalentemente disattento, prevalentemente iperattivo-impulsivo e combinato), ma la realtà clinica è molto più complessa.
L’ADHD non si manifesta sempre in modo chiaro e definito, e molte persone presentano sintomi che si collocano a metà tra le categorie diagnostiche attuali.
La domanda quindi sorge spontanea: perché l’ADHD non è già stato ridefinito come spettro, proprio come è successo per l’autismo?

Pensi di essere ADHD?
Compila il test di autovalutazione! Ti darà un’indicazione sull’opportunità di approfondire con diagnosi e terapia. Bastano 3 minuti per avere il risultato.
Perché l’ADHD non è ancora considerato uno “spettro”?
Ci sono diverse ragioni per cui questo cambiamento non è ancora avvenuto.
In primo luogo, l’autismo ha una lunga storia di sottodiagnosi e fraintendimenti clinici, il che ha reso necessario un cambiamento radicale nel modo in cui veniva descritto.
La ridefinizione come spettro ha permesso di includere molte persone che in passato non rientravano nei criteri diagnostici rigidi dell’autismo classico.
L’ADHD, d’altra parte, è stato diagnosticato in modo più costante nel tempo, quindi il bisogno di una ridefinizione non è stato percepito con la stessa urgenza.
Un altro fattore è la natura stessa dei sintomi dell’ADHD.
Mentre l’autismo è principalmente caratterizzato da difficoltà nella comunicazione sociale e da interessi ristretti e ripetitivi, i sintomi dell’ADHD (disattenzione, impulsività e iperattività) sono considerati più “universali” e possono manifestarsi anche in individui senza una diagnosi formale.
Questo ha portato a un dibattito su quanto l’ADHD sia effettivamente una condizione distinta o piuttosto una variazione naturale della neurodiversità.
Se fosse considerato uno spettro, potrebbe diventare più evidente che molte persone sperimentano alcune caratteristiche dell’ADHD in misura variabile, senza necessariamente soddisfare i criteri per una diagnosi clinica.
Tuttavia, è sempre più probabile che in futuro l’ADHD venga riconosciuto ufficialmente come spettro.
La ricerca neuroscientifica sta dimostrando che l’ADHD non è un disturbo unitario, ma una condizione con molteplici sottotipi e varianti, che possono manifestarsi con diversa gravità e combinazioni di sintomi.
Inoltre, l’integrazione tra ADHD e altre condizioni neuropsichiatriche sta portando a una maggiore comprensione della sua complessità.
Alcuni studiosi suggeriscono che l’ADHD potrebbe essere visto come parte di un più ampio spettro di disturbi dell’autoregolazione, che include difficoltà nella gestione dell’attenzione, dell’impulsività e delle emozioni.

Prenota un colloquio gratuito per l’ADHD
Pensi che l’ADHD limiti la tua vita? Un colloquio gratuito con un nostro psicologo può chiarire molti dubbi, così potrai decidere se iniziare un percorso di diagnosi o trattamento.
Perché si potrebbe, in futuro, parlare di “Spettro dell’ADHD”?
L’ADHD è attualmente classificato come un disturbo neuropsichiatrico distinto, caratterizzato da sintomi di disattenzione, iperattività e impulsività.
Tuttavia, negli ultimi anni, diversi studi e prospettive scientifiche hanno suggerito che potrebbe essere più accurato considerarlo non come un singolo disturbo, ma come una condizione che esiste lungo uno spettro, in modo simile all’autismo.
Questa ipotesi si basa su molteplici fattori, tra cui:
- Eterogeneità della sintomatologia: l’ADHD si manifesta in modi estremamente diversi tra le persone, rendendo difficile incasellarlo in una definizione rigida. Alcuni individui sperimentano principalmente difficoltà di attenzione, mentre altri mostrano impulsività e iperattività. Inoltre, l’intensità dei sintomi può variare notevolmente da lieve a grave. In alcuni casi, la compromissione è limitata a specifici ambiti della vita, mentre in altri può influenzare quasi ogni aspetto del funzionamento quotidiano. Questa grande variabilità suggerisce che non esiste un solo tipo di ADHD, ma piuttosto una gamma di presentazioni cliniche che potrebbero essere meglio comprese se considerate come parte di uno spettro.
- Evidenze neurobiologiche: le ricerche in neuroscienze hanno dimostrato che l’ADHD non ha un’unica base biologica, ma coinvolge molteplici sistemi cerebrali e percorsi neurochimici. Sono state identificate alterazioni nella rete delle funzioni esecutive, nella connettività della corteccia prefrontale, nella regolazione della dopamina e della noradrenalina e nell’attivazione di diverse aree del cervello coinvolte nella modulazione dell’attenzione, della memoria di lavoro e del controllo degli impulsi. Tuttavia, questi deficit non sono presenti in maniera uniforme in tutti gli individui ADHD, il che rafforza l’idea che il disturbo esista lungo un continuum piuttosto che come una condizione monolitica.
- Variabilità nelle traiettorie di sviluppo: gli individui ADHD possono seguire percorsi di sviluppo molto diversi. Alcuni bambini ADHD mostrano una riduzione dei sintomi con l’età, mentre altri continuano a sperimentare difficoltà significative nell’età adulta. Inoltre, l’ADHD può manifestarsi in modi differenti a seconda delle fasi della vita: nei bambini, l’iperattività può essere particolarmente evidente, mentre negli adulti possono emergere problemi legati alla gestione del tempo, alla procrastinazione e alla regolazione emotiva. Questo suggerisce che l’ADHD potrebbe essere meglio descritto come una condizione con espressioni diverse lungo l’arco della vita, piuttosto che un disturbo statico con manifestazioni uniformi.
- Dimensione della disfunzione piuttosto che categorizzazione rigida: un modello dimensionale dell’ADHD riconoscerebbe che i sintomi si distribuiscono lungo un continuum, piuttosto che essere presenti o assenti in modo netto. Questo è il motivo per cui molte persone mostrano tratti di disattenzione o impulsività senza soddisfare pienamente i criteri per una diagnosi clinica. Nel caso dell’autismo, il passaggio da una classificazione categoriale (sindrome di Asperger, autismo infantile, ecc.) a un concetto di spettro ha permesso di riconoscere che molte persone condividono alcune caratteristiche autistiche senza necessariamente avere una forma grave di autismo. Un approccio simile per l’ADHD potrebbe aiutare a riconoscere meglio le variazioni individuali e adattare il supporto in base alle specifiche difficoltà di ogni persona.
Alla luce di tutto ciò, la domanda non è se l’ADHD può essere considerato uno spettro, ma quando lo sarà. Il progresso nella ricerca neuroscientifica e nella comprensione della neurodiversità sta rendendo sempre più evidente che la categorizzazione attuale è troppo rigida e non riflette la realtà della condizione.
Se l’autismo è stato ridefinito come spettro solo negli ultimi decenni, è possibile che lo stesso percorso venga seguito per l’ADHD nei prossimi anni.

Il tuo punto di riferimento per l’ADHD
Se cerchi un aiuto concreto per affrontare l’ADHD, il nostro Centro Clinico è qui per te. Offriamo diagnosi accurate, trattamenti personalizzati e supporto continuo per aiutarti a vivere al meglio.
Cosa comporterebbe avere l’etichetta “Spettro dell’ADHD”?
Se l’ADHD venisse riconosciuto ufficialmente come uno spettro nei manuali diagnostici, le implicazioni sarebbero profonde sia a livello clinico che a livello sociale.
Questo cambiamento influenzerebbe la diagnosi dell’ADHD, il trattamento dell’ADHD nonché la ricerca scientifica e la percezione pubblica del disturbo.
La transizione da una categorizzazione rigida a un modello dimensionale rifletterebbe meglio la diversità dei sintomi e delle manifestazioni, favorendo un approccio più personalizzato e mirato.
Inoltre, la ridefinizione dell’ADHD come spettro potrebbe portare a una maggiore integrazione con altre condizioni neuropsichiatriche e a una revisione dei criteri diagnostici che tenga conto della variabilità individuale, migliorando così il supporto per chi ne è affetto.
Nello specifico:
- Modifica dei criteri diagnostici e maggiore accuratezza nella valutazione: attualmente, i manuali diagnostici come il DSM-5 e l’ICD-11 definiscono l’ADHD attraverso criteri specifici e distinti, con tre sottotipi principali: prevalentemente disattento, prevalentemente iperattivo-impulsivo e combinato. Se l’ADHD fosse inquadrato come uno spettro, questi sottotipi potrebbero essere sostituiti da una scala di gravità e da una descrizione più sfumata delle caratteristiche individuali. Questo permetterebbe di riconoscere meglio i casi atipici e quelli con sintomi subclinici, evitando diagnosi arbitrarie basate su soglie rigide e consentendo di valutare il disturbo in un continuum. Inoltre, la nuova classificazione potrebbe includere indicatori aggiuntivi come il funzionamento esecutivo, la regolazione emotiva e il livello di compromissione in diversi contesti di vita, fornendo un quadro più completo delle difficoltà vissute dall’individuo.
- Maggiore riconoscimento della variabilità individuale e riduzione del rischio di sottodiagnosi o sovradiagnosi: uno dei problemi dell’attuale approccio diagnostico è che molte persone con difficoltà legate all’attenzione e all’impulsività non soddisfano tutti i criteri per una diagnosi di ADHD, pur avendo difficoltà significative nella vita quotidiana. Se l’ADHD fosse considerato uno spettro, si potrebbe evitare di escludere questi individui dalla possibilità di ricevere un supporto adeguato. Al contrario, nei casi in cui la diagnosi venga assegnata con troppa leggerezza, un modello dimensionale potrebbe aiutare a distinguere meglio tra una reale compromissione funzionale e una semplice variazione del comportamento che non richiede un intervento clinico. Questo ridurrebbe sia la sottodiagnosi che la sovradiagnosi, consentendo un’identificazione più accurata delle persone che effettivamente necessitano di supporto.
- Miglioramento dell’accesso ai trattamenti e personalizzazione delle terapie: attualmente, il trattamento dell’ADHD è spesso standardizzato, con la prescrizione di farmaci stimolanti come opzione primaria. Tuttavia, l’ADHD non si manifesta allo stesso modo in tutti gli individui, e alcuni traggono maggiore beneficio da interventi comportamentali, terapie cognitive, supporto educativo o strategie di gestione ambientale. Se l’ADHD fosse riconosciuto come spettro, sarebbe più facile adottare un approccio terapeutico su misura, basato sulla specifica posizione dell’individuo all’interno dello spettro e sulle sue esigenze particolari. Inoltre, si potrebbe sviluppare una gamma più ampia di opzioni di trattamento per affrontare aspetti meno considerati del disturbo, come le difficoltà di regolazione emotiva o le problematiche sociali, che non sempre sono trattate adeguatamente con la terapia farmacologica.
- Maggiore integrazione con altri disturbi neuropsichiatrici e riconoscimento delle sovrapposizioni diagnostiche: un approccio a spettro renderebbe più evidente la continuità tra ADHD e altri disturbi neuropsichiatrici, come il disturbo dello spettro autistico (ASD), i disturbi dell’apprendimento, i disturbi d’ansia e i disturbi dell’umore. Attualmente, molti individui ricevono più diagnosi separate per condizioni che potrebbero essere meglio comprese come manifestazioni diverse di uno stesso continuum neurobiologico. Se l’ADHD fosse visto come parte di uno spettro più ampio, si potrebbe evitare la frammentazione diagnostica e promuovere un inquadramento clinico più integrato. Questo permetterebbe anche una maggiore flessibilità nella progettazione dei trattamenti, riducendo la rigidità delle categorie diagnostiche attuali e riconoscendo che molte persone hanno difficoltà che si estendono oltre i confini di un’unica etichetta clinica.
- Riduzione della stigmatizzazione e maggiore accettazione sociale: l’attuale concezione dell’ADHD come disturbo rigido e ben delimitato può contribuire alla stigmatizzazione di chi riceve questa diagnosi. Se invece l’ADHD fosse inquadrato come spettro, sarebbe più chiaro che non si tratta di una condizione “tutto o niente”, ma di un insieme di tratti che variano in intensità e che molte persone possiedono in misura minore o maggiore. Questo potrebbe ridurre lo stigma associato all’etichetta di “disturbo”, promuovendo una maggiore comprensione e accettazione della neurodiversità. Inoltre, il riconoscimento dell’ADHD come spettro potrebbe favorire un approccio più inclusivo nelle scuole e nei luoghi di lavoro, con adattamenti mirati a sostenere chi ha difficoltà, piuttosto che imporre un modello rigido di normalità.
- Maggiore precisione nella ricerca scientifica e nuove prospettive di studio: un modello dimensionale potrebbe rivoluzionare la ricerca sull’ADHD, consentendo studi più dettagliati sulle variazioni individuali e sui fattori che influenzano l’espressione del disturbo. Attualmente, la ricerca è spesso limitata dalla necessità di categorizzare i partecipanti in base a criteri diagnostici rigidi, escludendo molte persone che presentano caratteristiche ADHD in forma attenuata o atipica. Con un approccio a spettro, gli studi potrebbero analizzare meglio la continuità dei sintomi, identificare sottogruppi con profili neurobiologici distinti e sviluppare trattamenti più mirati. Inoltre, si potrebbero esplorare più approfonditamente le differenze di genere, considerando che l’ADHD si manifesta in modo diverso tra uomini e donne e che le donne spesso ricevono una diagnosi tardiva o errata a causa della presentazione meno tipicamente iperattiva del disturbo.
- Impatto sul sistema educativo e maggiore adattabilità nei percorsi scolastici: nel contesto scolastico, il riconoscimento dell’ADHD come spettro potrebbe portare a un cambiamento significativo nel modo in cui gli studenti con difficoltà di attenzione e autoregolazione vengono supportati. Attualmente, molte scuole operano secondo criteri rigidi per determinare chi ha diritto a servizi di supporto. Un modello a spettro potrebbe invece consentire un approccio più flessibile, in cui gli studenti ricevono aiuti in base alle loro specifiche esigenze piuttosto che a una diagnosi formale. Ciò potrebbe portare a una maggiore equità nell’accesso agli strumenti compensativi, agli adattamenti didattici e alle strategie di apprendimento personalizzate.
- Evoluzione della percezione medica e psicologica dell’ADHD: il passaggio a una visione a spettro dell’ADHD potrebbe portare a un cambiamento culturale nel modo in cui la condizione viene concepita all’interno della comunità medica e psicologica. Invece di considerare l’ADHD come una deviazione patologica da una norma, si potrebbe riconoscere che le caratteristiche associate al disturbo fanno parte della naturale variabilità della mente umana. Questo potrebbe stimolare un dibattito più ampio sulla neurodiversità e sul modo in cui le società strutturano le loro aspettative nei confronti dell’attenzione, della produttività e dell’autocontrollo.
Se l’ADHD fosse ufficialmente riconosciuto come spettro nei manuali diagnostici, ciò segnerebbe un cambiamento epocale nella comprensione, nella gestione e nella percezione del disturbo.
Questo nuovo approccio potrebbe portare a diagnosi più accurate, trattamenti più efficaci, una maggiore integrazione con altre condizioni neuropsichiatriche e una riduzione della stigmatizzazione, contribuendo a un futuro in cui l’ADHD sia visto non come una patologia rigida, ma come una parte della diversità cognitiva umana.

L’ADHD ti sta mettendo alla prova ogni giorno?
Un trattamento mirato può aiutarti a gestire meglio i sintomi dell’ADHD, migliorando la tua qualità della vita e restituendoti il controllo delle tue azioni.