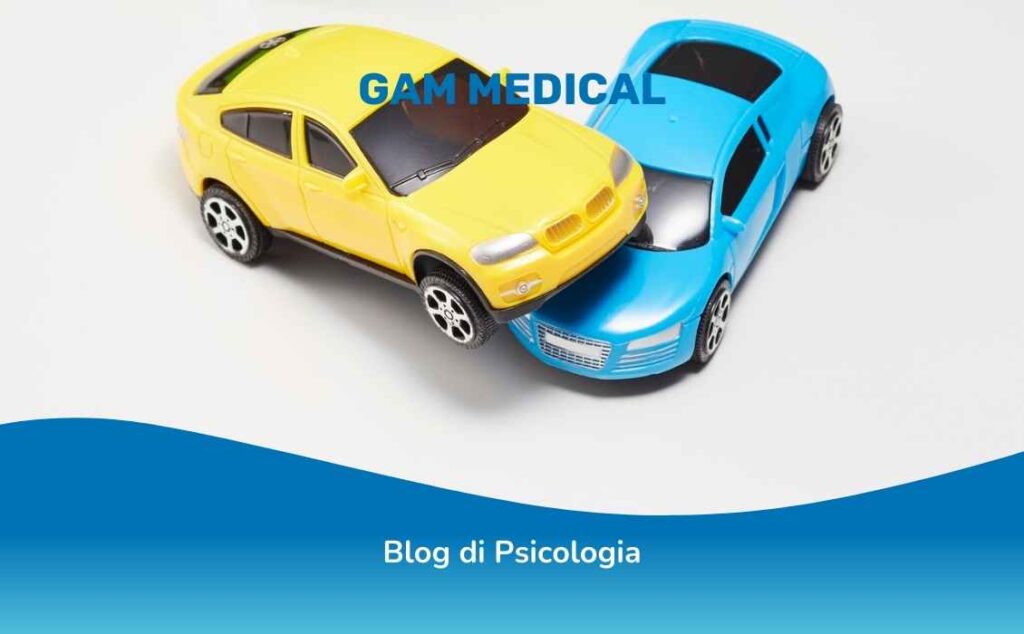Nella nostra pratica clinica lo vediamo tutti i giorni: sempre più persone si informano sull’ADHD attraverso TikTok. Alla domanda “cosa ti porta qui?”, in tanti ci dicono di aver avuto il sospetto di essere ADHD dopo aver visto dei video su TikTok.
La piattaforma, nata come spazio per intrattenimento e creatività, è ormai diventata quasi un motore di ricerca alternativo. Cerchi ispirazione per un outfit? C’è TikTok. Una ricetta veloce? C’è TikTok. Hai il sospetto di avere sintomi di ADHD? Anche lì, c’è TikTok.
Ma i contenuti che circolano su questa piattaforma riguardo all’ADHD sono davvero affidabili? Quanto sono basati su evidenze scientifiche, e quanto invece rischiano di essere fuorvianti? E soprattutto: quali implicazioni ha, per chi cerca risposte sulla propria salute mentale, l’informarsi su TikTok?

Il tuo punto di riferimento per l’ADHD
Se cerchi un aiuto concreto per affrontare l’ADHD, il nostro Centro Clinico è qui per te. Offriamo diagnosi accurate, trattamenti personalizzati e supporto continuo per aiutarti a vivere al meglio.
Il fenomeno “TikTok ADHD”
Basta aprire TikTok e digitare nella barra di ricerca “ADHD”, “sintomi ADHD” o “ADHD test” per ritrovarsi immersi in un flusso di contenuti che parlano di distrazione, iperfocus, procrastinazione, pensieri multipli, difficoltà a organizzarsi, e molto altro.
Da una parte, questo è un segnale positivo: le informazioni sono più accessibili e alla portata di tutti. Questo significa che la salute mentale non è più un tabù e che sempre più persone riconoscono in sé o negli altri dei pattern che meritano attenzione.
In molti casi, adulti che non si erano mai identificati nei modelli classici di ADHD (quello del bambino iperattivo, disattento, “monello” o “sognatore”) riescono finalmente a dare un nome a qualcosa che li accompagna da anni.
Molti adulti ADHD, uomini e donne, raccontano di essersi riconosciute proprio grazie a un video su TikTok: un contenuto che parlava di disorganizzazione cronica, iperfocalizzazione, o stanchezza mentale legata a stimoli eccessivi.
In questo senso, i social media hanno avuto un ruolo dirompente e in parte positivo: rendere visibile una condizione che per troppo tempo è stato pensato solo in termini infantili.
Dal punto di vista clinico, questo aumento di consapevolezza non è affatto trascurabile.
Le persone che si riconoscono in alcuni tratti descritti online spesso intraprendono un percorso di approfondimento: si informano, consultano un professionista, e in alcuni casi arrivano a una diagnosi formale.
In un mondo in cui l’accesso ai servizi di salute mentale è ancora disomogeneo e spesso ostacolato da costi, stigma o scarsa informazione, l’idea che un social possa “accendere una lampadina” è di per sé positiva.
La rete può dunque fungere da ponte: da un lato favorisce l’identificazione precoce dei disturbi, dall’altro permette di normalizzare la richiesta di aiuto.
È un meccanismo che abbiamo già osservato con altri temi di salute mentale, come l’ansia o la depressione. Ma nel caso dell’ADHD, questa dinamica si intreccia con un aspetto molto delicato: la tendenza all’autodiagnosi di ADHD.

Prenota un colloquio gratuito per l’ADHD
Pensi che l’ADHD limiti la tua vita? Un colloquio gratuito con un nostro psicologo può chiarire molti dubbi, così potrai decidere se iniziare un percorso di diagnosi o trattamento.
L’altro lato della medaglia: disinformazione sull’ADHD con TikTok
Il rischio dell’autodiagnosi non è nuovo, ma su TikTok assume una forma particolarmente potente.
Molti creator pubblicano video dal tono quasi diagnostico: elencano sintomi, fanno “test” veloci, o invitano l’utente a “verificare se si riconosce” in determinate descrizioni.
L’intento spesso è buono — divulgativo, empatico, a volte ironico — ma il risultato può essere fuorviante.
Succede che caratteristiche comuni a molte persone vengano descritte come sintomi ADHD, generando confusione.
Ad esempio: “Ti distrai facilmente?”, “Hai mille pensieri insieme?”, “Ti dimentichi le cose?”.
Sono esperienze umane universali, ma presentate come indicatori diagnostici diventano pericolose.
L’ADHD non è una semplice difficoltà di concentrazione o una tendenza a procrastinare: è un disturbo neuroevolutivo complesso, con sintomi specifici e criteri diagnostici precisi.
Uno dei punti più critici, in questo senso, è la confusione tra sintomi primari e caratteristiche secondarie.
I sintomi primari dell’ADHD, secondo i manuali diagnostici internazionali (DSM-5-TR, ICD-11), riguardano tre aree: disattenzione, iperattività e impulsività.
Le caratteristiche secondarie, invece, sono modi in cui questi sintomi si manifestano nella vita quotidiana, spesso influenzati dal contesto, dalla personalità o dalle strategie compensatorie.
Ad esempio:
- la procrastinazione può derivare dalla difficoltà di avviare compiti complessi (sintomo primario: disattenzione);
- la disorganizzazione cronica può essere una conseguenza delle difficoltà esecutive (sintomo secondario);
- la creatività e l’iperfocus, spesso esaltati sui social come “superpoteri dell’ADHD”, non sono sintomi, ma pattern comportamentali correlati.
Confondere i due piani — come accade in moltissimi video — rischia di banalizzare il disturbo o, al contrario, di patologizzare tratti normali della personalità.

Hai il sospetto che l’ADHD ti stia influenzando la vita?
Se credi che l’ADHD possa limitarti, un percorso diagnostico ti aiuterà a ottenere chiarezza e a capire come affrontarlo al meglio.
I contenuti sull’ADHD pubblicati su TikTok, sono veritieri o fuorvianti?
Uno studio pubblicato nel 2024 da Smita Verma e Suman Kumar Sinha ha analizzato proprio questo fenomeno.
Il lavoro, intitolato “How evidence-based is the ‘hashtag ADHD test’ (#adhdtest): A cross-sectional content analysis of TikTok videos on attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) screening”, ha valutato i 50 video più popolari su TikTok con l’hashtag #ADHDtest.
Gli autori hanno confrontato i contenuti di questi video con la scala clinica validata Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1), utilizzata per lo screening negli adulti.
I risultati sono stati netti: il 92% dei video è stato classificato come “fuorviante”, perché conteneva informazioni scorrette o incomplete sui sintomi dell’ADHD.
Solo una piccola parte dei video (l’8%) risultava “utile”, cioè coerente con almeno quattro delle sei domande presenti nel questionario ufficiale.
Ma la parte più interessante — e preoccupante — è che i video “utili” ricevevano pochissimo coinvolgimento: solo il 4% dei like, l’1% dei commenti e il 7% dei salvataggi totali.
Questo dato suggerisce che i contenuti accurati faticano a circolare, mentre quelli più emotivi o sensazionalistici vengono amplificati dall’algoritmo e raggiungono un pubblico molto più vasto.
Un meccanismo che alimenta la disinformazione e rafforza il rischio di autodiagnosi.
Perché TikTok può amplificare i contenuti fuorvianti
Il funzionamento stesso di TikTok spiega in parte questa distorsione.
L’algoritmo privilegia i contenuti che generano coinvolgimento — like, commenti, condivisioni — e questi spesso coincidono con video che semplificano o spettacolarizzano l’esperienza.
Un video che dice “Hai queste tre cose? Allora potresti avere l’ADHD” cattura l’attenzione, mentre uno che spiega la complessità diagnostica del disturbo probabilmente verrà ignorato.
C’è poi un aspetto psicologico più profondo: il bisogno di riconoscersi.
Molti utenti trovano conforto nel sapere che “non sono soli” nelle loro difficoltà quotidiane, e che esiste una possibile spiegazione neurologica al loro modo di funzionare.
In assenza di un contesto clinico adeguato, questa identificazione può però trasformarsi in un’autodiagnosi auto-confermante.

Pensi di essere ADHD?
Compila il test di autovalutazione! Ti darà un’indicazione sull’opportunità di approfondire con diagnosi e terapia. Bastano 3 minuti per avere il risultato.
Il ruolo dei professionisti della salute mentale: tra TikTok e Contesto Clinico
In questo scenario, i professionisti della salute mentale (psicologi, psichiatri, neuropsichiatri, psicoterapeuti) hanno una responsabilità importante: non demonizzare i social, ma imparare a dialogare attraverso essi.
Il fenomeno TikTok non va ignorato né banalizzato, perché rappresenta una fonte reale di informazione per milioni di persone.
La strategia vincente non è “contrastare TikTok”, ma occupare quello spazio con contenuti scientifici ma comprensibili, capaci di mantenere accuratezza e appeal comunicativo.
Un linguaggio clinico, accessibile ma rigoroso, può aiutare a colmare il divario tra informazione virale e conoscenza clinica.
Spiegare, ad esempio, la differenza tra sintomo e caratteristica secondaria, tra diagnosi di ADHD e autodiagnosi, tra ADHD e altri disturbi del neurosviluppo, è un modo per restituire complessità senza perdere chiarezza.
Molti professionisti della salute mentale lo stanno già facendo e tra quelli, anche noi sui nostri canali social.

L’ADHD ti sta mettendo alla prova ogni giorno?
Un trattamento mirato può aiutarti a gestire meglio i sintomi dell’ADHD, migliorando la tua qualità della vita e restituendoti il controllo delle tue azioni.