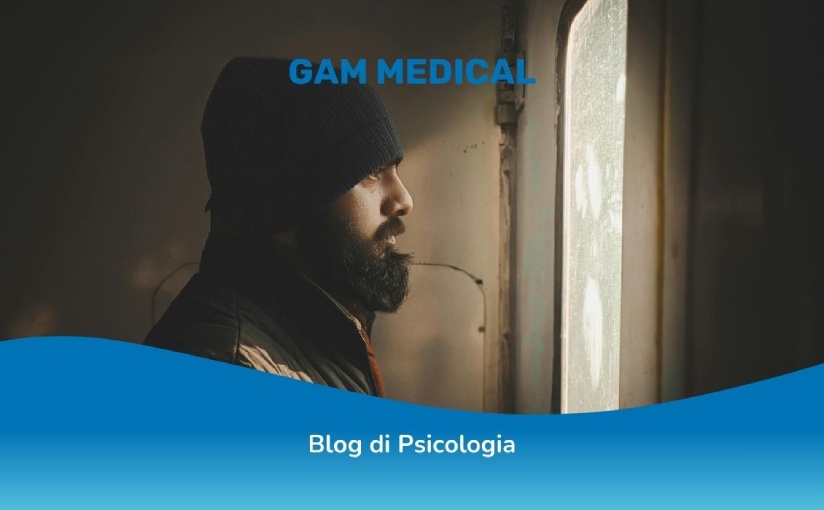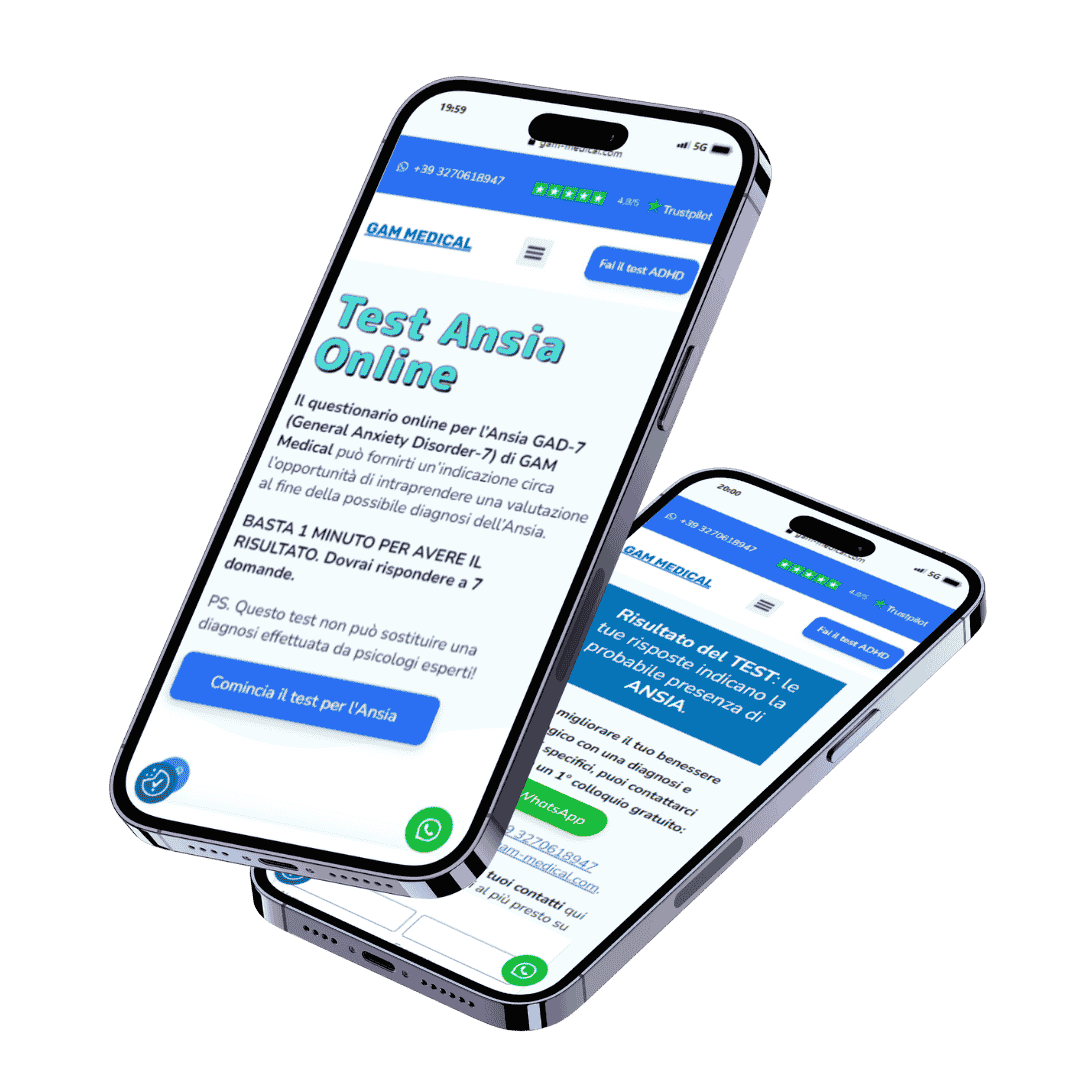Le persone con DOC sono praticamente incapaci di procrastinare.
In realtà è un po’ più complesso di così e c’è un interessante paradosso da considerare.
A prima vista, infatti, può sembrare che le persone DOC siano l’opposto dei procrastinatori: attente, precise, incapaci di rimandare ciò che ritengono urgente. E in parte è vero.
Ma la realtà è che chi soffre di DOC non riesce a procrastinare le proprie compulsioni — cioè non può rimandare la messa in atto del comportamento che “disinnesca” l’ansia — ma tende invece a procrastinare tutto il resto, accumulando ritardi, frustrazione e senso di fallimento.
Questo paradosso rappresenta uno dei cuori clinici del disturbo, e spiega molto del modo in cui il DOC condiziona la vita quotidiana, le relazioni e la percezione del tempo.
Il paradosso della procrastinazione nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo
La parola procrastinazione deriva dal latino pro crastinus, “per il domani”, e indica l’abitudine a rimandare a un momento futuro ciò che si potrebbe o si dovrebbe fare oggi.
È un meccanismo umano comune, spesso legato alla difficoltà di tollerare l’ansia, la noia o l’incertezza.
Nel caso del disturbo ossessivo-compulsivo, però, la procrastinazione assume una forma completamente diversa.
Chi soffre di DOC non riesce a procrastinare le azioni legate alla propria ossessione: deve agire subito, immediatamente, per ridurre la tensione interna.
Tuttavia, nello stesso tempo, tende a procrastinare tutte le altre attività della vita quotidiana, dal lavoro agli impegni personali, perché la mente è assorbita, catturata e monopolizzata dalle compulsioni.
Immaginiamo una persona con ossessioni di contaminazione.
Appena entra in contatto con un oggetto che percepisce come “sporco”, l’ansia esplode e la mente attiva una spia interna, come quella dell’olio della macchina: “devo lavarmi subito le mani”.
Non può rimandare quel gesto: la sensazione di sporcizia è insopportabile, e l’unico modo per calmarsi è mettere in atto la compulsione immediatamente.
In questo senso, il soggetto è l’antitesi del procrastinatore.
Ma nel frattempo, tutte le altre attività vengono rimandate: uscire, prepararsi, lavorare, rispondere a un messaggio. L’urgenza ossessiva occupa tutto lo spazio mentale e temporale.
La persona finisce così in una condizione paradossale: non riesce a procrastinare dove dovrebbe, ma procrastina dove non vorrebbe.
A livello clinico, questo fenomeno è legato a una bassa tolleranza alla frustrazione e a una scarsa capacità di differire la gratificazione o il sollievo.
L’ansia provocata dall’ossessione è talmente forte che l’unica via possibile, per il soggetto, è agire subito. Ma proprio questa urgenza diventa il motore del mantenimento del disturbo.
La sveglia mentale: come si concretizza l’esperienza ossessiva
Per comprendere meglio cosa accade nella mente di una persona con DOC, possiamo usare una metafora semplice ma efficace: la sveglia.
Quando arriva un pensiero ossessivo, è come se nella testa suonasse una sveglia improvvisa, fortissima, che non può essere ignorata.
È un suono acuto, insistente, che richiama tutta l’attenzione del soggetto. La differenza è che, nella mente ossessiva, quella sveglia non suona una sola volta, ma può ripetersi decine o centinaia di volte al giorno, anche per la stessa preoccupazione.
Proviamo a immaginare la scena: stiamo già svegli, ma la sveglia continua a suonare. Il suono è fastidioso, insistente, intollerabile. Cosa facciamo? La spegniamo. E per un momento, finalmente, c’è silenzio. Ma se quella sveglia riprende a suonare pochi minuti dopo, ci troviamo a ripetere lo stesso gesto, ancora e ancora.
Nel disturbo ossessivo-compulsivo, l’ossessione funziona proprio così. È un pensiero che suona nella testa, un allarme che segnala pericolo, errore, colpa o contaminazione. La compulsione è il gesto che “spegne la sveglia”: lavarsi, controllare, contare, ripetere una frase, verificare di non aver fatto danni.
Se la compulsione è rapida, il sollievo arriva subito. Ma se è lunga, ritualizzata o richiede tempo — come accade nella maggior parte dei casi — la persona finisce per accumulare ritardi e interferenze in ogni aspetto della vita quotidiana.
Ogni ciclo ossessivo-compulsivo, infatti, consuma tempo ed energia mentale. Quando l’ossessione ritorna frequentemente, anche a distanza di pochi minuti, il soggetto resta intrappolato in un meccanismo che impedisce la gestione normale del tempo.
La giornata si riempie di micro-rituali, verifiche e azioni ripetute. E alla fine, tutto il resto viene rimandato: appuntamenti, lavoro, relazioni, progetti personali.
Il nucleo del Disturbo Ossessivo-Compulsivo: l’intolleranza alla frustrazione
Il cuore del disturbo ossessivo-compulsivo non è solo l’ansia, ma la relazione che il soggetto ha con l’ansia.
Chi soffre di DOC presenta una intolleranza marcata alla frustrazione, all’incertezza e all’attesa. L’ossessione rappresenta un segnale di allarme: “qualcosa non va”, “potrei sbagliare”, “potrei contaminarmi”, “potrei fare del male a qualcuno”.
In una mente non ossessiva, questi pensieri vengono riconosciuti come irrazionali o transitori, e vengono lasciati andare. In una mente ossessiva, invece, ogni pensiero intrusivo viene preso come un segnale reale di pericolo o di colpa, e quindi deve essere “risolto” immediatamente.
La persona non riesce a tollerare l’idea di non intervenire.
L’attesa — anche di pochi minuti — diventa insopportabile. E così, la compulsione viene messa in atto per ottenere un sollievo immediato, anche se temporaneo.
A livello psicologico, questo meccanismo crea una forma di apprendimento patologico: ogni volta che il soggetto agisce per neutralizzare l’ossessione, prova un sollievo immediato. Questo sollievo diventa un rinforzo negativo, cioè una ricompensa che rafforza il comportamento.
In termini semplici, il cervello “impara” che l’unico modo per calmarsi è agire subito. E inizia a cercare quell’azione ogni volta che compare un pensiero ossessivo. Col tempo, la persona perde completamente la capacità di aspettare, di procrastinare, di lasciare che il disagio esista senza controllarlo.
Questo spiega perché le persone con DOC appaiono iper-controllanti e rigidamente organizzate su alcuni aspetti, ma allo stesso tempo disorganizzate e in ritardo su tutto il resto.
Il loro controllo non è realmente funzionale, ma difensivo: serve a evitare la frustrazione, non a gestire il tempo in modo efficace.
Le conseguenze: il circolo vizioso della procrastinazione ossessiva
Il risultato di questo meccanismo è un vero e proprio circolo vizioso, che mantiene e amplifica il disturbo.
- L’ossessione appare nella mente, generando ansia, paura o disgusto.
- La compulsione viene eseguita per ridurre l’ansia.
- Il sollievo arriva, ma dura poco.
- La mente collega la riduzione dell’ansia all’azione compulsiva, imparando che “funziona”.
- Il ciclo si ripete, ogni volta più rapidamente e più intensamente.
La persona, consapevole di quanto sia assurdo o irrazionale il proprio comportamento, tenta di resistere. Ma il tentativo di resistere all’ossessione aumenta l’ansia, e quindi la necessità di neutralizzarla.
Più prova a procrastinare la compulsione, più l’urgenza cresce, finché non cede.
E nel momento in cui cede, sperimenta sollievo e senso di colpa insieme. Sollievo perché l’ansia è diminuita, colpa perché “ha ceduto di nuovo”.
Questo rinforza ulteriormente la convinzione di essere incapace di resistere, e il ciclo si chiude su sé stesso.
Con il tempo, questo meccanismo produce conseguenze significative:
- Accumulo di ritardi cronici nelle attività quotidiane;
- Sensazione di inefficienza e fallimento personale;
- Riduzione del tempo dedicato a relazioni, lavoro, tempo libero;
- Aumento del senso di colpa e della sfiducia nelle proprie capacità.
In altre parole, il disturbo ossessivo-compulsivo, nel suo tentativo di controllare ogni cosa, finisce per controllare il tempo stesso, privando la persona della possibilità di scegliere quando agire e quando fermarsi.
La doppia trappola del DOC: l’urgenza e il rinforzo
Nel disturbo ossessivo-compulsivo, ogni ciclo ossessivo-compulsivo è alimentato da due trappole cognitive principali: l’urgenza e il rinforzo.
- L’urgenza è la sensazione immediata di dover fare qualcosa, di dover “risolvere” o “neutralizzare” un pensiero subito. È il motore dell’azione.
- Il rinforzo è il sollievo che segue la compulsione: breve, ma potentissimo. È ciò che insegna al cervello che “ha fatto bene ad agire”.
In questo modo, il DOC diventa una macchina perfetta di auto-mantenimento. Ogni volta che il soggetto agisce per ridurre l’ansia, conferma implicitamente l’idea che non può tollerarla, e che deve agire subito per stare bene.
Procrastinare, in questo contesto, significherebbe accettare l’incertezza, tollerare l’ansia, non fare nulla di fronte al disagio — cioè esattamente ciò che il disturbo impedisce.
Ecco perché la procrastinazione, per chi soffre di DOC, è allo stesso tempo impossibile e inevitabile: impossibile rispetto alla compulsione, inevitabile rispetto a tutto il resto.
Il disturbo ossessivo-compulsivo è il disturbo dell’urgenza e del controllo per definizione, in cui la mente cerca disperatamente di prevenire o neutralizzare un pericolo percepito come reale.
Ogni ossessione è una sveglia che suona troppo presto, e ogni compulsione è un tentativo di spegnerla. Ma a forza di spegnere quella sveglia, il tempo smette di scorrere in modo naturale.
ùSe soffri di sintomi ossessivi o compulsivi, non esitare a contattare la clinica specializzata in disturbo ossessivo-compulsivo GAM-Medical, centro dedicato alla diagnosi e al trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo, anche nelle sue forme più resistenti.