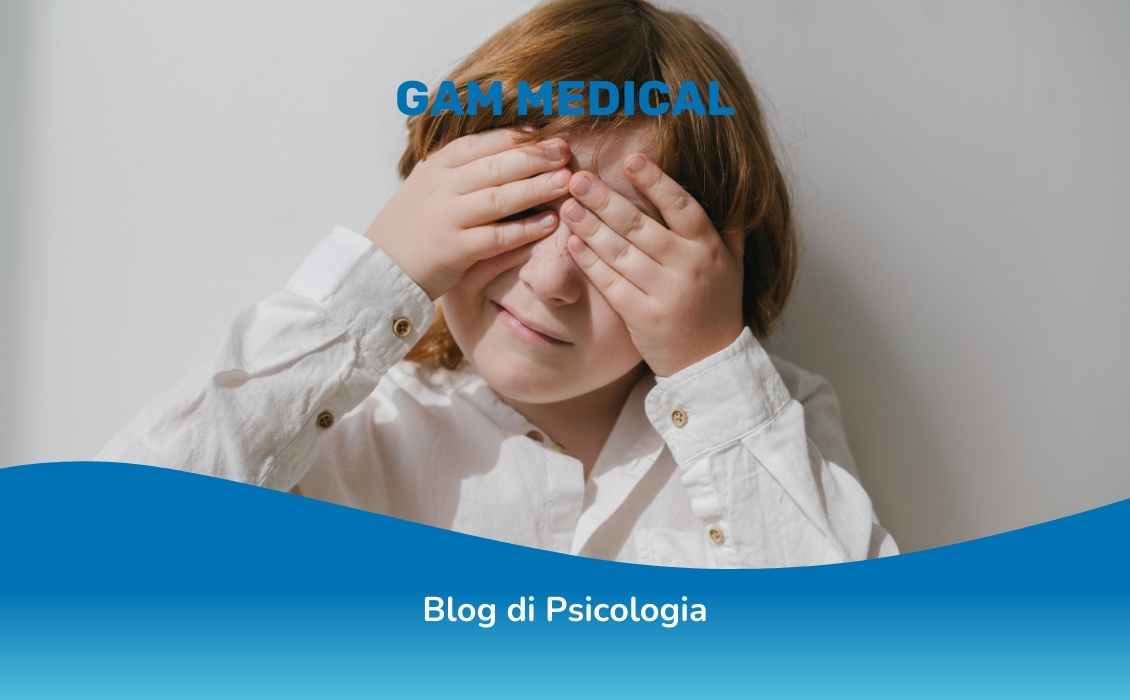L’autismo è un disturbo del neurosviluppo.
Questa affermazione, all’apparenza semplice e lineare, racchiude una profondità concettuale che merita di essere compresa con attenzione, soprattutto per evitare fraintendimenti che ancora oggi, nonostante il crescente interesse verso la neurodivergenza, permangono sia nel linguaggio comune che nel modo in cui molte persone si avvicinano a questo tema.
Dire che l’autismo è un disturbo del neurosviluppo significa, innanzitutto, riconoscere che esso affonda le sue radici nei primissimi processi di sviluppo del sistema nervoso.
Non si tratta, dunque, di una condizione acquisita lungo il percorso della vita, né di un evento traumatico o patologico che insorge improvvisamente come potrebbe accadere con una malattia o un’infezione.
L’autismo non si “contrae”, non si sviluppa come conseguenza di una cattiva educazione, di un errore ambientale, o di una colpa esterna. È una modalità diversa, innata e persistente, di funzionamento neurologico.
Una persona non diventa autistica: è autistica sin dall’origine del suo sviluppo, anche se questa neurodivergenza può diventare visibile o comprensibile solo in un secondo momento.
Questa distinzione è fondamentale: l’autismo è parte integrante del modo in cui una persona è costruita, nel senso più autentico e profondo del termine.
Non si tratta di qualcosa che “succede” a una persona, ma di qualcosa che la accompagna fin dalla strutturazione stessa delle sue reti neurali.
Questo non significa, tuttavia, che il disturbo dello spettro autistico sia sempre immediatamente riconoscibile alla nascita.
Anzi, nella grande maggioranza dei casi, non è affatto possibile determinare se un neonato sia autistico nei primissimi momenti di vita.
Nei primi mesi, quando le interazioni sociali sono ancora limitate, quando il linguaggio non è ancora emerso, quando le richieste ambientali sono minime, molti segnali distintivi dell’autismo possono non essere presenti o essere troppo sfumati per essere osservati chiaramente.
È con l’avanzare dello sviluppo, e in particolare quando iniziano a strutturarsi le funzioni sociali, comunicative e relazionali, che certi tratti tipici dello spettro autistico cominciano a emergere in modo più riconoscibile.
È in questa fase che iniziano a delinearsi differenze significative nei tempi e nei modi dell’acquisizione di determinate abilità: differenze che, se osservate con attenzione, non sono necessariamente segno di mancanza, ma piuttosto di un diverso stile di sviluppo, di un’altra traiettoria evolutiva.
Ci sono, inoltre, casi in cui l’autismo si manifesta dopo un primo periodo di sviluppo che, almeno in apparenza, sembra tipico; in questi casi si parla spesso di “autismo regressivo”, una forma che lascia particolarmente spaesati perché porta con sé l’esperienza concreta di un “prima” e di un “dopo”: una fase iniziale in cui alcune abilità sembrano presenti, funzionanti, adeguate, seguita da una fase in cui quelle stesse abilità sembrano venire meno, svanire, trasformarsi.
Questo fenomeno ha un impatto profondo sul modo in cui genitori, educatori e clinici si confrontano con il riconoscimento dell’autismo, perché mette in discussione l’idea che la neurodivergenza debba sempre essere visibile fin da subito.
Queste considerazioni ci portano inevitabilmente a introdurre il concetto di traiettoria di sviluppo.
Parlare di traiettorie di sviluppo significa riconoscere che la crescita umana non si muove lungo un unico binario lineare e uniforme, ma che esistono molteplici percorsi possibili, ciascuno con le sue caratteristiche, le sue modalità, le sue tempistiche.
Lo sviluppo tipico rappresenta soltanto uno dei tanti modi in cui il sistema nervoso può organizzarsi e rispondere alle sollecitazioni dell’ambiente.
Quando parliamo invece di sviluppo atipico, non stiamo parlando necessariamente di un deficit o di una patologia, ma di un funzionamento che si discosta dalle medie statistiche o dalle aspettative convenzionali, pur mantenendo al suo interno coerenza, intelligenza e struttura.
Nel caso dell’autismo, lo sviluppo atipico si configura come un cammino specifico, marcato da un diverso equilibrio tra le aree cognitive, emotive, sensoriali e relazionali.
Alcune competenze possono emergere prima o in modo più accentuato rispetto ad altre; alcune aree possono manifestare un funzionamento avanzato, mentre altre sembrano evolvere più lentamente o in modo irregolare.
Nelle prossime righe capiremo quali sono le caratteristiche dell’autismo regressivo e come riconoscere i “prima e dopo”.
Un supporto concreto per l’autismo
Il nostro Centro Clinico offre diagnosi, consulenze e percorsi personalizzati per supportare al meglio le persone autistiche e le loro famiglie. Scopri come possiamo aiutarti.
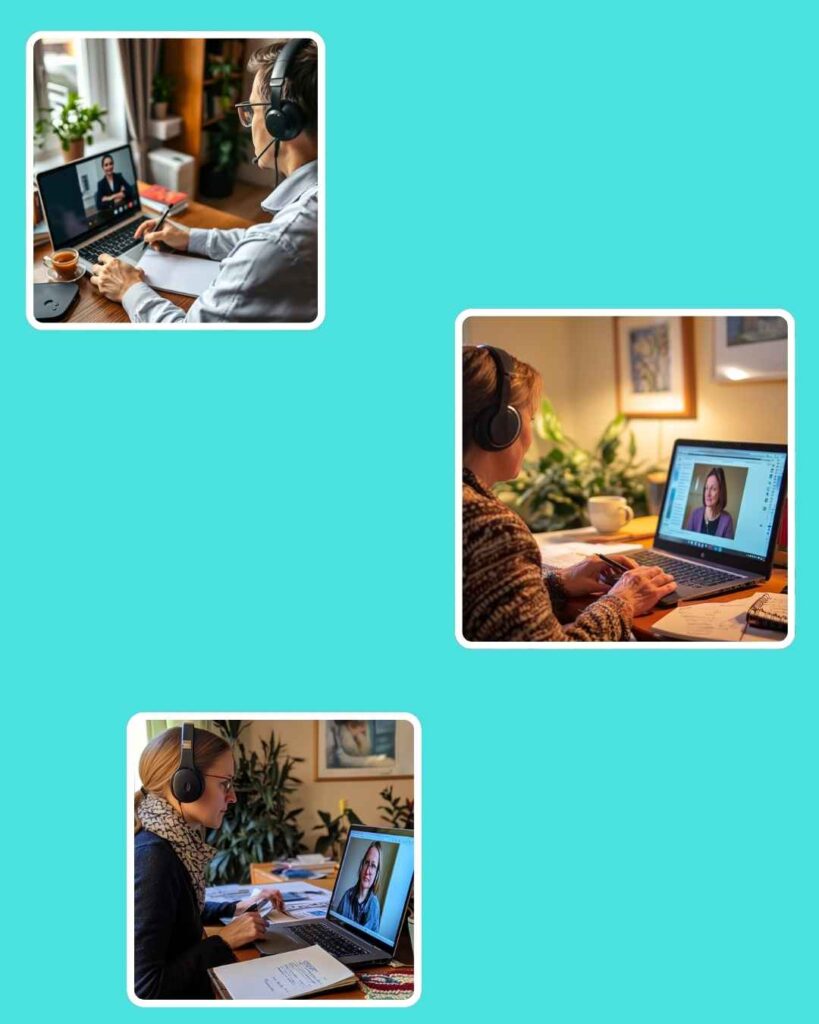
Prenota un colloquio gratuito per l’autismo
Pensi di rientrare nello spettro autistico? Un colloquio gratuito con un nostro psicologo può chiarire molti dubbi, così potrai decidere se iniziare un percorso di diagnosi o trattamento.
Pensi di essere una persona autistica?
Compila il test di autovalutazione! Ti darà un’indicazione sull’opportunità di approfondire con diagnosi e terapia. Bastano 5 minuti per avere il risultato.
Le Principali Manifestazioni dell’Autismo Regressivo: Cosa Cambia tra il “Prima” e il “Dopo”
L’autismo regressivo è una forma di manifestazione dello spettro autistico che suscita spesso domande, confusione, e talvolta un senso di spaesamento, in particolare nei genitori e nei caregiver.
A differenza delle forme in cui i segnali di neurodivergenza si manifestano fin dalle prime fasi dello sviluppo, l’autismo regressivo si presenta in modo apparentemente più contraddittorio, creando un effetto di discontinuità.
È caratterizzato, come già accennato, da un periodo iniziale in cui lo sviluppo del bambino sembra procedere lungo una traiettoria considerata “tipica”: il bambino acquisisce abilità relazionali, comunicative, motorie e cognitive in linea con le aspettative della sua età.
Questo passaggio avviene generalmente tra i 15 e i 30 mesi e può essere lento o repentino, sfumato o evidente, ma in ogni caso comporta una trasformazione significativa in una o più aree del funzionamento del bambino.
Le abilità precedentemente acquisite sembrano regredire, affievolirsi, a volte scomparire.
Le più riconoscibili e comuni riguardano:
- Regressione del linguaggio: una delle manifestazioni più frequenti e osservabili dell’autismo regressivo è la perdita, parziale o totale, delle abilità linguistiche precedentemente acquisite. Molti bambini che vanno incontro a una traiettoria regressiva iniziano a parlare, pronunciano le loro prime parole, talvolta combinano anche brevi frasi o mostrano una padronanza iniziale del linguaggio verbale, coerente con la loro età cronologica. Nel “prima”, il bambino può essere descritto come comunicativo, con un lessico funzionale, capace di rispondere alle domande, di chiamare per nome le figure familiari, di usare la parola come strumento per esprimere desideri o bisogni. Il “dopo”, invece, si caratterizza per un progressivo silenziarsi. Le parole si riducono, diventano meno frequenti, perdono funzione comunicativa, fino in alcuni casi a sparire del tutto. Anche le lallazioni e i vocalizzi possono attenuarsi, lasciando spazio a silenzi lunghi o a suoni non strutturati. Il linguaggio, che prima sembrava in crescita, si blocca o regredisce, generando un evidente segnale di cambiamento che porta spesso i genitori a chiedere aiuto o consulenza.
- Calo dell’interscambio sociale: un altro segno distintivo del cambiamento riguarda l’interazione sociale. Nel periodo precedente alla regressione, il bambino può apparire affettuoso, incline al contatto visivo, interessato a giocare con gli altri, rispondente al proprio nome, attento alle espressioni del volto degli adulti, sorridente e desideroso di condivisione. Può indicare oggetti, mostrare interesse per l’ambiente circostante, coinvolgere gli altri nelle sue attività, cercare il conforto dell’adulto o mostrare reazioni empatiche. Dopo la regressione, tutto questo può cambiare drasticamente. Il bambino sembra ritirarsi, perdere interesse per l’altro, interrompere il contatto oculare, non rispondere più al proprio nome, diventare più autoreferenziale. I genitori spesso riferiscono che “non ci guarda più negli occhi”, “sembra perso nei suoi pensieri”, “è come se non ci sentisse”, oppure “gioca solo e non cerca più nessuno”. Questa chiusura può avvenire in modo graduale o improvviso, ma rappresenta uno dei segni più evidenti di quel prima e dopo che contraddistingue l’autismo regressivo.
- Perdita del gioco simbolico o relazionale: il gioco è un indicatore fondamentale del neurosviluppo, e nelle traiettorie regressive dell’autismo può subire un’evoluzione inversa rispetto a quanto ci si aspetta. Nella fase precedente, molti bambini mostrano un inizio di gioco simbolico: fingono di far mangiare una bambola, imitano le azioni degli adulti, inventano brevi scenari con oggetti o pupazzi. Possono anche coinvolgere l’adulto o un pari in giochi di turnazione, indicare oggetti per condividerli, ridere durante attività condivise. Dopo la regressione, invece, questo tipo di gioco può sparire. I giochi diventano ripetitivi, solitari, meno vari. Spesso il bambino si concentra su dettagli degli oggetti (ruote che girano, luci che si accendono), mette in fila oggetti in modo rigido, oppure ripete azioni senza scopo apparente. Il piacere dell’interazione durante il gioco sembra svanire, lasciando spazio a modalità più stereotipate, autoreferenziali e meno flessibili.
- Aumento dei comportamenti ripetitivi o atipici: in molti casi, il “dopo” nella traiettoria regressiva si accompagna a un’intensificazione o comparsa di comportamenti ripetitivi, movimenti stereotipati, rituali rigidi o interessi ristretti. Tali comportamenti possono non essere presenti nella fase iniziale oppure essere talmente lievi da passare inosservati. Dopo la regressione, invece, possono diventare più evidenti: il bambino può iniziare a dondolarsi, agitare le mani, correre in cerchio, fissare oggetti per lunghi periodi, sviluppare interessi assorbenti e inusuali. A questo si aggiungono, talvolta, resistenze marcate al cambiamento, difficoltà con la transizione tra un’attività e l’altra, o un attaccamento rigido a routine specifiche. Questi elementi, che nel “prima” non sembravano costituire un aspetto preponderante del comportamento, diventano centrali nel “dopo”, suggerendo un cambiamento significativo nella modalità di regolazione e di interazione con l’ambiente.
- Regressione delle autonomie apprese: alcuni bambini che attraversano una fase regressiva mostrano una perdita di abilità già acquisite anche in termini di autonomie personali. Azioni come mangiare con le posate, dormire con regolarità, usare il vasino o comunicare disagi in modo funzionale possono regredire improvvisamente. Prima della regressione, il bambino può aver mostrato buoni progressi in queste aree, manifestando comportamenti adeguati alla sua età. Dopo, queste stesse abilità possono svanire o diventare più faticose da mantenere. Spesso, questo viene attribuito inizialmente a fasi passeggeri di “regressione fisiologica”, ma quando il cambiamento si consolida e si accompagna ad altri segnali, emerge il quadro più ampio della traiettoria autistica.
L’autismo regressivo, con la sua dinamica di “prima e dopo”, rappresenta una delle modalità con cui la neurodivergenza può emergere e diventare visibile.
Questo approfondimento sull’autismo regressivo è stato pensato con una duplice intenzione, rivolta a due gruppi di persone che, per motivi diversi, si trovano a confrontarsi con la complessità del “prima e dopo” nello sviluppo autistico.
Da un lato, si rivolge agli adulti autistici, in particolare a coloro che hanno ricevuto una diagnosi di autismo in età adulta, e che si trovano ora a ripercorrere la propria storia personale alla luce di questa nuova consapevolezza.
Poiché l’autismo, per essere diagnosticato, richiede che i sintomi dell’autismo siano stati presenti fin dall’infanzia, può accadere che questi adulti si imbattano in narrazioni familiari che sembrano contraddire questa continuità: racconti di un’infanzia “normale”, di uno sviluppo apparentemente tipico, di abilità che si sarebbero perse col tempo.
Comprendere il fenomeno dell’autismo regressivo può offrire una chiave di lettura preziosa per integrare questi ricordi frammentati, restituendo senso a quella sensazione diffusa di “qualcosa che è cambiato” e aiutando a riconoscere che l’autismo può essersi manifestato in modo meno lineare, più sfumato, ma non per questo meno autentico o legittimo.
Dall’altro lato, questo testo è pensato per i genitori di bambini recentemente diagnosticati, oppure che stanno osservando nei loro figli una regressione dello sviluppo, a volte improvvisa, a volte graduale, spesso difficile da comprendere o da collocare.
Offrire strumenti di comprensione su cosa sia davvero l’autismo regressivo significa offrire uno spazio di accoglienza, di validazione e di sostegno emotivo per affrontare un’esperienza complessa e a tratti dolorosa, con maggiore lucidità e meno solitudine.
In entrambi i casi, la conoscenza può diventare uno strumento di riconnessione: con sé stessi, con la propria storia, con i propri figli, e con un modo diverso – ma altrettanto valido – di crescere, sentire e stare al mondo.
Senti che le difficoltà sociali ti isolano?
Se pensi di essere una persona AUTISTICA e hai difficoltà nella comunicazione e nelle interazioni sociali, una diagnosi può offrirti la comprensione necessaria per affrontare le tue sfide quotidiane. Vuoi avere più informazioni?
Ti senti bloccato nelle relazioni e nella comunicazione?
Con un percorso terapeutico adatto, puoi trovare strategie per migliorare le tue interazioni sociali e sentirti più a tuo agio nel mondo.